"Non siamo cavalli. Siamo esseri umani. Gli esseri umani sono…"
Questa frase spezzata e incompleta, pronunciata da Gi-hun Seong come ultima battuta nel toccante finale della terza e ultima stagione di Squid Game, ha sorpreso e spiazzato milioni di spettatori, lasciandoli a riflettere sul vero significato che essa poteva avere. Perché non ha mai terminato quelle parole? Cosa voleva davvero comunicare? Quanto del vero significato della serie si cela dietro quelle parole?

Dall’esplosione del fenomeno mondiale con la prima stagione e l’intensa prosecuzione nella seconda, Squid Game si è sempre concentrata su un’unica grande questione: fino a che punto l’essere umano può perdere la propria umanità di fronte alla disperazione e al desiderio di sopravvivere, e quanto la propria avidità possa spingerlo a rinnegare quelli che sembrerebbero essere i più basilari aspetti della civiltà.
Nella seconda stagione (QUI la nostra recensione), abbiamo visto Gi-hun diventare un rivoluzionario, un uomo che sfida l’intero sistema criminale dietro il gioco mortale, pronto a tutto per smantellarlo. Ora, nell’atto conclusivo della trilogia, la posta in gioco si fa ancora più alta, e la brutalità, la disumanizzazione e il cinismo arrivano a livelli estremi.
Nel terzo capitolo, la rivoluzione fallisce e i sopravvissuti – sessanta partecipanti – riprendono il loro infernale percorso infernale verso un premio sempre più cospicuo ma anche sanguinoso, con una violenza costante e sempre crescente. I giochi sono molto più brutali, creando ancora di più nello spettatore quel disagio creato dal forte contrasto di essere basati su semplicissimi passatempi dell’infanzia come nascondino, il salto della corda e il gioco della torre.

Gi-hun, quasi muto per il trauma della battaglia persa, deve affrontare una sfida che trascende la competizione in atto: salvare la neonata cui è toccato lo sfortunato fato di nascere proprio durante i giochi e che per capriccio (dei VIP) e vile calcolo del Front Man, diventa parte attiva divenendo alla fine, per ironia del destino, l’ultimo “avversario” rimasto in gara.
Eppure lo stesso Front Man, rivelatosi essere In-ho, il fratello del poliziotto sacrificatosi nelle stagioni precedenti, lo aveva invitato a scegliere la via più semplice: uccidere gli altri e tenere il montepremi (oltre che salvare la propria pelle e quella della neonata). Ma Gi-hun non è disposto a rinunciare alla sua umanità e alla fine decide di sacrificarsi per salvare la neonata, un gesto che ribalta la crudele logica del gioco.
La metafora dei concorrenti come “cavalli da corsa” per i VIP, gli spettatori benestanti che scommettono sulla loro vita, è un filo rosso che attraversa tutte le stagioni. Gi-hun stesso, giocatore d’azzardo alle corse, si rende conto di essere diventato lui stesso un cavallo, un oggetto da sfruttare e manipolare. Ed ecco che la sua frase finale unisce come in un filo rosso tutta la serie come tutte le persone morte nel tentativo di ergersi da un futuro già scritto, e vuole essere una denuncia e un appello: «Non siamo cavalli, siamo esseri umani». Ma cosa significa davvero essere umani, quando intorno a te vedi che anche le azioni più brutali sembrano inevitabili?

Il creatore Dong-hyuk Hwang ha spiegato che la frase è rimasta incompleta proprio perché l’umanità non può essere racchiusa in una definizione semplice. Sono le azioni di Gi-hun, soprattutto il sacrificio finale, a parlare, lasciando il segno più delle parole: un invito a non perdere la speranza e a cercare di costruire un mondo migliore, anche quando tutto sembra perduto. Anche se questo significa apparentemente perdere tutto!
Rispetto alla seconda stagione, la terza perde parte della suspense e dell’effetto sorpresa, ma guadagna in intensità drammatica. La violenza si fa più spietata, la satira sociale si attenua, e il gioco si trasforma definitivamente in un campo di battaglia dominato da tradimenti e disperazione. Alcuni nuovi personaggi, come l’ex agente nordcoreano Kang No-eul, riescono a portare sullo schermo momenti di umanità e complessità che nella seconda stagione erano rimasti in secondo piano. Altri, invece, risultano sottoutilizzati dalla sceneggiatura e liquidati troppo in fretta, soprattutto nel modo in cui vengono fatti uscire di scena.
Nonostante la durata generosa degli episodi – che spesso sfiora l’ora – il tempo per sviluppare meglio certe dinamiche c’era tutto. Eppure, in diversi momenti la narrazione rallenta e rischia di far perdere tensione, con lo spettatore che finisce per contare i minuti in attesa del prossimo gioco.
Un esempio lampante di quanto detto è rappresentato dalle votazioni per decidere se proseguire o meno nei giochi — un meccanismo democratico imposto ai partecipanti — che finiscono per apparire come una pantomima inutile, sottraendo tempo prezioso alle sfide stesse, rendendo la narrazione più dispersiva rispetto all’impatto concentrato e diretto della prima stagione.
Tuttavia, tutto viene riscattato da un finale di sacrificio ben costruito, che rompe con le regole fin troppo buoniste tipiche di molte serie streaming contemporanee. Lo fa però fino a un certo punto, perché Squid Game ormai è un marchio consolidato che fa visualizzazioni e guadagni.
La stagione finale ha totalizzato la impressionante cifra di 60,1 milioni di visualizzazioni in appena 72 ore, raggiungendo il primo posto tra le serie più viste in ognuno dei 93 Paesi in cui il servizio è disponibile. Capirete bene che un tale successo non può certo concludersi qui.

Non sorprende quindi più di tanto (anche se non lascia indifferenti) la presenza di Cate Blanchett nell’ultima scena: la celebre attrice compare come reclutatrice di una versione americana del gioco, suggerendo un possibile spin-off made in USA, probabilmente sotto la direzione di David Fincher. È un chiaro segnale che il fenomeno Squid Game è destinato a espandersi ulteriormente anche se il suo creatore
Hwang Dong-hyuk nega di aver creato questo finale pensando a un continuo.
Pro
- Messaggio profondo e significativo
- Finale toccante e simbolico
Contro
- Alcuni nuovi personaggi sono poco sviluppati e la loro uscita di scena appare frettolosa e poco soddisfacente
- La brutalità è aumentata, ma la componente di critica sociale si è affievolita, spostando l’attenzione più sul dramma e il thriller
- Perdita del "sense of wonder"










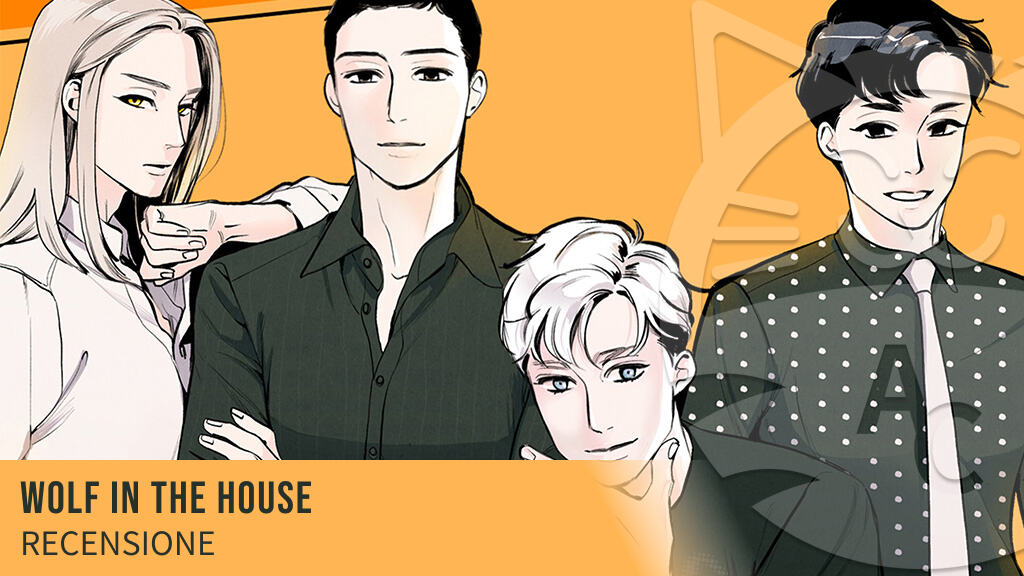




È la cosa più prevedibile della serie, io lo avevo pure già detto ad alcuni miei conoscenti come sarebbe finito un mese fa scommettendo con loro e ci ho preso.
Il finale è deludente e praticamente non risolve nulla della macro trama. Chiaramente Netflix si tiene porte aperte per eventuali sequel e spin-off ma ormai la serie ha già perso il suo smalto.
Ma infatti, il finale è scontato fin dal momento in cui compare il bambino.
È vero, Squid Game 3 tenta di chiudere il cerchio con un messaggio sull’umanità, ma secondo me lo fa in modo fin troppo prevedibile. Il sacrificio finale di Gi-hun sembra più un atto dovuto che un vero colpo di scena. È costruito per farci emozionare, ma senza la profondità o l’imprevedibilità che ha reso grande la prima stagione.
La scena della bambina, il dialogo “non siamo cavalli”... tutto sembra progettato per colpire lo spettatore nel cuore, ma non nella mente. E Squid Game, per me, funzionava proprio quando riusciva a far entrambe le cose: emozionare e spaventare con una critica sociale dura e cinica. Qui invece, sembra che la critica sociale venga messa da parte in favore del melodramma.
L’impressione che ho avuto è che la serie volesse “piacere” a tutti i costi, invece che rischiare come aveva fatto in passato. Un finale che chiude tutto, sì, ma in modo quasi scolastico. E in una serie che parlava di imprevedibilità, questo stona.
Quindi no, per me non è un finale da ricordare, ma una chiusura che gioca sul sicuro. E in un gioco dove il rischio era tutto… è un peccato.
Poi va beh, il poliziotto che non capisce una sega stile dora l'esploratrice mi ha fatto molto ridere.
Che dire? Mi è piaciuta nel complesso ma ho preferito la prima stagione.
Peccato per i personaggi secondari poco approfonditi e per i VIP totalmente insignificanti nella storia.
I giochi sono uno dei pochi aspetti positivi. (tranne il 2° quelli della seconda e terza stagione sono migliorati). Come ha scritto qualcuno era un finale prevedibile appena ha fatto comparsa 222.
Lascia amarezza perchè potevano sviluppare molto meglio. Poca tensione palpabile.
Insomma, tecnicamente impeccabile e tematicamente spietata, anche se è anche vero che più si va avanti, più sembra anche compiacersi del proprio sadismo (come molte opere coreane del resto).
Per me questa stagione soprattutto se FINALE, doveva del tutto chiudere ogni punto interrogativo, magari anche far capire com'è nato il gioco, o il passato di qualche importante personaggio, o qualcosa di relativo e importante, ma invece nonostante le 2 stagioni (collegate) per me si è davvero perso tutto per aggiungere cose inutili.
Il detective, ci mette 2 stagioni per trovare l'isola, la trova mentre sta per esplodere tutto, e chiede al fratello "Perchè l'hai fatto?"
Cosa di un inutilità e che non risolvere assolutamente nulla, per me.
Gi-Hun che in questa stagione perde del tutto la sua parte Eren, che vuole salvare tutti e fermare i giochi, anzi commette pure un omicidio forzato (nel gioco del nascondino) che boh... non credo avrebbe risolto qualcosa, i giochi sono bellini niente da dire, e anche la parte del soldato 11 è carina, ma onestamente a cosa è servita? Pensavo fosse più un modo per esplorare l'altro lato, ma infine si è rivelata solo come una storia personale che, okay ci sta, ma che non ha il senso di esistere visto che stai concludendo la serie.
Poi boh, bastava davvero così poco per chiudere i giochi? "La guardia costiera sta arrivando!"
Dai registri dello scantinato, avranno fatto chissà quante edizioni, eppure boh, anche questa mi sembra una conclusione forzata.
Che poi non si è capito se appunto, è stato fermato lo Squid Game koreano, o se c'è ne sono altri, hanno mostrato il Cameo Americano, ma solo per fare i fighi, e anche se parlano di un non seguito, secondo me con un po di soldi in mano cambierebbero facilmente l'idea, a questo punto era meglio mostrare una scena, dove si vedevano più "Squid Game" in giro per il mondo, così da far pensare che in ogni caso "E' stato tutto inutile".
Ah, ovviamente il sacrificio di Gi-hun super prevedibile, e anche stupido, visto che bastava sforzarsi di premere il bottone rosso prima di uccidere l'altro tizio, invece no, finale "da strappalacrime" anche se scontatissimo.
In ogni caso, la serie non è brutta, ma se davvero questa è l'ultima volta che sentiremo parlare di SG, allora direi che è stata una brutta chiusura.
PS: solo a me ha fatto strano vedere bambini e cani in CG? XD
Senza contare che
Comunque non capisco chi si lamenta che non era uguale alla prima; una copia 1:1 che avrebbe aggiunto? Piuttosto ha reso deboli le side stories che avrebbero potuto dare una svolta netta o chiudere in bellezza. La voglia di continuare a specularci è ciò che ha deluso di questa seconda parte di seconda serie, con l'investigatore fratello del Front Man con la squadra di fessi speciali che alla fine ha salvato solo una persona (pure ignorato ai fini delle indagini sullo Squid Game) e solo grazie al soldato 11, anche lei tanti sforzi per una piccola soddisfazione e una rivelazione appiccicata per spin-off, come anche il cameo alla fine.
La scelta di Gi-Hun spiazza? No, quando è apparsa la bambina si era capito che il nostro protagonista avrebbe cercato di proteggerla fino alla fine. Prevedibile? Sì e no: se fosse rimasto sulla idea iniziale di far vincere sia Gi-Hun Seong che la bambina sarebbe stato meno banale? Se la squadra fosse arrivata integra e avesse salvato più gente beccando magari qualche VIP bastardo sarebbe piaciuta di più a un pubblico solleticato da cinismo e negatività?
Credo che quanto fatto abbia impattato su Front Man, che col suo gesto verso figlia e bambina, penso abbia lasciato dietro anche un indizio per chi vuol indagare sugli Squid Game. È più netta la critica alla "scelta democratica" di essere crudeli (non a caso).
Ma questo è l'aspetto per me più inquietante di molte produzioni degli ultimi decenni: prima ti rendono figa e abituano la crudeltà in fiction, poi al genocidio a Gaza, tipo.
Qualcuno voleva veramente vedere Gi-Hun passare al lato oscuro.
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.