Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle recensioni su anime e manga, realizzate degli utenti di AnimeClick.it.
Se volete farne parte anche voi... rimboccatevi le maniche e recensite!
Ricordiamo che questa rubrica non vuole essere un modo per giudicare in maniera perentoria i titoli in esame, ma un semplice contesto in cui proporre delle analisi che forniscano, indipendentemente dal loro voto finale, spunti interessanti per la nascita di discussioni, si auspica, costruttive per l'utenza.
Per saperne di più continuate a leggere.
Se volete farne parte anche voi... rimboccatevi le maniche e recensite!
Ricordiamo che questa rubrica non vuole essere un modo per giudicare in maniera perentoria i titoli in esame, ma un semplice contesto in cui proporre delle analisi che forniscano, indipendentemente dal loro voto finale, spunti interessanti per la nascita di discussioni, si auspica, costruttive per l'utenza.
Per saperne di più continuate a leggere.
Fan X
-
“La corazzata spaziale Yamato” è un iconico anime del 1974. Si tratta di uno dei pezzi di animazione giapponese più celebri ed emblematici, e non a caso. Questo cartone animato non solo è importante nell’universo dell’animazione giapponese, ma si fa interprete dell’epoca in cui è stato prodotto.
Fermandoci alla prima serie, l’anime non è molto lungo: dura ventisei episodi e la trama è molto lineare. L’asse portante della storia è il difficile viaggio della nave spaziale Yamato a Iscandar: in questo lontano pianeta, i protagonisti devono recuperare un purificatore che permetterà di risanare la Terra. La Terra, infatti, è stata ripetutamente bombardata da missili atomici da una razza sconosciuta di alieni, i Gamilonesi.
Ogni episodio rappresenta una tappa di questo viaggio, osteggiato apertamente dai Gamilonesi; in ogni episodio, i protagonisti rischiano di fallire la missione.
Benché la trama non sia originalissima, l’anime sa avvincere grazie alla grande carica emotiva che esercita sullo spettatore. Senza essere pretenziosi, i primi episodi sanno rappresentare la condizione della Terra in modo coinvolgente, facendo partecipare lo spettatore alla tristezza dei protagonisti. È per questo che ogni pericolo corso dagli eroi ti fa stare con il fiato sospeso: l’anime fa un grande lavoro a farti affezionare alla missione della Yamato.
Avevo accennato come “La corazzata spaziale Yamato” si faccia interprete della sua epoca. Ed è vero: l’anime è stato prodotto nel secondo Dopoguerra, e in tale periodo va contestualizzato. Molti sono i riferimenti alla Seconda Guerra Mondiale, e alla sofferenza che ha portato in Giappone: la Yamato stessa è identificabile con una nave da guerra usata dai Giapponesi contro gli Americani nel secondo conflitto. I missili atomici dei Gamilonesi ricordano moltissimo la bomba atomica esplosa a Hiroshima e Nagasaki; frequenti sono, nell’anime, immagini di cataclismi naturali, dall’inizio alla fine. Alcuni di questi, poi, sono veramente impressionanti. Con i mezzi dell’epoca, l’anime riesce a farti sentire tutto l’impatto emotivo di quelle catastrofi. Uno dei personaggi principali, Kodai, ha in particolare un lungo flashback in cui ricorda quei tragici eventi, con immagini terribili e strazianti.
Tuttavia, l’anime non va interpretato come una semplice allegoria del secondo conflitto mondiale. I Gamilonesi non si identificano, negli intenti, con gli Americani: nel corso dell’anime, lo spettatore impara a conoscere anche la loro tragica situazione. Non c’è un sentimento di odio verso il nemico, nella serie. O meglio, c’è, ma per una buona prima parte; successivamente, questo senso di odio viene superato, e i protagonisti assumono un atteggiamento diverso nei confronti della propria missione e dell’esistenza.
In particolare, il tema su cui si fonda “La corazzata spaziale Yamato” è la speranza. Con la loro missione, i giovani protagonisti si fanno simbolo della speranza in un futuro migliore. L’unico protagonista anziano è il capitano Okita: un uomo che ha sofferto molto a causa della guerra e che, con la sua esperienza e la sua saggezza, accompagna la missione della sua giovane ciurma, sia dal punto di vista materiale sia spirituale. Come i ragazzi sono il simbolo della speranza nel futuro, così Okita è simbolo del passato doloroso che si cela dietro a quella speranza. Questo è il messaggio della serie: che la speranza non è un sentimento del tutto positivo. Ogni speranza, infatti, presuppone un dolore. Il finale della serie ci insegna che questo dolore non andrà dimenticato, ma si può e si deve superare: a un certo punto, bisogna abbracciare il futuro.
E proprio con questa tematica l’anime si fa interprete della sua epoca. Dopo quello che era successo una trentina di anni prima, è normale che nel Giappone degli anni ’70 si sperasse in un futuro migliore. Una generazione, la più anziana, aveva conosciuto gli orrori della guerra e ne serbava il triste ricordo. Le generazioni più giovani, invece, dovevano farsi promotrici del cambiamento, del riscatto del Paese.
Poi, per carità, l’anime non è assolutamente perfetto. Benché i personaggi, per esempio, mi siano piaciuti, a volte si comportano in modo strano, addirittura inspiegabile per gli standard di oggi. È anche vero che l’anime è stato prodotto molti anni fa, in un contesto culturale diverso, e in un periodo in cui i prodotti di intrattenimento non erano così sorvegliati come oggi.
Inoltre, molto spesso il modo in cui i protagonisti si tirano fuori dal pericolo è poco credibile. Ci sono anche buchi di trama non di scarso rilievo. Non mi è piaciuto, poi, il character design, che trovo decisamente superato. Infine, nonostante adori il finale della serie, ho trovato alcune soluzioni molto discutibili.
Nonostante tutto, però, “La Corazzata Spaziale Yamato” rimane nel podio dei miei anime preferiti. Per me, è un esempio di come una storia non debba per forza essere impeccabile, per essere bella. I suoi difetti non impediscono alla serie di comunicare il suo messaggio in modo straordinariamente efficace, emozionando lo spettatore. Penso che proprio questo, infatti, sia lo scopo di ogni storia: trasmettere messaggi universali attraverso l’emozione.
A caricare l’anime di emozione contribuisce anche la colonna sonora, molto tradizionale e orchestrale. I pezzi non sono tanti, ma la loro ripetitività calza bene con la natura episodica dell’anime. Ciascuno di questi pezzi sa emozionare in modo diverso: alcuni sono incalzanti e avventurosi, altri misteriosi e pacati. Infine, ci sono pezzi di una tristezza unica, che colorano le scene di un’atmosfera dolorosa. La sigla d’apertura è molto iconica e concisa, è mi è piaciuta molto; un po’ meno la sigla di chiusura, che ha un sound un po’ sporco e datato, anche se riesce a essere suggestiva.
Per chiarire, comunque, io ho recuperato la versione giapponese sottotitolata in inglese. Mi ero resa conto, cominciando la serie in italiano, che c’erano troppe modifiche e censure. Già il titolo dell’anime è mutato in “Star Blazers”, titolo che elimina la connotazione squisitamente giapponese dell’opera. Cambia, di conseguenza, anche il nome della nave spaziale: non più Yamato, ma Argo. Cambiano i nomi dei personaggi, che vengono americanizzati: il capitano Okita è il capitano Avatar, Kodai diventa Derek, e via dicendo. Inoltre, vengono rimosse molte scene ritenute inappropriate, e molti riferimenti alla Seconda Guerra Mondiale. È per questo che ho scelto, alla fine, di vedere l’originale: volevo vedere il prodotto così com’era pensato, anche con i suoi elementi più spigolosi. Anche perché, oggi come oggi, abituati come siamo a prodotti sorvegliati, vedere in un anime riferimenti ad avvenimenti storici è una cosa sorprendente.
Fermandoci alla prima serie, l’anime non è molto lungo: dura ventisei episodi e la trama è molto lineare. L’asse portante della storia è il difficile viaggio della nave spaziale Yamato a Iscandar: in questo lontano pianeta, i protagonisti devono recuperare un purificatore che permetterà di risanare la Terra. La Terra, infatti, è stata ripetutamente bombardata da missili atomici da una razza sconosciuta di alieni, i Gamilonesi.
Ogni episodio rappresenta una tappa di questo viaggio, osteggiato apertamente dai Gamilonesi; in ogni episodio, i protagonisti rischiano di fallire la missione.
Benché la trama non sia originalissima, l’anime sa avvincere grazie alla grande carica emotiva che esercita sullo spettatore. Senza essere pretenziosi, i primi episodi sanno rappresentare la condizione della Terra in modo coinvolgente, facendo partecipare lo spettatore alla tristezza dei protagonisti. È per questo che ogni pericolo corso dagli eroi ti fa stare con il fiato sospeso: l’anime fa un grande lavoro a farti affezionare alla missione della Yamato.
Avevo accennato come “La corazzata spaziale Yamato” si faccia interprete della sua epoca. Ed è vero: l’anime è stato prodotto nel secondo Dopoguerra, e in tale periodo va contestualizzato. Molti sono i riferimenti alla Seconda Guerra Mondiale, e alla sofferenza che ha portato in Giappone: la Yamato stessa è identificabile con una nave da guerra usata dai Giapponesi contro gli Americani nel secondo conflitto. I missili atomici dei Gamilonesi ricordano moltissimo la bomba atomica esplosa a Hiroshima e Nagasaki; frequenti sono, nell’anime, immagini di cataclismi naturali, dall’inizio alla fine. Alcuni di questi, poi, sono veramente impressionanti. Con i mezzi dell’epoca, l’anime riesce a farti sentire tutto l’impatto emotivo di quelle catastrofi. Uno dei personaggi principali, Kodai, ha in particolare un lungo flashback in cui ricorda quei tragici eventi, con immagini terribili e strazianti.
Tuttavia, l’anime non va interpretato come una semplice allegoria del secondo conflitto mondiale. I Gamilonesi non si identificano, negli intenti, con gli Americani: nel corso dell’anime, lo spettatore impara a conoscere anche la loro tragica situazione. Non c’è un sentimento di odio verso il nemico, nella serie. O meglio, c’è, ma per una buona prima parte; successivamente, questo senso di odio viene superato, e i protagonisti assumono un atteggiamento diverso nei confronti della propria missione e dell’esistenza.
In particolare, il tema su cui si fonda “La corazzata spaziale Yamato” è la speranza. Con la loro missione, i giovani protagonisti si fanno simbolo della speranza in un futuro migliore. L’unico protagonista anziano è il capitano Okita: un uomo che ha sofferto molto a causa della guerra e che, con la sua esperienza e la sua saggezza, accompagna la missione della sua giovane ciurma, sia dal punto di vista materiale sia spirituale. Come i ragazzi sono il simbolo della speranza nel futuro, così Okita è simbolo del passato doloroso che si cela dietro a quella speranza. Questo è il messaggio della serie: che la speranza non è un sentimento del tutto positivo. Ogni speranza, infatti, presuppone un dolore. Il finale della serie ci insegna che questo dolore non andrà dimenticato, ma si può e si deve superare: a un certo punto, bisogna abbracciare il futuro.
E proprio con questa tematica l’anime si fa interprete della sua epoca. Dopo quello che era successo una trentina di anni prima, è normale che nel Giappone degli anni ’70 si sperasse in un futuro migliore. Una generazione, la più anziana, aveva conosciuto gli orrori della guerra e ne serbava il triste ricordo. Le generazioni più giovani, invece, dovevano farsi promotrici del cambiamento, del riscatto del Paese.
Poi, per carità, l’anime non è assolutamente perfetto. Benché i personaggi, per esempio, mi siano piaciuti, a volte si comportano in modo strano, addirittura inspiegabile per gli standard di oggi. È anche vero che l’anime è stato prodotto molti anni fa, in un contesto culturale diverso, e in un periodo in cui i prodotti di intrattenimento non erano così sorvegliati come oggi.
Inoltre, molto spesso il modo in cui i protagonisti si tirano fuori dal pericolo è poco credibile. Ci sono anche buchi di trama non di scarso rilievo. Non mi è piaciuto, poi, il character design, che trovo decisamente superato. Infine, nonostante adori il finale della serie, ho trovato alcune soluzioni molto discutibili.
Nonostante tutto, però, “La Corazzata Spaziale Yamato” rimane nel podio dei miei anime preferiti. Per me, è un esempio di come una storia non debba per forza essere impeccabile, per essere bella. I suoi difetti non impediscono alla serie di comunicare il suo messaggio in modo straordinariamente efficace, emozionando lo spettatore. Penso che proprio questo, infatti, sia lo scopo di ogni storia: trasmettere messaggi universali attraverso l’emozione.
A caricare l’anime di emozione contribuisce anche la colonna sonora, molto tradizionale e orchestrale. I pezzi non sono tanti, ma la loro ripetitività calza bene con la natura episodica dell’anime. Ciascuno di questi pezzi sa emozionare in modo diverso: alcuni sono incalzanti e avventurosi, altri misteriosi e pacati. Infine, ci sono pezzi di una tristezza unica, che colorano le scene di un’atmosfera dolorosa. La sigla d’apertura è molto iconica e concisa, è mi è piaciuta molto; un po’ meno la sigla di chiusura, che ha un sound un po’ sporco e datato, anche se riesce a essere suggestiva.
Per chiarire, comunque, io ho recuperato la versione giapponese sottotitolata in inglese. Mi ero resa conto, cominciando la serie in italiano, che c’erano troppe modifiche e censure. Già il titolo dell’anime è mutato in “Star Blazers”, titolo che elimina la connotazione squisitamente giapponese dell’opera. Cambia, di conseguenza, anche il nome della nave spaziale: non più Yamato, ma Argo. Cambiano i nomi dei personaggi, che vengono americanizzati: il capitano Okita è il capitano Avatar, Kodai diventa Derek, e via dicendo. Inoltre, vengono rimosse molte scene ritenute inappropriate, e molti riferimenti alla Seconda Guerra Mondiale. È per questo che ho scelto, alla fine, di vedere l’originale: volevo vedere il prodotto così com’era pensato, anche con i suoi elementi più spigolosi. Anche perché, oggi come oggi, abituati come siamo a prodotti sorvegliati, vedere in un anime riferimenti ad avvenimenti storici è una cosa sorprendente.
Vinland Saga
8.5/10
Recensione di MartinoMystero
-
“...che la guerra è bella, anche se fa male” F. De Gregori
Se la storia del Medioevo anglosassone ha sempre esercitato un grande fascino nell’immaginario collettivo, e questo lo si vede nella grande produzione di epopee e saghe cavalleresche che si sono susseguite nel nostro continente e non solo, nel corso dei secoli, le cronache dei Vichinghi hanno sicuramente fatto meno presa sul pubblico, forse perché ciò che è arrivato a noi di loro è l’immagine di meri e feroci razziatori privi di scrupoli e di onore, o forse perché considerati troppo lontani, dalle nostre latitudini, per essere degni di ricevere le dovute attenzioni.
Intanto bisogna dire che con l’appellativo “vichingo” non si fa riferimento a un intero popolo, ma solo a dei pirati appartenenti a genti di origine scandinava. Tali comunità venivano chiamate dagli abitanti delle isole britanniche “Norreni” o “Normanni” (“provenienti dal Nord”), e molti di essi vivevano di allevamento e commercio; inoltre, i Normanni, sono stati tutt’altro che marginali nella storia d’Europa, visto che furono determinanti per la creazione di quello che poi diverrà il Regno Unito e per nulla a noi lontani, dato che i loro discendenti colonizzarono l’intero Sud Italia.
Non so come sia venuto in mente a un autore giapponese di raccontare le gesta di questi popoli, di sicuro c’è stato dietro un grande lavoro storiografico, dato che è riuscito a incastonare nella sua avventura avvenimenti realmente accaduti e personaggi davvero esistiti (chissà, magari ha usato un ottimo consulente alla “Barbero”), e, per quanto mi riguarda, il risultato finale è stato più che soddisfacente. Per i motivi già descritti in precedenza, a un livello prettamente commerciale, l’autore e il suo editore si sono anche presi un gran bel rischio nel narrare un frammento dell’epopea di tali popolazioni: i “Vichinghi” difficilmente riescono a produrre quell’empatia e immedesimazione nel pubblico, tali da indurre la gente ad appassionarsi alle loro vicende, anzi è più probabile che generino antipatia e repulsione, e infatti, nelle varie produzioni letterarie e poi cinematografiche che si sono succedute nei secoli, incarnano quasi sempre il ruolo di banali antagonisti dell’eroe di turno. In pratica, il solo nome evoca già uno stereotipo tutt’altro che positivo, tale da tenere alla larga gran parte del potenziale pubblico.
Questo anime, ambientato a cavallo del primo millennio dopo Cristo, ci fa rivedere la storia che in qualche modo abbiamo studiato (ah ah) a scuola, da un punto di vista invertito, dove il mangaka, portandoci in un villaggio edificato sulle brulle coste della fredda Islanda, ci permette conoscere una piccola e pacifica comunità norrena che cerca di andare avanti con fatica, in una terra dura e ostile. Il clima che si può percepire all’interno della comunità è fraterno e giovale, ed è in questo luogo che si “staglia”, non solo fisicamente, ma anche moralmente, Thors, uomo tanto forte quanto saggio, considerato forse senza la propria volontà capo del villaggio. Ben presto si capisce che fuori dal questo raccolto “rifugio” c’è un mondo crudo e ingiusto, dove sono molto più pericolose le persone che lo abitano e le regole che lo governano, piuttosto che le tormente di neve e le tempeste. Questo mondo “barbarico”, inevitabilmente, busserà alla porta dei protagonisti, stravolgendo le loro vite e dando il via a “Vinland Saga”.
La prima percezione che si ha è che la narrazione vada subito fuori tema: non ci vuole molto per capire cosa sia e dove si trovi “Vinland” (ed è piuttosto lontano dai luoghi trattati), mentre il focus di gran parte delle prime puntate è concentrato sulle vicissitudini del protagonista, e tutto questo rende il racconto piuttosto distante dalla definizione di “Saga”, ma ogni cosa ben presto acquisterà un senso, dato che, verso la metà della serie, il protagonista viene accantonato gradualmente, mentre cominciano ad acquistare sempre più peso quelli che sono stati dei veri personaggi storici, con i conseguenti eventi a loro connessi.
Non mi dilungherò oltre sulla trama, che comunque è sviluppata con abile maestria, ma invece vorrei soffermarmi su una serie di elementi che mi hanno fatto apprezzare questo autore, dato che, tra battaglie, razzie, duelli, cospirazioni e assalti, dimostra di avere una grande capacità nel saper scrutare piuttosto a fondo nella natura umana. Quasi furtivamente, Makoto Yukimura sbatte in faccia allo spettatore quello che è il vero elefante nella stanza del comportamento nella specie “Homo Sapiens”: non solo la propensione, ma addirittura la fascinazione verso il conflitto.
Sin dalle prime battute si vede il forte contrasto tra Thors, che ha vissuto la guerra e fa di tutto per rifuggirla, e i giovani maschi suoi conterranei (compreso suo figlio Thorfinn), che invece l’agognano, la bramano, la sognano, vedendone in essa solo il lato eroico ed epico, sopravvalutando ingenuamente le proprie capacità e sottovalutandone invece i pericoli. Non voglio generalizzare, perché sicuramente le cose sono più complesse di quello che sto per descrivere, tuttavia ciò mi ha riportato alla mente le immagini iniziali delle due Guerre Mondiali, dove, allo stesso modo, persone (soprattutto maschi) di opposte fazioni accoglievano con entusiasmo l’entrata nel conflitto del proprio Paese e orgogliosamente salivano su treni, navi e poi aerei, verso un viaggio che per molti di loro fu di sola andata, perché per ogni “prima” fatto di concitazione, entusiasmo, voglia di avventura e sete di giustizia, c’è un “dopo” fatto di morti, di reduci feriti nel corpo e nell’animo, di distruzione, di macerie e di nuovi rancori, ma questo “dopo” in qualche modo viene percepito come “strano”, “anomalo”, come un qualcosa che è “andato storto” e non come frutto di accadimenti connaturati nella natura stessa del conflitto e alimentati da un’immagine falsamente positiva della guerra, impressa da qualche parte nel DNA umano. Quello che traspare in quest’opera è un sano, sanissimo “fatalismo”, che solo apparentemente potrebbe essere scambiato per cinismo.
L’autore Makoto Yukimura si limita a prendere atto di questa attitudine umana alla guerra, non la cavalca come fa l’intero genere eroico della letteratura (poi adottato a piè pari nei film, nei fumetti e nelle animazioni), non la osteggia con una melassa buonista fatta di slogan ideali “Peace and Love”, “Fate l’amore, non fate la guerra”, ma delinea davanti al ragazzo un duro cammino di disillusione e nuova consapevolezza fatto di sangue, perdita, orrori (subiti e compiuti), dolore e sconfitte. È come se il giovane protagonista (con i suoi coetanei) non abbia nessuna possibilità di comprendere certe cose “per sentito dire”, ma che debba per forza viverle tutte sulla sua pelle, per poter giungere infine alla stessa comprensione di chi lo ha preceduto.
In questa orda di eventi caotici, traspare anche una costante che accomuna tutti i contendenti: lo scopo della propria esistenza. Per quanto possa essere illusoria, gretta o sconsiderata, la ragione per cui vivere sembra essere l’unica cosa che permette, a ognuno dei personaggi, di andare avanti; non a caso, colui che si dimostra più fragile di tutti è anche quello che non riesce ad averla. Riguardo questo argomento lascio un giudizio in sospeso, sicuramente sarà sviluppato nelle prossime stagioni, mentre volevo elencare alcune cose che invece non mi hanno convito appieno: ci sono delle “enfatizzazioni” fisiche di alcuni personaggi i quali o sono troppo forti o troppo resistenti o troppo alti, tuttavia queste piccole licenze, in un’animazione, che fa di tutto per essere “fantasy free”, possono anche essere comprensibili; ci sono poi alcune scene umoristiche totalmente fuori contesto, che invece di risultare piacevoli sono disturbanti; uno dei protagonisti stravolgerà in pochi istanti la sua personalità - è vero che stiamo parlando di un cristiano, e questo repentino cambiamento avviene dopo una caduta da cavallo (era quello che cercava lo scopo), però si passa troppo velocemente da un eccesso a un altro.
C’è poi un pirata che viene presentato come un “banale” capitano vichingo “accatastabile”, senza tante remore, nella sezione “cattivi”, ma che gradualmente acquista spessore, fino a diventare l’individuo più complesso dell’anime. È tra i personaggi più definiti con i quali mi sia imbattuto, dato che, da subito, mette in mostra le sue abilità di guerriero, ma gradualmente inizia a manifestare delle capacità politiche degne del Machiavelli. Lo considero sicuramente il personaggio più interessante dell’intera produzione, tuttavia ciò rappresenta una caduta di realismo, perché non penso che sia esistito nella storia dell’umanità un individuo tanto abile a combattere, quanto bravo a “tramare” dietro le quinte, e, se c’è stato, non lo conosco (magari chiederò a Barbero).
Il mix direzione artistica - animazioni - espressioni è eccellete: il regista riesce a far trasparire sui volti dei vari protagonisti, grazie anche a un grande supporto tecnico, le emozioni che essi vivono, rendendo ancora più intense le scene già di per sé drammatiche. Complice forse lo studio di produzione WIT, che è lo stesso de “L’attacco dei giganti”, un’ambientazione vagamente familiare a tale anime, nonché la stessa “de-romanticizzazione” della guerra, “Vinland Saga” sembra nascere da una sua costola, e più di una volta il piccolo Thorfinn mi ha ricordato il giovane Eren Jaeger. Il comparto grafico è ottimo, la CGI si integra piuttosto bene con le scene disegnate e smussa alcuni difetti, come gli inseguimenti sui cavalli, che erano molto evidenti ai tempi del famoso “Attacco”. Le due opening e le due ending le considero senza lode e senza infamia, da questo punto di vista si poteva fare molto di più.
Il mio voto finale non raggiunge il massimo, non tanto per le imperfezioni di cui sopra, che vengono eclissate dai grandi meriti portati in scena, ma piuttosto dal fatto che il manga, da cui questo anime è tratto, ancora non è giunto a conclusione, e l’autore stesso ha ammesso che la costanza non è il suo forte, quindi il rischio che vada tutto a ramengo, come purtroppo è accaduto a tante altre saghe che lo hanno preceduto, è sempre dietro l’angolo. Al momento, questa prima stagione è da non perdere!
Se la storia del Medioevo anglosassone ha sempre esercitato un grande fascino nell’immaginario collettivo, e questo lo si vede nella grande produzione di epopee e saghe cavalleresche che si sono susseguite nel nostro continente e non solo, nel corso dei secoli, le cronache dei Vichinghi hanno sicuramente fatto meno presa sul pubblico, forse perché ciò che è arrivato a noi di loro è l’immagine di meri e feroci razziatori privi di scrupoli e di onore, o forse perché considerati troppo lontani, dalle nostre latitudini, per essere degni di ricevere le dovute attenzioni.
Intanto bisogna dire che con l’appellativo “vichingo” non si fa riferimento a un intero popolo, ma solo a dei pirati appartenenti a genti di origine scandinava. Tali comunità venivano chiamate dagli abitanti delle isole britanniche “Norreni” o “Normanni” (“provenienti dal Nord”), e molti di essi vivevano di allevamento e commercio; inoltre, i Normanni, sono stati tutt’altro che marginali nella storia d’Europa, visto che furono determinanti per la creazione di quello che poi diverrà il Regno Unito e per nulla a noi lontani, dato che i loro discendenti colonizzarono l’intero Sud Italia.
Non so come sia venuto in mente a un autore giapponese di raccontare le gesta di questi popoli, di sicuro c’è stato dietro un grande lavoro storiografico, dato che è riuscito a incastonare nella sua avventura avvenimenti realmente accaduti e personaggi davvero esistiti (chissà, magari ha usato un ottimo consulente alla “Barbero”), e, per quanto mi riguarda, il risultato finale è stato più che soddisfacente. Per i motivi già descritti in precedenza, a un livello prettamente commerciale, l’autore e il suo editore si sono anche presi un gran bel rischio nel narrare un frammento dell’epopea di tali popolazioni: i “Vichinghi” difficilmente riescono a produrre quell’empatia e immedesimazione nel pubblico, tali da indurre la gente ad appassionarsi alle loro vicende, anzi è più probabile che generino antipatia e repulsione, e infatti, nelle varie produzioni letterarie e poi cinematografiche che si sono succedute nei secoli, incarnano quasi sempre il ruolo di banali antagonisti dell’eroe di turno. In pratica, il solo nome evoca già uno stereotipo tutt’altro che positivo, tale da tenere alla larga gran parte del potenziale pubblico.
Questo anime, ambientato a cavallo del primo millennio dopo Cristo, ci fa rivedere la storia che in qualche modo abbiamo studiato (ah ah) a scuola, da un punto di vista invertito, dove il mangaka, portandoci in un villaggio edificato sulle brulle coste della fredda Islanda, ci permette conoscere una piccola e pacifica comunità norrena che cerca di andare avanti con fatica, in una terra dura e ostile. Il clima che si può percepire all’interno della comunità è fraterno e giovale, ed è in questo luogo che si “staglia”, non solo fisicamente, ma anche moralmente, Thors, uomo tanto forte quanto saggio, considerato forse senza la propria volontà capo del villaggio. Ben presto si capisce che fuori dal questo raccolto “rifugio” c’è un mondo crudo e ingiusto, dove sono molto più pericolose le persone che lo abitano e le regole che lo governano, piuttosto che le tormente di neve e le tempeste. Questo mondo “barbarico”, inevitabilmente, busserà alla porta dei protagonisti, stravolgendo le loro vite e dando il via a “Vinland Saga”.
La prima percezione che si ha è che la narrazione vada subito fuori tema: non ci vuole molto per capire cosa sia e dove si trovi “Vinland” (ed è piuttosto lontano dai luoghi trattati), mentre il focus di gran parte delle prime puntate è concentrato sulle vicissitudini del protagonista, e tutto questo rende il racconto piuttosto distante dalla definizione di “Saga”, ma ogni cosa ben presto acquisterà un senso, dato che, verso la metà della serie, il protagonista viene accantonato gradualmente, mentre cominciano ad acquistare sempre più peso quelli che sono stati dei veri personaggi storici, con i conseguenti eventi a loro connessi.
Non mi dilungherò oltre sulla trama, che comunque è sviluppata con abile maestria, ma invece vorrei soffermarmi su una serie di elementi che mi hanno fatto apprezzare questo autore, dato che, tra battaglie, razzie, duelli, cospirazioni e assalti, dimostra di avere una grande capacità nel saper scrutare piuttosto a fondo nella natura umana. Quasi furtivamente, Makoto Yukimura sbatte in faccia allo spettatore quello che è il vero elefante nella stanza del comportamento nella specie “Homo Sapiens”: non solo la propensione, ma addirittura la fascinazione verso il conflitto.
Sin dalle prime battute si vede il forte contrasto tra Thors, che ha vissuto la guerra e fa di tutto per rifuggirla, e i giovani maschi suoi conterranei (compreso suo figlio Thorfinn), che invece l’agognano, la bramano, la sognano, vedendone in essa solo il lato eroico ed epico, sopravvalutando ingenuamente le proprie capacità e sottovalutandone invece i pericoli. Non voglio generalizzare, perché sicuramente le cose sono più complesse di quello che sto per descrivere, tuttavia ciò mi ha riportato alla mente le immagini iniziali delle due Guerre Mondiali, dove, allo stesso modo, persone (soprattutto maschi) di opposte fazioni accoglievano con entusiasmo l’entrata nel conflitto del proprio Paese e orgogliosamente salivano su treni, navi e poi aerei, verso un viaggio che per molti di loro fu di sola andata, perché per ogni “prima” fatto di concitazione, entusiasmo, voglia di avventura e sete di giustizia, c’è un “dopo” fatto di morti, di reduci feriti nel corpo e nell’animo, di distruzione, di macerie e di nuovi rancori, ma questo “dopo” in qualche modo viene percepito come “strano”, “anomalo”, come un qualcosa che è “andato storto” e non come frutto di accadimenti connaturati nella natura stessa del conflitto e alimentati da un’immagine falsamente positiva della guerra, impressa da qualche parte nel DNA umano. Quello che traspare in quest’opera è un sano, sanissimo “fatalismo”, che solo apparentemente potrebbe essere scambiato per cinismo.
L’autore Makoto Yukimura si limita a prendere atto di questa attitudine umana alla guerra, non la cavalca come fa l’intero genere eroico della letteratura (poi adottato a piè pari nei film, nei fumetti e nelle animazioni), non la osteggia con una melassa buonista fatta di slogan ideali “Peace and Love”, “Fate l’amore, non fate la guerra”, ma delinea davanti al ragazzo un duro cammino di disillusione e nuova consapevolezza fatto di sangue, perdita, orrori (subiti e compiuti), dolore e sconfitte. È come se il giovane protagonista (con i suoi coetanei) non abbia nessuna possibilità di comprendere certe cose “per sentito dire”, ma che debba per forza viverle tutte sulla sua pelle, per poter giungere infine alla stessa comprensione di chi lo ha preceduto.
In questa orda di eventi caotici, traspare anche una costante che accomuna tutti i contendenti: lo scopo della propria esistenza. Per quanto possa essere illusoria, gretta o sconsiderata, la ragione per cui vivere sembra essere l’unica cosa che permette, a ognuno dei personaggi, di andare avanti; non a caso, colui che si dimostra più fragile di tutti è anche quello che non riesce ad averla. Riguardo questo argomento lascio un giudizio in sospeso, sicuramente sarà sviluppato nelle prossime stagioni, mentre volevo elencare alcune cose che invece non mi hanno convito appieno: ci sono delle “enfatizzazioni” fisiche di alcuni personaggi i quali o sono troppo forti o troppo resistenti o troppo alti, tuttavia queste piccole licenze, in un’animazione, che fa di tutto per essere “fantasy free”, possono anche essere comprensibili; ci sono poi alcune scene umoristiche totalmente fuori contesto, che invece di risultare piacevoli sono disturbanti; uno dei protagonisti stravolgerà in pochi istanti la sua personalità - è vero che stiamo parlando di un cristiano, e questo repentino cambiamento avviene dopo una caduta da cavallo (era quello che cercava lo scopo), però si passa troppo velocemente da un eccesso a un altro.
C’è poi un pirata che viene presentato come un “banale” capitano vichingo “accatastabile”, senza tante remore, nella sezione “cattivi”, ma che gradualmente acquista spessore, fino a diventare l’individuo più complesso dell’anime. È tra i personaggi più definiti con i quali mi sia imbattuto, dato che, da subito, mette in mostra le sue abilità di guerriero, ma gradualmente inizia a manifestare delle capacità politiche degne del Machiavelli. Lo considero sicuramente il personaggio più interessante dell’intera produzione, tuttavia ciò rappresenta una caduta di realismo, perché non penso che sia esistito nella storia dell’umanità un individuo tanto abile a combattere, quanto bravo a “tramare” dietro le quinte, e, se c’è stato, non lo conosco (magari chiederò a Barbero).
Il mix direzione artistica - animazioni - espressioni è eccellete: il regista riesce a far trasparire sui volti dei vari protagonisti, grazie anche a un grande supporto tecnico, le emozioni che essi vivono, rendendo ancora più intense le scene già di per sé drammatiche. Complice forse lo studio di produzione WIT, che è lo stesso de “L’attacco dei giganti”, un’ambientazione vagamente familiare a tale anime, nonché la stessa “de-romanticizzazione” della guerra, “Vinland Saga” sembra nascere da una sua costola, e più di una volta il piccolo Thorfinn mi ha ricordato il giovane Eren Jaeger. Il comparto grafico è ottimo, la CGI si integra piuttosto bene con le scene disegnate e smussa alcuni difetti, come gli inseguimenti sui cavalli, che erano molto evidenti ai tempi del famoso “Attacco”. Le due opening e le due ending le considero senza lode e senza infamia, da questo punto di vista si poteva fare molto di più.
Il mio voto finale non raggiunge il massimo, non tanto per le imperfezioni di cui sopra, che vengono eclissate dai grandi meriti portati in scena, ma piuttosto dal fatto che il manga, da cui questo anime è tratto, ancora non è giunto a conclusione, e l’autore stesso ha ammesso che la costanza non è il suo forte, quindi il rischio che vada tutto a ramengo, come purtroppo è accaduto a tante altre saghe che lo hanno preceduto, è sempre dietro l’angolo. Al momento, questa prima stagione è da non perdere!
Hitler
6.5/10
Recensione di DarkSoulRead
-
Shigeru Mizuki è stato un reduce di guerra; arruolato nell'esercito imperiale giapponese durante la seconda guerra mondiale, l’autore visse a pieno l’orrore bellico sul campo di battaglia: assistette alle brutali morti di molti dei suoi compagni e perse il braccio sinistro in seguito ad un’esplosione scaturita da un attacco aereo. Da mancino dovette reinventarsi destrorso, imparando nuovamente a scrivere e successivamente a disegnare con la mano destra. Noto come il padre degli yōkai, Mizuki è ricordato sopratutto grazie al suo celebre “Kitaro dei cimiteri”, personaggio divenuto leggendario nel folklore giapponese, e “Nonnonbâ”, favola orrorifica di matrice autobiografica. I mostri rappresentati dall’autore non sono altro che estensioni estremizzate e parossistiche dell’essere umano, e diventano metafora della popolazione giapponese che, ferita profondamente da Hiroshima e Nagasaki, grida vendetta trasformandosi in un demonio ebbro di rabbia, spalancando fauci insanguinate pronte ad ingoiare tutto il genere umano in un feroce morso d’odio. Come poteva dunque, Adolf Hitler, il demone umano per antonomasia, non passare sotto il vaglio di Shigeru Mizuki?
In “Hitler” Mizuki mette volontariamente a lato gli orrori della guerra, concentrandosi maggiormente sugli aspetti politici e socioculturali di una nazione sfregiata nell'orgoglio dopo il primo conflitto mondiale, pronta a rinascere sotto la guida di un demagogo dalle capacità oratorie e persuasive senza precedenti.
“Io sono un artista e non un politico”.
L’Hitler mizukiano appare collerico e schizoide, ma anche e sopratutto dannatamente umano, tanto che nella sua folle parabola discendente che lo porterà al suicidio instillerà più volte compassione nel lettore.
L’amore morboso e smisurato che nutre nei confronti della nipote Geli, figlia di sua sorella, è un qualcosa che in un certo senso umanizza il demonio più maligno del ventesimo secolo, ponendolo in una dimensione differente rispetto alle caricature di malvagità estrema a cui eravamo stati abituati. Lo spietato Führer era un uomo che si nutriva di sogni, subiva il fascino dell’arte, della musica, aveva la passione per i dipinti e per l’architettura, ma le sue aspirazioni di artista furono distrutte dalle due bocciature all’esame d’ammissione all’Accademia delle Belle Arti di Vienna.
“Il sogno di trasformare la Germania, anzi l’Europa intera, in un’opera nuova, in una creazione che sarebbe stata solo sua. Una creazione che avrebbe plasmato con uno strumento chiamato forza”.
La prima cosa che a chiunque viene in mente quando si parla di nazismo è l’olocausto; sorprendentemente la persecuzione perpetrata dai tedeschi al popolo ebraico è un aspetto che Mizuki preferisce tener da parte, accennandone appena con alcune sporadiche sequenze che evidenziano l’antisemitismo del Führer, ma i campi di concentramento di Auschwitz e gli stermini lì compiuti restano totalmente avulsi al volume.
Scelta sicuramente discutibile dato il didascalico e minuzioso nozionismo storico con cui il mangaka approccia l’opera, cronistoria che fa si che il lettore attenda tutto il tempo un momento che non arriva mai, rimanendo inevitabilmente deluso dall’orrore celato.
L’approccio anticonvenzionale di Mizuki rende “Hitler” un’opera sui generis, indubbiamente spiazzante alla prima lettura, che non anela a sensibilizzare il lettore né tantomeno a sconvolgerlo emotivamente, come di prassi fanno le opere trattanti il medesimo contesto storico. Sia chiaro il manga non vuole essere affatto l’apologia di Hitler, ma la fascinazione che il Mizuki bambino provava verso il Führer emerge chiaramente sin dalle prime pagine. “Hitler” è in primis la storia di un uomo, con evidenti debolezze e grandi aspirazioni, e quella consegnataci dall’autore è l’immagine di un condottiero carismatico e trascinante, l’immagine che durante l’ascesa tedesca tutto il mondo (o quasi) aveva, prima che venisse fornita la definitiva fotografia demoniaca con cui oggi tutti i libri di storia lo ritraggono. Dopotutto non va dimenticato che Hitler è stato eletto al potere democraticamente, e sono proprio le critiche alle falle del sistema democratico uno dei punti chiave del sottotesto mizukiano.
I personaggi storici sono numerosissimi, perfino troppi per lasciare il segno in un sovraccarico di personalità che disorienta e confonde, appesantendo sovente la lettura. Impossibile non citare Mussolini, buffo e grottesco, Mizuki gli dona una caratterizzazione simile a quella vista nell’ultimo “Pinocchio” di Guillermo del Toro, per intenderci, palesando la ridicola considerazione che il mondo ha del duce.
Molte le reference a Napoleone, d’altronde per Hitler il generale francese è stato uno dei massimi riferimenti, una delle figure a cui si è maggiormente ispirato lungo la sua scalata al potere, che diventa metro di paragone nei suoi continui deliri di megalomania.
“Io valgo molto più di Napoleone.
Io sono protetto da Dio!”
Il tratto di Shigeru Mizuki è classico, e strizza l’occhio alla tradizione stilistica manga anni ‘70, di cui lui è antesignano.
Agli sfondi, cupi e fotorealistici (molti presi da fotografie dell’epoca) fanno da contrasto personaggi contraddistinti da un tratto sintetico e caricaturale, quasi cartoonesco, che, con pochissime linee, conferisce loro la massima espressività. Vedere Hitler con la fronte aggrottata imperlata di sudore mentre si deforma nelle sua caratteristiche ed istrioniche espressioni facciali è un qualcosa che da solo vale il prezzo del biglietto.
Il mangaka si cimenta in una contestualizzazione storica certosina, denotativa di un’abilità narrativa che non si limita a racconti folkloristici e di fantasia, come dimostrerà ampiamente anche in seguito con “Verso una nobile morte” e “Showa: Una storia del Giappone”.
Tuttavia da un reduce di guerra era auspicabile un’opera più cruda, “Gekiga Hitler” non è un manga di denuncia, ma una biografia didascalica disegnata da un ex soldato giapponese che ci conferisce un ritratto attraverso “occhi non velati d’odio”, mostrandoci, per alcuni versi, anche nuovi piani prospettici dell’uomo più tristemente noto di tutti i tempi.
Dai primi dipinti al vagabondaggio, dai sogni alle bramosie di conquista, dall’arruolamento militare nell’esercito tedesco, dove si distinguerà per le sue eccezionali doti belliche, fino all’imposizione sull’insipienza politica dell’epoca; la storia di un uomo che ha risollevato una nazione per far poi sprofondare il mondo intero nel terrore più puro.
In “Hitler” Mizuki mette volontariamente a lato gli orrori della guerra, concentrandosi maggiormente sugli aspetti politici e socioculturali di una nazione sfregiata nell'orgoglio dopo il primo conflitto mondiale, pronta a rinascere sotto la guida di un demagogo dalle capacità oratorie e persuasive senza precedenti.
“Io sono un artista e non un politico”.
L’Hitler mizukiano appare collerico e schizoide, ma anche e sopratutto dannatamente umano, tanto che nella sua folle parabola discendente che lo porterà al suicidio instillerà più volte compassione nel lettore.
L’amore morboso e smisurato che nutre nei confronti della nipote Geli, figlia di sua sorella, è un qualcosa che in un certo senso umanizza il demonio più maligno del ventesimo secolo, ponendolo in una dimensione differente rispetto alle caricature di malvagità estrema a cui eravamo stati abituati. Lo spietato Führer era un uomo che si nutriva di sogni, subiva il fascino dell’arte, della musica, aveva la passione per i dipinti e per l’architettura, ma le sue aspirazioni di artista furono distrutte dalle due bocciature all’esame d’ammissione all’Accademia delle Belle Arti di Vienna.
“Il sogno di trasformare la Germania, anzi l’Europa intera, in un’opera nuova, in una creazione che sarebbe stata solo sua. Una creazione che avrebbe plasmato con uno strumento chiamato forza”.
La prima cosa che a chiunque viene in mente quando si parla di nazismo è l’olocausto; sorprendentemente la persecuzione perpetrata dai tedeschi al popolo ebraico è un aspetto che Mizuki preferisce tener da parte, accennandone appena con alcune sporadiche sequenze che evidenziano l’antisemitismo del Führer, ma i campi di concentramento di Auschwitz e gli stermini lì compiuti restano totalmente avulsi al volume.
Scelta sicuramente discutibile dato il didascalico e minuzioso nozionismo storico con cui il mangaka approccia l’opera, cronistoria che fa si che il lettore attenda tutto il tempo un momento che non arriva mai, rimanendo inevitabilmente deluso dall’orrore celato.
L’approccio anticonvenzionale di Mizuki rende “Hitler” un’opera sui generis, indubbiamente spiazzante alla prima lettura, che non anela a sensibilizzare il lettore né tantomeno a sconvolgerlo emotivamente, come di prassi fanno le opere trattanti il medesimo contesto storico. Sia chiaro il manga non vuole essere affatto l’apologia di Hitler, ma la fascinazione che il Mizuki bambino provava verso il Führer emerge chiaramente sin dalle prime pagine. “Hitler” è in primis la storia di un uomo, con evidenti debolezze e grandi aspirazioni, e quella consegnataci dall’autore è l’immagine di un condottiero carismatico e trascinante, l’immagine che durante l’ascesa tedesca tutto il mondo (o quasi) aveva, prima che venisse fornita la definitiva fotografia demoniaca con cui oggi tutti i libri di storia lo ritraggono. Dopotutto non va dimenticato che Hitler è stato eletto al potere democraticamente, e sono proprio le critiche alle falle del sistema democratico uno dei punti chiave del sottotesto mizukiano.
I personaggi storici sono numerosissimi, perfino troppi per lasciare il segno in un sovraccarico di personalità che disorienta e confonde, appesantendo sovente la lettura. Impossibile non citare Mussolini, buffo e grottesco, Mizuki gli dona una caratterizzazione simile a quella vista nell’ultimo “Pinocchio” di Guillermo del Toro, per intenderci, palesando la ridicola considerazione che il mondo ha del duce.
Molte le reference a Napoleone, d’altronde per Hitler il generale francese è stato uno dei massimi riferimenti, una delle figure a cui si è maggiormente ispirato lungo la sua scalata al potere, che diventa metro di paragone nei suoi continui deliri di megalomania.
“Io valgo molto più di Napoleone.
Io sono protetto da Dio!”
Il tratto di Shigeru Mizuki è classico, e strizza l’occhio alla tradizione stilistica manga anni ‘70, di cui lui è antesignano.
Agli sfondi, cupi e fotorealistici (molti presi da fotografie dell’epoca) fanno da contrasto personaggi contraddistinti da un tratto sintetico e caricaturale, quasi cartoonesco, che, con pochissime linee, conferisce loro la massima espressività. Vedere Hitler con la fronte aggrottata imperlata di sudore mentre si deforma nelle sua caratteristiche ed istrioniche espressioni facciali è un qualcosa che da solo vale il prezzo del biglietto.
Il mangaka si cimenta in una contestualizzazione storica certosina, denotativa di un’abilità narrativa che non si limita a racconti folkloristici e di fantasia, come dimostrerà ampiamente anche in seguito con “Verso una nobile morte” e “Showa: Una storia del Giappone”.
Tuttavia da un reduce di guerra era auspicabile un’opera più cruda, “Gekiga Hitler” non è un manga di denuncia, ma una biografia didascalica disegnata da un ex soldato giapponese che ci conferisce un ritratto attraverso “occhi non velati d’odio”, mostrandoci, per alcuni versi, anche nuovi piani prospettici dell’uomo più tristemente noto di tutti i tempi.
Dai primi dipinti al vagabondaggio, dai sogni alle bramosie di conquista, dall’arruolamento militare nell’esercito tedesco, dove si distinguerà per le sue eccezionali doti belliche, fino all’imposizione sull’insipienza politica dell’epoca; la storia di un uomo che ha risollevato una nazione per far poi sprofondare il mondo intero nel terrore più puro.
I collegamenti ad Amazon fanno parte di un programma di affiliazione: se effettui un acquisto o un ordine attraverso questi collegamenti, il nostro sito potrebbe ricevere una commissione.
















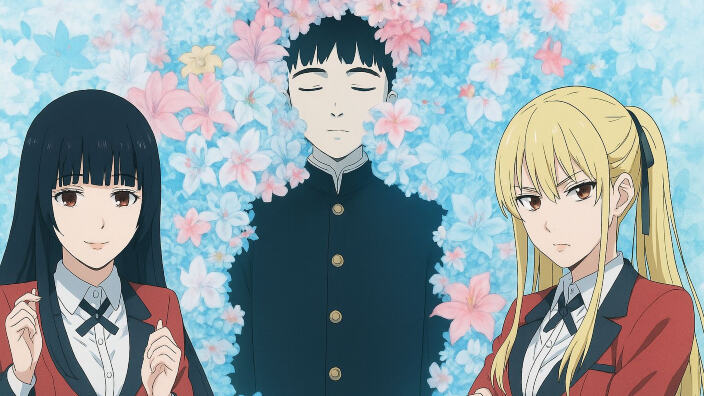


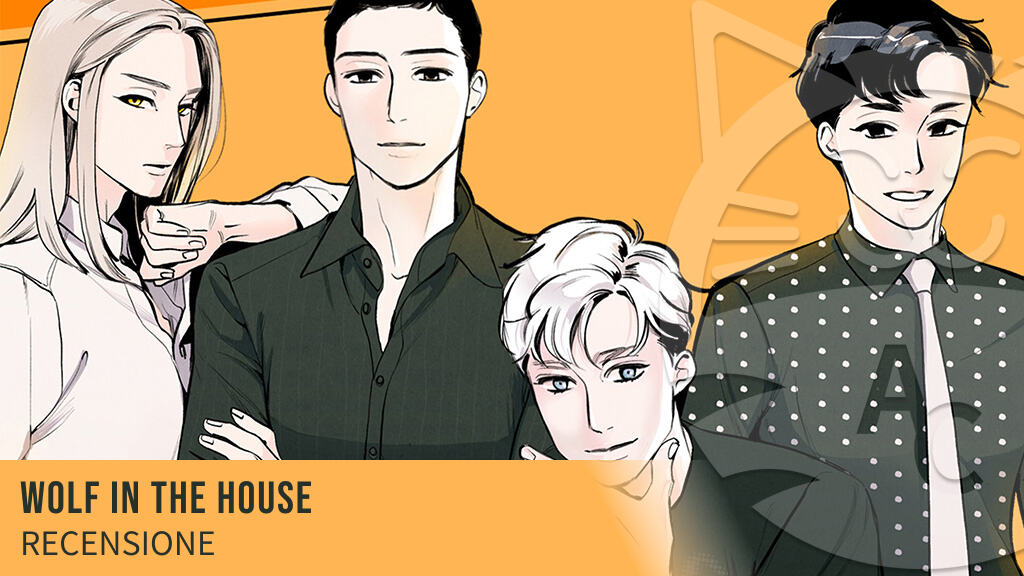


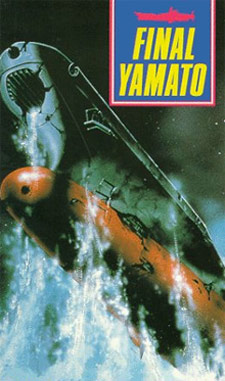

La corazzata è un capolavoro, un punto fondamentale nella storia degli anime.
Troppo spesso si sentono persone (spesso giovani ma non solo) dire che gli anime degli anni 80 e 90 siano vetusti ed inguardabili ... è un po' come dire che il Colosseo cade a pezzi ed è vecchio quindi fa schifo, mentre invece è bello il futuristico grattacielo.
Certo che il grattacielo futuristico può essere impressionante ma il Colosseo ha il suo fascino anche perché, senza di lui, non ci sarebbero stati grattacieli
A chi lo dici! Io ne ho fatto una mia battaglia personale ...
L'animazione come il cinema per me sono arte, e l'arte non invecchia. Oramai è radicato nella testa delle persone, ogni riflessione che fanno contiene sempre le parole - è invecchiato bene - è invecchiato male - oggi non è più buono - oggi gli standard sono altri - ecc-ecc- è una vera e propria malattia.
Io, quando ero ragazzino, negli 80, o nei 90 da maggiorenne, non parlavo male né dicevo che lo Squalo o L'esorcista, di 10-20 anni prima, fossero invecchiati male! Non sentivi nessuno dire, della mia combriccola, che l'invasione degli ultracorpi o King King del 33, erano superati. Anzi, giù il cappello! Ci riempivamo la bocca nel parlarne!
Stessa cosa con la musica, noi degli 80, o dei 90, a parlare della musica di 30 anni prima, che ancora andava forte, e ancora va forte!
Dal 2000 in poi, con l'avvento della rete, è successo qualcosa nella testa delle persone!
Vinland Saga ho appena iniziato il manga, i primi tre albi, e mi ha coinvolta subito... conto di recuperare anche l'anime prima o poi.
belle pero!! e che cose impegnate!!
in effetti sai che tipo di anime ci stava bene in questa categoria di "tragedie storiche", anche? ok...lo sai ahah
questi cmq sono bellissimi e pure belle le rece
@miriam22 beh non serve nemmeno che te lo dica. ma servono recensioni colossali ahah però battute a parte, in effetti calza a pennello col tema di cui parla oggi la beneamata rubrica
Aspettiamo che qualcuno la scrivi quella recensione colossale😎
vinland la prima stagione mi ha colpito per quello ho paura di guardare la seconda
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.