"Shunga" è parola giapponese che significa «pittura dei genitali» e indica le xilografie di soggetto carnale, dette anche "hi-ga" («immagini segrete»). Le raccolte di shunga erano considerate veri e propri manuali di avviamento al piacere dei sensi e venivano donate alle ragazze prossime alle nozze (le donne, perciò, pare le chiamassero "yo-me-iri-makura", cioè «cuscino nuziale»). A questo genere si dedicarono i più famosi incisori giapponesi: Harunobu, Koryûsai, Bunchô, Kunisada, Hokusai. I soggetti rappresentati sono vari e variamente dissoluti: si va dalla raffigurazione delle tenerezze più delicate a quella delle perversioni più spinte, fino alle fantasie sessuali più sfrenate, non senza, spesso, una sottile vena umoristica che pervade il tutto.

Questo breve estratto di un articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore introduce in modo esemplificato il tema della mostra in corso fino al 31 gennaio presso il Palazzo Reale in Piazza Duomo 12 a Milano. Potrete visitarla il lunedì dalle 14.30 alle 19.30, il giovedì e il sabato dalle 9.30 alle 22.30, gli altri giorni dalle 9.30 alle 19.30. Biglietto d'ingresso 8 euro.

Riportiamo di seguito la presentazione pubblicata sul sito della mostra:
Gli Shunga esprimono i valori del nuovo ceto borghese delle grandi città - composto da mercanti, artigiani e artisti, escluso dal potere politico, ma economicamente fiorente - con il quale si affermò in quegli anni una concezione edonistica dell’esistenza, in contrasto con la rigida morale neoconfuciana, sostenuta dalla classe guerriera dei Samurai che reggeva il governo centrale del Giappone. Questi cittadini offrivano un esempio di vita raffinata, ostentando il lusso, organizzando feste, frequentando i teatri e le case di piacere: così il termine ukiyo-e, che designava l’arte ispirata a tale genere di vita, diventa sinonimo di “moderno”, alla moda, esprimendo una sorta di filosofia incentrata sul gusto di un’esistenza piacevole e, per quanto possibile, appagante dei desideri personali. Superando i divieti e gli ostacoli del potere politico, gli Shunga si affermarono come componente fondamentale della produzione dei più importanti artisti del tempo come Harunobu, Koryusai, Kiyonaga, Utamaro e Hokusai. Furono molto apprezzati sia come stampe a se stanti, pubblicate generalmente in album di 12 fogli e destinate a un pubblico di amatori d’arte, sia come illustrazioni per libri erotici fruiti soprattutto attraverso le librerie ambulanti a prestito. Questi libri Shunga inoltre erano destinati all’educazione delle cortigiane e delle fanciulle che andavano spose, come utile vademecum per l'avviamento alla vita sessuale, oppure inseriti nei bauli dei guerrieri, per il loro potere di preservare dalla distruzione e di condurre alla vittoria. Gli Shunga furono espressione di un’ideologia che fece da contraltare visivo a una produzione letteraria piena di sensualità che si affermò con i cosiddetti “romanzi del mondo fluttuante”, fra i quali ricordiamo le opere dei celebri scrittori come Ihara Saikaku e Ejima Kiseki. Collezionate segretamente in Europa, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, dopo che il Giappone fu costretto ad aprire le sue isole alle navi straniere e agli scambi commerciali col mondo occidentale, esse furono motivo di ispirazione diretta di letterati e artisti della levatura di Zola, di Van Gogh, di Toulouse-Lautrec e di Klimt, e influirono in modo significativo sulla riflessione artistica nell'ambito dell'Orientalismo della fine del XIX e dell'inizio del XX secolo. Considerati per molto tempo immagini di carattere pornografico, nonostante il loro altissimo valore artistico, gli Shunga sono stati da più di venti anni rivalutati sia come espressione «alta» della cultura giapponese e specchio raffinato dei costumi del loro tempo, sia come uno dei vertici assoluti dell'espressione dell'eros nell'arte.


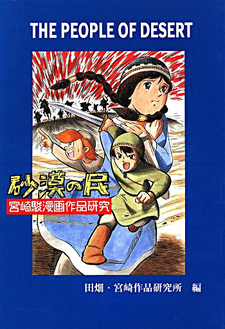

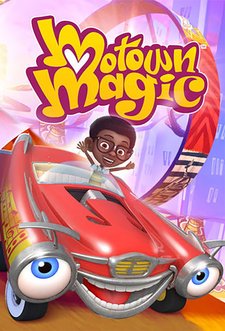
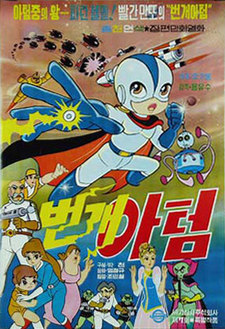
Mi sembra che posti sempre più notizie su quest'argomento!
A proposito, sarebbe ora di inserire nuovi titoli
Comunque è interessantissimo notare come la xilografia (incisioni con matrice in legno) sia stata utilizzata in maniera così differente tra oriente ed occidente: da noi in Europa la si sfruttava spesso per la sua resa poco rifinita e per accentuare la componente espressionista tipica di un sentire "sofferente" e angosciato la realtà in cui si viveva (soprattutto durante la guerra); mente in Giappone per stampare in serie soggetti così leziosi e ...da "monellacci". Certo che 'sti giapponesi hanno sempre avuto un chiodo fisso!
effettivamente qualche doppiio senso c'è...
comunque questa forma è arte, anche se aveva un uso diffuso e pratico. L'arte giapponese è proprio diversa da quella occidentale, come dic Oberon, la leggerezza dei contenuti la rende molto affascinante...
e poi dietro a queste raffigurazioni si coglie lo spirito di una cultura aperta, spregiudicata...tutto il contrario della nostra...
cavoli, però! 8euro l'ngresso alla mostra???
non ascoltare questi puritani!!! la veneranda età rende l'uomo più ecchi e meno serio! continua così! ahahahah
viva i doppi sensi U_U
come ben sappiamo, parlando seriamente, c'è un vero e proprio abisso nella concezione sessuale che si è sviluppata qui e in giappone nell'ultimo millennio. forse grazie alla globalizzazione le distanze di pensiero hanno l'opportunità di accorciarsi, ma chi sa.. a volte paiono due mondi completamente differenti
i kanji che compongono la parola shunga 春画 sono:
(shun) 春 cioè primavera
(ga) 画 cioè immagine.
Primavera stagione degli amori
Comunque non sminuirei così questa arte "fluttuante" dell'abbandonarsi ai piaceri della vita (non solo sessuali)
che li rende ancora più belli e apprezzabili proprio perchè
fugaci e temporanei.
Gli shunga sono si stampe erotiche ma molto raffinate a mio avviso.
@oberon gli shunga sono una parte dell'arte del periodo Edo diffuso nella classe borghese, non rappresenta l'arte di tutti i giapponesi di quel tempo.
C'è tutta un'arte aristocratica e di corte risalente a prima dell'anno mille (che preferisco)
Comunque è errata la definizione di resa poco rifinita della xilografia europea, non vedo su che basi poggi. Dare del poco rifinito a una xilografia di Duerer mi pare un affermazione proprio campata per aria, considerando soprattutto quanta perizia ci voglia per incidere il legno e la resa che Duerer ne otteneva.
@Limbes
Se nella stessa frase utilizzo "xilografia" "espresionista" "sofferente" e "guerra" mi sembra lapalissiano che mi stessi riferendo ad una xilografia alla Ernst Ludwig Kirchner
Che poi ci siano di mezzo tante sfumature di grigio questo è un altro discorso, un discorso ovvio a dirla tutta, ma che semplicemente non mi interessava assolutamente toccare. Magari ora dovrei mettermi a citare tutti gli incisori di questo mondo, e magari passare anche a parlare dell'acquaforte, della litografia e della serigrafia, per giustificare una semplice osservazione?
<i>"Dare del poco rifinito a una xilografia di Duerer..."</i>
Infatti io non l'ho fatto >_> non l'ho neanche nominato apposta. Durer (assieme a Rembrandt) è forse uno degli esponenti dell'arte incisoria che più di tanti altri ha realizzato opere dettagliatissime! Neanche un bambino delle elementari si sognerebbe di definirlo "poco rifinito"
"Shunga. Arte ed Eros nel Giappone del periodo Edo" non è semplicemente una mostra, ma un percorso d'iniziazione erotica come non se ne vedevano dai bei tempi degli spinti cartoni animati che dal sol levante invadevano le nostre tivì commerciali."
è una vera stupidaggine. Però, da qui a parlare addirittura di disinformazione "da delinquenti" ce ne passa...
Ibra, ti sbagli.
Questi sono "delinquenti culturali".
Duerer valeva solo come esempio contraddittorio random alla xilografia europea poco rifinita, e comunque non ci contare su come potrebbe essere definito, ho sentito cose io...
Questa è la seconda inerente la cultura Giapponese che fanno a Palazzo reale quest'anno, e alla prima sono andato.
@ Tacchan: mi associo a Oberon, l afrase può sembrare equivoca
Hai perfettamente ragione, Milano ultimamente "si sta dando al Giappone" (spero non ci leggerete un doppio-senso come avete fatto con il povero Tacchan, anche molto blando direi)
@Oberon
Si sente proprio che sei un artista acculturato, ora mi aspetto da te come minimo una minuziosa analisi di tutti i mangaka, con influssi artistici di riferimento, ecc... vabbè il resto lo lascio a te visto che io non ci capisco nulla
è un video serissimo....e piuttosto interessante
<center><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" width="482" height="419" id="yalplayer" align="middle"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="movie" value="http://landing.yalp.alice.it/landing/LandingService?contentId=dv-50160207&size=s&color=00ccff&corr=1&uri=http%3A%2F%2Fwww.yalp.alice.it%2Fvideo%2Flifestyle%2Fsocieta%2Faa%2Fdv-50160207.html&channelId=null"></param><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="black" /><embed src="http://landing.yalp.alice.it/landing/LandingService?contentId=dv-50160207&size=s&color=00ccff&corr=1&uri=http%3A%2F%2Fwww.yalp.alice.it%2Fvideo%2Flifestyle%2Fsocieta%2Faa%2Fdv-50160207.html&channelId=null" quality="high" bgcolor="black" width="482" height="419" name="yalplayer" align="middle" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" ></embed></object></center>
spero che si inserisca però. Trovato casualmente.
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.