 Non so se Yuasa conosca Richard K. Morgan. Credo che Morgan sia comunque misconosciuto fuori della cerchia dei cultori della fantascienza. Di chi ha letto quel Bay City che riprendeva ciò che il cyberpunk aveva ancora da dire e ne estraeva una storia di spessore e profondità, satura d’idee come nella migliore tradizione della corrente. Una storia che, en passant, ha raccolto il premio Phillip K. Dick. Tanto per gradire.
Non so se Yuasa conosca Richard K. Morgan. Credo che Morgan sia comunque misconosciuto fuori della cerchia dei cultori della fantascienza. Di chi ha letto quel Bay City che riprendeva ciò che il cyberpunk aveva ancora da dire e ne estraeva una storia di spessore e profondità, satura d’idee come nella migliore tradizione della corrente. Una storia che, en passant, ha raccolto il premio Phillip K. Dick. Tanto per gradire.Kaiba ha molto, moltissimo del soggetto di Morgan. Yuasa lo muove su altre strade, con altri scopi, ma la base è quella: il corpo intercambiabile. Una custodia, in Kaiba come in Bay City – nel quale così viene pure chiamato, tra l’altro. Nel dubbio, si può prenderla come convergenza evolutiva.
È pur vero che altri spunti, concettuali e non soltanto, Yuasa li pesca da fonti a lui più vicine. Si va dall’Akira di Otomo alle molte manifestazioni di Ghost in the Shell, fino al NGE che fu. Su quest’ultimo debito ci sarebbe da discutere perché le aspirazioni totalizzanti del discorso di Anno portano, a torto o a ragione, a ricondurre a Evangelion quasi tutto ciò che anche di vagamente simile gli è seguíto. Ma la parentesi sarebbe troppo ampia. Il succo della faccenda è che l’originalità contenutistica, così acclamata dagli intenditori (o sedicenti tali) dell’animazione, in Kaiba è un aspetto trascendentale. A Yuasa importa d’altro. Yuasa lavora su ben altro.
Il contrappunto, per esempio. A un primo colpo d’occhio pare lampante la dissonanza tra i temi e la veste di Kaiba. Figurazione “pupazzosa”, bambinesca; condizioni distopiche, pervasività della morte. Sotto la superficie c’è un’operazione parecchio raffinata che, sul piano espressivo, gioca sulle possibilità produttive del contrasto tra le implicazioni delle azioni e la loro resa grafica: sulla carica che si genera dall’interazione tra accenti opposti. Da una parte la crudezza/crudeltà delle scene, dall’altra la messinscena buffa/carnevalesca.
Yuasa l’aveva già fatto ai tempi di Genius Party, con Happy Machine, da gemellare per parecchi motivi a Kaiba, che potrebbe magari nascere come una ripresa ed espansione di quel piccolo gioiello. In aggiunta, qui, Yuasa scherza con l’alternanza dei toni – comico, patetico eccetera –, con la loro giustapposizione che ne ingigantisce gli effetti, li rende paradossali, li dissacra anche. Sempre sotto l’egida di una (auto)ironia che non vela del tutto l’amarezza per una realtà disumana, postsumana, o forse terribilmente umana.
In Kaiba la disperazione è occultata, o meglio ribaltata: altra faccia di un mondo plasmato sullo zucchero filato; precipitata sotto un chara all’apparenza kawaii. In realtà Yuasa opera in modo più sottile anche in questo. Riprende e riattualizza un modello (pre?)tezukiano stilizzando pupazzetti che si muovono in mezzo a orrori strampalati. È la sublimazione nel grottesco di una tragedia di bambole, quella di Yuasa, un riuscire a prendere sul serio ciò che superficialmente è impossibile prendere sul serio. La posta in palio non è solo, o meglio non tanto la rottura degli stereotipi iconografici dell’animazione mainstream.
 È lo stesso argomento fantascientifico di cui parlavo prima a essere sovvertito, innestato in uno spazio fantasmagorico, surreale, dove le leggi fisiche non funzionano – non ce n’è bisogno. La presenza divina è inglobata nel tessuto del mondo. In Kaiba il trascendente si fonde all’immanente. Dio esplora un universo di cui fa parte e in cui tutto è visibile. Una realtà irreale, una dimensione metafisica dove s’incontrano dio e contro-dio. Né mimesi del “nostro” mondo né ricalco dell’idealità proposta dai canoni classici della japanimation. Magari solo uno tra i possibili creati della divinità proteiforme di Mind Game.
È lo stesso argomento fantascientifico di cui parlavo prima a essere sovvertito, innestato in uno spazio fantasmagorico, surreale, dove le leggi fisiche non funzionano – non ce n’è bisogno. La presenza divina è inglobata nel tessuto del mondo. In Kaiba il trascendente si fonde all’immanente. Dio esplora un universo di cui fa parte e in cui tutto è visibile. Una realtà irreale, una dimensione metafisica dove s’incontrano dio e contro-dio. Né mimesi del “nostro” mondo né ricalco dell’idealità proposta dai canoni classici della japanimation. Magari solo uno tra i possibili creati della divinità proteiforme di Mind Game.E, come in Mind Game, lo stile di Yuasa continua a spezzare schemi formali, ma in maniera differente. Mitiga lo sclero furioso del film del 2004, lo leviga in funzione di una narrazione sempre rapsodica ma meno euforica, più elegante, più (de)costruita. Il montaggio antilineare saltella con leggerezza sui fili di un’intricatissima rete di elisioni, depistaggi, cenni e analessi. Abolito ogni didascalismo, l’uso massiccio dello straniamento costringe a ragionare, stimolo a uno sforzo logico che rimetta insieme i pezzi, rimonti le informazioni quantizzate, parcellizzate, sparpagliate nel labirinto dell’intreccio. Kaiba struttura una visione attiva per sguardi svezzati, scalza vecchi modi, vecchie soluzioni ormai apprese, somatizzate, stantie.
Se Yuasa lo faccia per il suo piacere o per quello altrui, non è semplice capirlo. Certo è che di godimento per l’occhio, di chi non importa, Kaiba ne offre a treni. E proprio dentro la forma di Kaiba si trova il più nascosto, forse il più grande dei contrappunti gestiti dal suo creatore. Quello tra la semplicità degli strumenti che utilizza e la complessità estrema con cui li manipola. La sintassi visiva di Yuasa piega il mezzo a ogni suo volere, ne adopera gli elementi con una proprietà assoluta, con la naturalezza, la consapevolezza che sono sole dei geni, lui sì, Yuasa, genio in mezzo a masnade di millantatori, millantati e falsi illuminati.
Poi in fondo a tutto ciò Yuasa racconta anche una storia, semplice, triste se si vuole, bella, brutta, di (ri)formazione o devastazione. Le lascia comunque un lumicino di speranza alla fine. Magari una piccola metafora, forse è lo stesso Kaiba quel lumicino, opera meravigliosa che da sola dà un senso ai duecento e passa titoli d’impalpabile inanità evacuati ogni anno dall’industria degli anime.






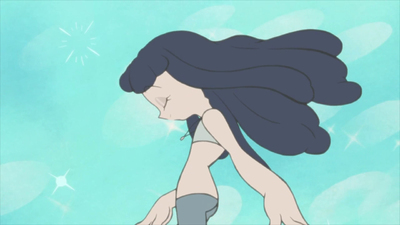











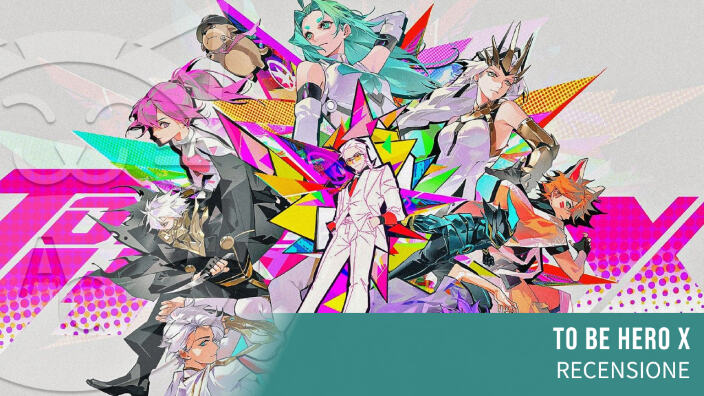







sarebbe?
Anche a me i disegni hanno fatto subito venire in mente Tezuka .-.
Complimenti per lo scritto e... me la segno
Comunque, Limbes dice bene, Yuasa è un genio, dopo aver visto Kaiba e Tatami Galaxy è entrato a far parte dei miei registi preferiti.
E Kaiba è un capolavoro.
Personalmente è da 9,5.
Non credo sia un anime per tutti. Spero non si commercializzi come altre perle del genere, anche se dubito che mai accadrà.
Mi manca Kemonozume e poi potrò dire di aver visto quasi tutto ciò che Yuasa ha prodotto.
Sperando che non esista gente che pensi che prima di Tezuka non esistessero fumetti e animazione in Giappone, c'erano ma erano diversi.
Visivamente il film è molto bello, i toni fanciulleschi che rimandano a tezuka si scontrano con un ambientazione in cui aleggia angoscia e un vago senso di morte, come hai detto tu. Perlomeno questo è ciò che mi hanno trasmesso le immagini.
Generalmente apprezzo queste opere sperimentali, ma nella maggioranza dei casi dopo 20 minuti mi stufano, se non hanno una trama da portare avanti. Ad ogni modo gli darò senz'altro un'occhiata.
Edit: Ah comprendo solo ora che si tratta di una serie da 12 episodi.
Invece, da quanto ho capito, Kaiba è proprio un lavoro tutto suo, ed è animato dalla Madhouse. Mea culpa che ce l'ho pure in wishlist da chissà quanto e ancora non ne ho vista mezza puntata.
Dovrei recuperare pure Mind Game...
peccato! Mi sarebbe piaciuto sapere chi avesse ispirato a sua volta O. Tezuka.
@RyOGo
Bene, Ryogo, ma la mia domanda era "Chi è (pre)tezukiano" non " che significa (pre)tezukiano".
Ah, c'erano già quindi? XD
Inoltre l'apparato musicale è indimenticabile, forse perché riesce alla perfezione a sposarsi con l'apparato visuale e concettuale dell'opera, alternando a motivi non proprio orecchiabili, ma geniali nell'organizzazione ritmica, temi di un grandioso e sublime che quasi stona con i personaggi-pupazzo, e che proprio per tale ragione risaltano ancora di più.
Complimenti, Limbes. Come sempre invidio la ricchezza del tuo lessico, c'è da rimanere sbalorditi della proprietà di linguaggio con cui sai analizzare strato dopo strato un prodotto d'animazione.
La gente è rimasta estasiata.
PS: Tezuka viene citato al massimo nel tratto, ma non nello stile narrativo ne nei temi. Ed il motivo è spiegato da una bella frase nella rece: "È la sublimazione nel grottesco di una tragedia di bambole"
PS2: L'unico appunto che si può fare a Limbes, a voler essere rompipalle, ed io ovviamente lo voglio, è che esagera magari coi termini d'effetto. Ma finché la recensione risulta comunque comprensibile, chissenefrega
basta cercare i nomi dei vecchi corti d'animazione e qualche info la si trova.
E son contento che non sono l'unico su AC ad essermi visto alcune cose...
http://www.crunchyroll.com/japanese-anime-classic-collection-1/episode-11-our-baseball-match-oira-no-yakyo-507580
e a cosa si rifarebbe lo stile di Tezuka con 'stà roba??
http://www.animeclick.it/anime.php?titolo=Kaiba
PS off topic: Dato che l'incipit fa cenno alla letteratura di fantascienza un pensiero non può che andare alla memoria Ray Bradbury.
Però la recensione è troppo personale, in pratica, sembra di ascoltare Enrico Ghezzi quando parla fuori sincro a fuori orario.
E poi unire il linguaggio visivo di tezuka a temi "altri" (che ancora devo scoprire...) è una vera presa di posizione
Complimenti Limbles, hai una padronanza della dialettica bellissima, stima assoluta.
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.