Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle recensioni su anime e manga, realizzate degli utenti di AnimeClick.it.
Se volete farne parte anche voi... rimboccatevi le maniche e recensite!
Ricordiamo che questa rubrica non vuole essere un modo per giudicare in maniera perentoria i titoli in esame, ma un semplice contesto in cui proporre delle analisi che forniscano, indipendentemente dal loro voto finale, spunti interessanti per la nascita di discussioni, si auspica, costruttive per l'utenza.
Per saperne di più continuate a leggere.
Se volete farne parte anche voi... rimboccatevi le maniche e recensite!
Ricordiamo che questa rubrica non vuole essere un modo per giudicare in maniera perentoria i titoli in esame, ma un semplice contesto in cui proporre delle analisi che forniscano, indipendentemente dal loro voto finale, spunti interessanti per la nascita di discussioni, si auspica, costruttive per l'utenza.
Per saperne di più continuate a leggere.
La canzone del mare
9.0/10
“La canzone del mare” (titolo originale “Song of the Sea”) è un lungometraggio animato di produzione internazionale europea del 2014. Diretto da Tomm Moore e uscito nelle sale italiane con due anni di ritardo, è stato candidato all’Oscar per il miglior film d’animazione nell’annata 2015.
Trama: il piccolo Ben, che vive con i genitori e il cane Cù in un faro di cui il padre è custode, è rimasto orfano di madre il giorno stesso in cui è venuta al mondo la sua sorellina, la cui nascita era attesa con trepidazione ed entusiasmo. Sei anni dopo, la bambina, Saoirse, è ancora incapace di parlare e non sembra essere mai riuscita ad aprire una breccia nel cuore del fratello maggiore, che le si rivolge frequentemente con toni aspri e insofferenti, mentre il papà dei due è ancora visibilmente provato dall’allontanamento della moglie.
In seguito a un apparente incidente in mare, la nonna dei ragazzini decide di portarli con sé in città, allontanandoli da quello che ritiene un ambiente poco sicuro, ed è proprio qui che, paradossalmente, Ben e Saoirse si ritrovano immersi in una realtà magica, in cui è il folklore celtico (e soprattutto irlandese) a farla da padrone.
“La canzone del mare” è una fiaba moderna che riesce ad essere al contempo delicata e straordinariamente intensa, facendo affidamento a un mondo fantastico che, sebbene tangibile quanto quello reale, funge da allegoria per quest’ultimo, introducendo e spiegando concetti direttamente collegati alla difficile situazione famigliare di Ben e Saoirse tramite continui rimandi, visivi e narrativi, ai personaggi mitologici (ben noti ai protagonisti) e alle loro storie. L’intreccio semplice e i personaggi non particolarmente complessi ma terribilmente umani nulla tolgono alla forza del racconto, che fin dalle prime battute avvolge lo spettatore in un piacevole tepore affettivo, senza però sminuire la carica emotiva delle scene più toccanti e drammatiche.
Il cast, con le sue motivazioni ed esperienze, risulta affascinante e concreto, e bastano pochi dialoghi per afferrare i traumi del passato e le speranze per il futuro di ognuno, sia per quanto riguarda i personaggi principali che quelli secondari, a cui è impossibile non rivolgere sguardi colmi di comprensione e tristezza. L’ostilità di Ben nei confronti della dolce Saoirse è irrazionale e lo rende potenzialmente antipatico e insopportabile, almeno finché non si prendono in considerazione la sua giovanissima età e l’associazione tra la sparizione dell’amata madre e la nascita della sorellina. Lo stesso dicasi per la nonna, una figura quasi dispotica e crudele apparentemente intenzionata a distruggere un già fragile nucleo famigliare, ma in realtà semplicemente in apprensione per un figlio che non ha mai superato il dolore per la perdita della compagna e per dei nipoti cresciuti quasi in isolamento e con problemi comportamentali.
Si configura così una storia in cui non vi sono dei veri e propri antagonisti, quanto piuttosto situazioni conflittuali dovute a una reazione non salutare alla sofferenza, a un adagiarsi nella disperazione, al totale diniego dei ricordi infelici per confinarsi in un’illusoria pace priva di sentimenti e turbamenti di alcuna sorta. La bellezza della pellicola emerge proprio in un messaggio positivo, in un’accettazione della vita nella sua interezza, con i suoi dispiaceri e i momenti più allegri, poiché ignorare il malessere interiore è un atteggiamento miope con pericolose conseguenze di deumanizzazione, mentre l’abbandono passivo a un presente deprimente e cupo mortifica le persone care.
Il comparto grafico assume un ruolo di primo piano all’interno del lungometraggio, cui dona uno stile unico e inconfondibile, e accompagna mirabilmente gli sviluppi narrativi, assumendo tonalità cromatiche che vanno dallo spento al brillante a seconda delle circostanze. La prospettiva realistica viene messa da parte in favore di una percezione bidimensionale degli sfondi, a metà tra le incisioni dei manoscritti medievali e i libri pop-up, che si manifestano come semplici ma non privi di dettagli. Lo stesso character design presenta particolari spigolosi, ma non diviene mai duro e tagliente, rivelandosi invece morbido e tenero, perfetto per delle animazioni fluide.
Considerato il titolo, fin dal prologo “La canzone del mare” esprime un legame indissolubile con la musica, che riveste un ruolo fondamentale all’interno della vicenda stessa, in un misto di brani diegetici ed extra-diegetici. La colonna sonora, eseguita perlopiù con strumenti tradizionali, è discretamente versatile e include pezzi ritmati e vivaci e altri più solenni e mistici, restando per la maggior parte del tempo di una commovente bellezza. Molto buono anche il doppiaggio italiano.
In conclusione, “La canzone del mare” è un piccolo capolavoro, un’incantevole opera di splendida sartoria cinematografica dotata di profonda creatività visiva e umanità, in cui l’introspezione psicologica non spettacolare è compensata, come in alcuni dei lavori del maestro Miyazaki, dalle interpretazioni e dalle reazioni emotive dei protagonisti, credibili e capaci di smuovere le corde del più arido degli animi.
Si tratta di una pellicola magica e graziosa, coinvolgente e trascinante, un autentico film per tutta la famiglia, con tutte le implicazioni positive del termine.
Trama: il piccolo Ben, che vive con i genitori e il cane Cù in un faro di cui il padre è custode, è rimasto orfano di madre il giorno stesso in cui è venuta al mondo la sua sorellina, la cui nascita era attesa con trepidazione ed entusiasmo. Sei anni dopo, la bambina, Saoirse, è ancora incapace di parlare e non sembra essere mai riuscita ad aprire una breccia nel cuore del fratello maggiore, che le si rivolge frequentemente con toni aspri e insofferenti, mentre il papà dei due è ancora visibilmente provato dall’allontanamento della moglie.
In seguito a un apparente incidente in mare, la nonna dei ragazzini decide di portarli con sé in città, allontanandoli da quello che ritiene un ambiente poco sicuro, ed è proprio qui che, paradossalmente, Ben e Saoirse si ritrovano immersi in una realtà magica, in cui è il folklore celtico (e soprattutto irlandese) a farla da padrone.
“La canzone del mare” è una fiaba moderna che riesce ad essere al contempo delicata e straordinariamente intensa, facendo affidamento a un mondo fantastico che, sebbene tangibile quanto quello reale, funge da allegoria per quest’ultimo, introducendo e spiegando concetti direttamente collegati alla difficile situazione famigliare di Ben e Saoirse tramite continui rimandi, visivi e narrativi, ai personaggi mitologici (ben noti ai protagonisti) e alle loro storie. L’intreccio semplice e i personaggi non particolarmente complessi ma terribilmente umani nulla tolgono alla forza del racconto, che fin dalle prime battute avvolge lo spettatore in un piacevole tepore affettivo, senza però sminuire la carica emotiva delle scene più toccanti e drammatiche.
Il cast, con le sue motivazioni ed esperienze, risulta affascinante e concreto, e bastano pochi dialoghi per afferrare i traumi del passato e le speranze per il futuro di ognuno, sia per quanto riguarda i personaggi principali che quelli secondari, a cui è impossibile non rivolgere sguardi colmi di comprensione e tristezza. L’ostilità di Ben nei confronti della dolce Saoirse è irrazionale e lo rende potenzialmente antipatico e insopportabile, almeno finché non si prendono in considerazione la sua giovanissima età e l’associazione tra la sparizione dell’amata madre e la nascita della sorellina. Lo stesso dicasi per la nonna, una figura quasi dispotica e crudele apparentemente intenzionata a distruggere un già fragile nucleo famigliare, ma in realtà semplicemente in apprensione per un figlio che non ha mai superato il dolore per la perdita della compagna e per dei nipoti cresciuti quasi in isolamento e con problemi comportamentali.
Si configura così una storia in cui non vi sono dei veri e propri antagonisti, quanto piuttosto situazioni conflittuali dovute a una reazione non salutare alla sofferenza, a un adagiarsi nella disperazione, al totale diniego dei ricordi infelici per confinarsi in un’illusoria pace priva di sentimenti e turbamenti di alcuna sorta. La bellezza della pellicola emerge proprio in un messaggio positivo, in un’accettazione della vita nella sua interezza, con i suoi dispiaceri e i momenti più allegri, poiché ignorare il malessere interiore è un atteggiamento miope con pericolose conseguenze di deumanizzazione, mentre l’abbandono passivo a un presente deprimente e cupo mortifica le persone care.
Il comparto grafico assume un ruolo di primo piano all’interno del lungometraggio, cui dona uno stile unico e inconfondibile, e accompagna mirabilmente gli sviluppi narrativi, assumendo tonalità cromatiche che vanno dallo spento al brillante a seconda delle circostanze. La prospettiva realistica viene messa da parte in favore di una percezione bidimensionale degli sfondi, a metà tra le incisioni dei manoscritti medievali e i libri pop-up, che si manifestano come semplici ma non privi di dettagli. Lo stesso character design presenta particolari spigolosi, ma non diviene mai duro e tagliente, rivelandosi invece morbido e tenero, perfetto per delle animazioni fluide.
Considerato il titolo, fin dal prologo “La canzone del mare” esprime un legame indissolubile con la musica, che riveste un ruolo fondamentale all’interno della vicenda stessa, in un misto di brani diegetici ed extra-diegetici. La colonna sonora, eseguita perlopiù con strumenti tradizionali, è discretamente versatile e include pezzi ritmati e vivaci e altri più solenni e mistici, restando per la maggior parte del tempo di una commovente bellezza. Molto buono anche il doppiaggio italiano.
In conclusione, “La canzone del mare” è un piccolo capolavoro, un’incantevole opera di splendida sartoria cinematografica dotata di profonda creatività visiva e umanità, in cui l’introspezione psicologica non spettacolare è compensata, come in alcuni dei lavori del maestro Miyazaki, dalle interpretazioni e dalle reazioni emotive dei protagonisti, credibili e capaci di smuovere le corde del più arido degli animi.
Si tratta di una pellicola magica e graziosa, coinvolgente e trascinante, un autentico film per tutta la famiglia, con tutte le implicazioni positive del termine.
Grand Blue Dreaming
9.0/10
L'ironia è una grande cosa, soprattutto quando l'unico termine che riesce a descrivere un prodotto è lo stesso che lo caratterizza, e ironia vuole che "Grand Blue" sia una vera e propria "immersione" unica nel suo genere.
Trasposizione dell'opera originale del duo malefico Kenji Inoue/Kimitake Yoshioka, "Grand Blue" è un complesso mosaico capace di mischiare, in modo quasi sempre convincente, una quantità spropositata di influenze e citazioni della cultura otaku e non.
La trama, in soldoni, vede il giovane Iori Kitahara trasferirsi a casa dello zio in modo da poter frequentare l'università di Izu. Speranzoso di vivere una vita piena di emozioni ed esperienze, Iori si ritroverà, senza capirne bene le dinamiche, a far parte del club di immersioni dove gli elementi "sopra le righe" non mancano.
La prima impressione data dalla serie è quella dell'immediatezza, un approccio quasi brutale con lo spettatore che viene letteralmente trascinato nei deliri narrativi della stessa. Un'immediatezza che mette subito le carte in tavola, senza alcuna vergogna di sorta o timore reverenziale.
Kenji Inoue, vecchia volpe nota ai più per il suo "Baka to test to shoukanjuu", dimostra tutta la sua esperienza e classe mischiando vari stili comici in quello che, a conti fatti, è un mix esplosivo di gran lunga superiore a tantissime serie di produzione recente.
La comicità di "Grand Blue" è fanciullesca, quasi primordiale, capace di pizzicare quelle corde primitive che ognuno di noi ha nell'animo e che ci porta a ridere come degli ossessi quando vediamo qualcuno cadere o un animale fare qualcosa di stupido. Un fragoroso richiamo alla slapstick comedy di miti eterni come Charlie Chaplin, capaci di far ridere grazie alla propria mimica e gestualità. E questa non è che la punta dell'iceberg.
Troviamo infatti richiami più che espliciti alla comicità irriverente e dissacrante dei Monty Python, soprattutto nelle scene in cui i protagonisti si lasciano andare, con nonchalance più assoluta, in situazioni totalmente assurde e senza pudore.
Anche il rapporto litigioso fra Iori e il suo compagno di scorribande Kohei è una enorme citazione ad un certo tipo di comicità chiassosa tipicamente giapponese di fine anni '70, su tutti "Urusei Yatsura" e i perenni battibecchi fra Ataru Moroboshi e Mendō Shūtarō.
Non mancano infine situazioni originali al limite del grottesco (chi ha parlato di furgoni?) e tantissime citazioni che lascio a voi il piacere di scoprire di puntata in puntata.
"Grand Blue" non è però solo comicità, ma anche il racconto di un sogno, il sogno di Iori.
Seppur inizialmente scettico, il nostro protagonista scoprirà gradualmente un mondo nuovo nascosto nelle profondità del mare che lo porterà, come un novello Jonathan Livingston, a ricercare quelle emozioni di cui si era privato per forse troppo tempo.
Tecnicamente la serie è lodevole, pur non brillando sempre per qualità, e lo studio Zero-G non credo meriti alcun rimprovero a riguardo. Azzeccatissime sono le musiche, sempre a tema e capaci di sottolineare perfettamente le surreali situazioni fra serio e faceto.
Discorso a parte invece per la regia, vera e propria miniera d'oro della serie, che in sole 12 puntate è riuscita a non perdere mai il confronto con la serie cartacea: tempi comici perfetti e superbo equilibrio fra momenti seri e quelli più irriverenti.
In conclusione, "Grand Blue" è una serie che merita ampiamente la visione e difficilmente deluderà anche lo spettatore più esigente. Una perla in questo turbolento mare chiamato stagione estiva.
Trasposizione dell'opera originale del duo malefico Kenji Inoue/Kimitake Yoshioka, "Grand Blue" è un complesso mosaico capace di mischiare, in modo quasi sempre convincente, una quantità spropositata di influenze e citazioni della cultura otaku e non.
La trama, in soldoni, vede il giovane Iori Kitahara trasferirsi a casa dello zio in modo da poter frequentare l'università di Izu. Speranzoso di vivere una vita piena di emozioni ed esperienze, Iori si ritroverà, senza capirne bene le dinamiche, a far parte del club di immersioni dove gli elementi "sopra le righe" non mancano.
La prima impressione data dalla serie è quella dell'immediatezza, un approccio quasi brutale con lo spettatore che viene letteralmente trascinato nei deliri narrativi della stessa. Un'immediatezza che mette subito le carte in tavola, senza alcuna vergogna di sorta o timore reverenziale.
Kenji Inoue, vecchia volpe nota ai più per il suo "Baka to test to shoukanjuu", dimostra tutta la sua esperienza e classe mischiando vari stili comici in quello che, a conti fatti, è un mix esplosivo di gran lunga superiore a tantissime serie di produzione recente.
La comicità di "Grand Blue" è fanciullesca, quasi primordiale, capace di pizzicare quelle corde primitive che ognuno di noi ha nell'animo e che ci porta a ridere come degli ossessi quando vediamo qualcuno cadere o un animale fare qualcosa di stupido. Un fragoroso richiamo alla slapstick comedy di miti eterni come Charlie Chaplin, capaci di far ridere grazie alla propria mimica e gestualità. E questa non è che la punta dell'iceberg.
Troviamo infatti richiami più che espliciti alla comicità irriverente e dissacrante dei Monty Python, soprattutto nelle scene in cui i protagonisti si lasciano andare, con nonchalance più assoluta, in situazioni totalmente assurde e senza pudore.
Anche il rapporto litigioso fra Iori e il suo compagno di scorribande Kohei è una enorme citazione ad un certo tipo di comicità chiassosa tipicamente giapponese di fine anni '70, su tutti "Urusei Yatsura" e i perenni battibecchi fra Ataru Moroboshi e Mendō Shūtarō.
Non mancano infine situazioni originali al limite del grottesco (chi ha parlato di furgoni?) e tantissime citazioni che lascio a voi il piacere di scoprire di puntata in puntata.
"Grand Blue" non è però solo comicità, ma anche il racconto di un sogno, il sogno di Iori.
Seppur inizialmente scettico, il nostro protagonista scoprirà gradualmente un mondo nuovo nascosto nelle profondità del mare che lo porterà, come un novello Jonathan Livingston, a ricercare quelle emozioni di cui si era privato per forse troppo tempo.
Tecnicamente la serie è lodevole, pur non brillando sempre per qualità, e lo studio Zero-G non credo meriti alcun rimprovero a riguardo. Azzeccatissime sono le musiche, sempre a tema e capaci di sottolineare perfettamente le surreali situazioni fra serio e faceto.
Discorso a parte invece per la regia, vera e propria miniera d'oro della serie, che in sole 12 puntate è riuscita a non perdere mai il confronto con la serie cartacea: tempi comici perfetti e superbo equilibrio fra momenti seri e quelli più irriverenti.
In conclusione, "Grand Blue" è una serie che merita ampiamente la visione e difficilmente deluderà anche lo spettatore più esigente. Una perla in questo turbolento mare chiamato stagione estiva.
I Pescatori di Mezzanotte
8.0/10
Recensione di Texhnolyze
-
Yoshihiro Tatsumi è il padre del Gekiga, una delle correnti fumettistiche più importanti del mondo del fumetto e che a ben guardare è più in voga ora che 60 anni fa. Questo è dovuto al fatto che la scoperta di questi autori del gekiga è avvenuta piuttosto tardi per l’occidente, grazie solo a qualche illuminato come Spiegelman, Igort, Mazzucchelli o Tomine, ma la vera ondata si è avuta quando purtroppo gli editori avevano già pubblicato un numero spropositato di manga di facile presa e il rapporto qualità – soldi facili iniziava a calare drasticamente. Ecco che in un ambiente colmo di operazioni commerciali si è avvertito il bisogno fisiologico di un’alternativa, sia da parte degli editori e sia da parte dei lettori, un vero cambio di rotta, che poi è proprio ciò che rappresentò il Gekiga in Giappone in quegli anni.
Questa raccolta edita dalla neonata Oblomov si rifà all’edizione singaporiana denominata Midnight’s Fishermen e da quel che ho potuto capire non ha un corrispettivo giapponese, ma in ogni caso si tratta di 9 capitoli pubblicati su rivista tra il ’72 e il ’73.
Come è solito fare del Gekiga queste sono storie che descrivono apertamente la situazione del Giappone di quegli anni, un Giappone che è riuscito a liberarsi dall’occupazione americana ed è riuscito ad emergere, a sfociare in quello che poi sappiamo essere “miracolo economico”.
Lo stesso Tatsumi ci spiega in un’intervista il suo scopo e la situazione di allora, quella che vedeva il Giappone come un gigante economico e come alla crescita delle grandi industrie corrispondesse un enorme accumulo di spazzatura, allo stesso modo la gonfia economia produceva i reietti della società. Tatsumi non ha dovuto fare altro che trasporre su carta le sue riflessioni e i suoi sentimenti.
Sebbene in queste storie non si concentri affatto su questioni etiche e sociali come il nucleare o la guerra ma solo ed esclusivamente sui reietti e sulla difficile gioventù, le storie – con queste pretese – sono chiaramente spietate e pessimiste.
Quello era un periodo in cui abbondavano le manifestazioni studentesche, vi era un vento freddo che soffiava da una guerra invisibile, ma anche intellettuale, in cui si pensava ai possibili cambiamenti, alla rivoluzione; l’aria urlava libertà, mentre i palazzi e le industrie toglievano spazio soffocando chi non era alto abbastanza per respirare liberamente perché, si sa, l’aria inquinata si ammassa sul fondo.
E’ proprio in questo ambiente che Tatsumi documenta le vite, la sopravvivenza, di questi disgraziati con un tratto sgraziato a prima vista, fatto di linee grosse al punto che sembrano un fardello talmente pesante da piegare i protagonisti e renderli gobbi. E’ tramite questo suo semplice stile che sonda questi atti disperati, ma attenzione a definirlo banalmente brutto in quanto è uno stile coerente e consapevole; la sottrazione ideata da Tatsumi e gli altri esponenti è tutt’altro che banale, infatti quando c’è la necessità di dettagliare ecco che i tratteggi si infittiscono.
Tutte le storie sono legate da un fattore comune, cioè l’impossibilità di risalita, è come se i reietti fossero finiti nelle sabbie mobili e non c’è una sola fune a tirarli fuori. Forse il capitolo finale, Il Pesce Lanterna, è quello che più di tutti ci fa capire ciò tramite il simbolismo del pesce in questione, che essendo abituato alle profondità marine è impossibilitato ad uscire fuori dall’acqua per via della differenza di pressione. Sebbene l’idea è nobile e raffinata, oltremodo azzeccata, devo constatare che tutto sommato il modo in cui scaturisce l’associazione è scontato e privo di quella sottigliezza necessaria a restituire qualcosa in più, per questo è anche giusto dire che non tutti i racconti sono ugualmente riusciti ma la differenza non è troppa.
I capitoli comunque sono abbastanza diversificati, nonostante si parli sempre di angoscia, stress, inadeguatezza, egoismo, povertà e indifferenza.
Quindi è possibile imbattersi anche in un capitolo dal sapore fantascientifico, tezukiano, con i robot che servono i vecchi ormai imbottiti di organi artificiali e sono così vecchi da non sapere più che lì fuori la tecnologia è andata così avanti da perdere ogni cognizione spazio-temporale, ma questo capitolo riflette anche sull’impossibilità di morire o di lasciare spazio ai giovani.
Il capitolo che invece dà il titolo al volume riassume perfettamente tutto, una coppia di truffatori arriva ad avere finalmente i soldi per cambiare vita ma questa decide di truffare uno dei 2 a sua volta sul più bello e l’altro, spaventato, non può che correre, correre.
Quello era un Giappone che, seppur in ascesa, sanguinava copiosamente, perdeva dei valori, ammassava i reietti e li spargeva in una Tokyo claustrofobica e cieca, come se quelli fossero dei buchi neri.
Ennesimo volume della collana da leggere.
Questa raccolta edita dalla neonata Oblomov si rifà all’edizione singaporiana denominata Midnight’s Fishermen e da quel che ho potuto capire non ha un corrispettivo giapponese, ma in ogni caso si tratta di 9 capitoli pubblicati su rivista tra il ’72 e il ’73.
Come è solito fare del Gekiga queste sono storie che descrivono apertamente la situazione del Giappone di quegli anni, un Giappone che è riuscito a liberarsi dall’occupazione americana ed è riuscito ad emergere, a sfociare in quello che poi sappiamo essere “miracolo economico”.
Lo stesso Tatsumi ci spiega in un’intervista il suo scopo e la situazione di allora, quella che vedeva il Giappone come un gigante economico e come alla crescita delle grandi industrie corrispondesse un enorme accumulo di spazzatura, allo stesso modo la gonfia economia produceva i reietti della società. Tatsumi non ha dovuto fare altro che trasporre su carta le sue riflessioni e i suoi sentimenti.
Sebbene in queste storie non si concentri affatto su questioni etiche e sociali come il nucleare o la guerra ma solo ed esclusivamente sui reietti e sulla difficile gioventù, le storie – con queste pretese – sono chiaramente spietate e pessimiste.
Quello era un periodo in cui abbondavano le manifestazioni studentesche, vi era un vento freddo che soffiava da una guerra invisibile, ma anche intellettuale, in cui si pensava ai possibili cambiamenti, alla rivoluzione; l’aria urlava libertà, mentre i palazzi e le industrie toglievano spazio soffocando chi non era alto abbastanza per respirare liberamente perché, si sa, l’aria inquinata si ammassa sul fondo.
E’ proprio in questo ambiente che Tatsumi documenta le vite, la sopravvivenza, di questi disgraziati con un tratto sgraziato a prima vista, fatto di linee grosse al punto che sembrano un fardello talmente pesante da piegare i protagonisti e renderli gobbi. E’ tramite questo suo semplice stile che sonda questi atti disperati, ma attenzione a definirlo banalmente brutto in quanto è uno stile coerente e consapevole; la sottrazione ideata da Tatsumi e gli altri esponenti è tutt’altro che banale, infatti quando c’è la necessità di dettagliare ecco che i tratteggi si infittiscono.
Tutte le storie sono legate da un fattore comune, cioè l’impossibilità di risalita, è come se i reietti fossero finiti nelle sabbie mobili e non c’è una sola fune a tirarli fuori. Forse il capitolo finale, Il Pesce Lanterna, è quello che più di tutti ci fa capire ciò tramite il simbolismo del pesce in questione, che essendo abituato alle profondità marine è impossibilitato ad uscire fuori dall’acqua per via della differenza di pressione. Sebbene l’idea è nobile e raffinata, oltremodo azzeccata, devo constatare che tutto sommato il modo in cui scaturisce l’associazione è scontato e privo di quella sottigliezza necessaria a restituire qualcosa in più, per questo è anche giusto dire che non tutti i racconti sono ugualmente riusciti ma la differenza non è troppa.
I capitoli comunque sono abbastanza diversificati, nonostante si parli sempre di angoscia, stress, inadeguatezza, egoismo, povertà e indifferenza.
Quindi è possibile imbattersi anche in un capitolo dal sapore fantascientifico, tezukiano, con i robot che servono i vecchi ormai imbottiti di organi artificiali e sono così vecchi da non sapere più che lì fuori la tecnologia è andata così avanti da perdere ogni cognizione spazio-temporale, ma questo capitolo riflette anche sull’impossibilità di morire o di lasciare spazio ai giovani.
Il capitolo che invece dà il titolo al volume riassume perfettamente tutto, una coppia di truffatori arriva ad avere finalmente i soldi per cambiare vita ma questa decide di truffare uno dei 2 a sua volta sul più bello e l’altro, spaventato, non può che correre, correre.
Quello era un Giappone che, seppur in ascesa, sanguinava copiosamente, perdeva dei valori, ammassava i reietti e li spargeva in una Tokyo claustrofobica e cieca, come se quelli fossero dei buchi neri.
Ennesimo volume della collana da leggere.
I collegamenti ad Amazon fanno parte di un programma di affiliazione: se effettui un acquisto o un ordine attraverso questi collegamenti, il nostro sito potrebbe ricevere una commissione.




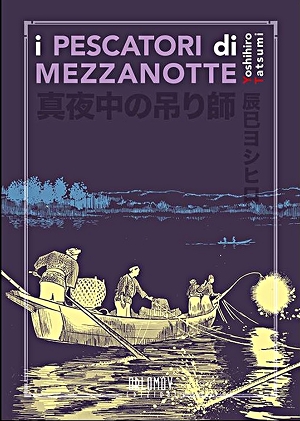











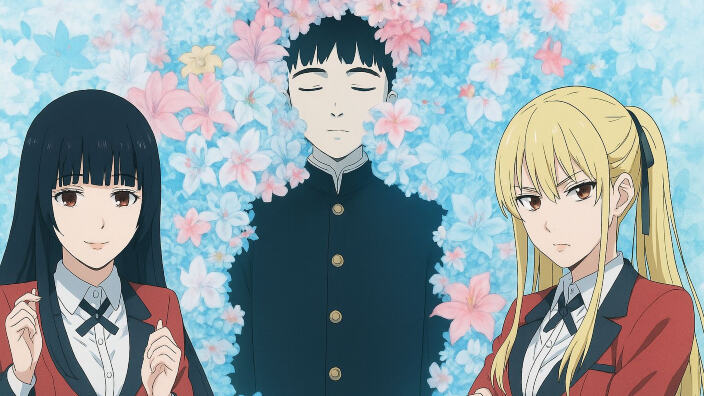


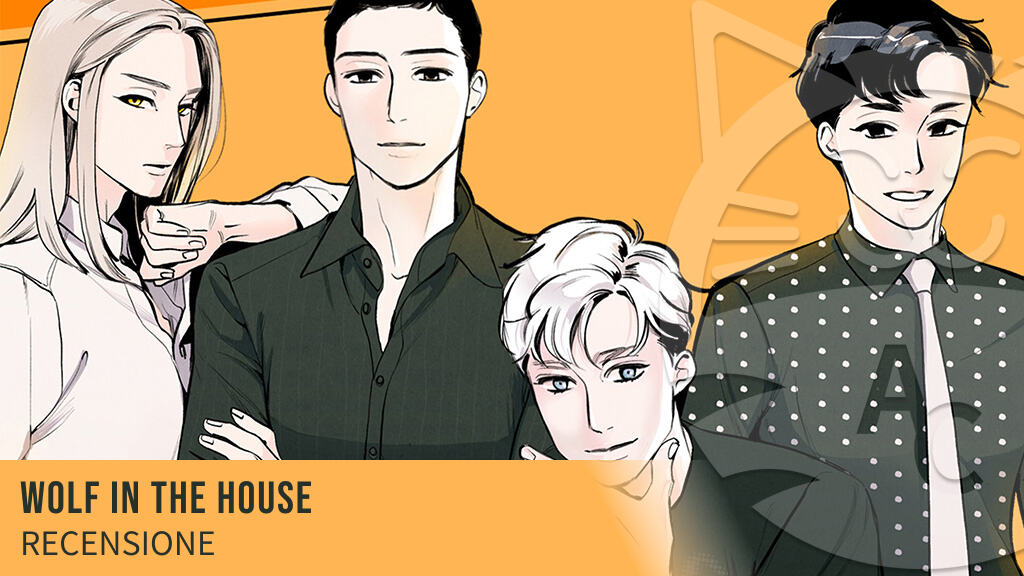




Eri pure ubriaco come fanno inutilmente ogni 3X2 in quella trashata?
Per la comicità prenderebbe 10 a prescendire, ma ci sono anche altri criteri da valutare in generale in un anime ed è normale poi che il voto scende notevolmente.
Nella mia recensione ho dato 5.
Complimenti per le recensioni!
Non capisco perché ne parli come se l'altra rubrica fosse stata sostituita da questa, se non mi sono perso niente entrambe vanno avanti indipendentemente da un sacco di tempo
So che è ancora presente, ma dal momento che la rubrica Animering non si vede quasi mai e alcune volte viene utilizzata per i manga (cosa comunque molto gradita dal sottoscritto) sembra quasi come se non ci fosse, perchè non avendo un appuntamento fisso settimanale può capitare facilmente che si perda (basta non accedere al sito proprio quel giorno) e quindi può capitare che passino diverse settimane (anche mesi) prima di ribeccarla. Non so tu, ma ci sono diverse rubriche che aspetto settimanalmente, so quando escono e mi collego al sito per visualizzarle. Un Animering e un Mangaring a cadenza settimanale, sarebbe molto più interessante secondo me...possibile che mi sbaglia, ho solo espresso una mia idea.
Non voglio screditare o accreditare una o l'altra rubrica, entrambe le trovo interessanti ma questa come già detto lascia il tempo che trova.
Non parlo a livello di divertimento o altro, parlo proprio di principio...entrambi gli anime mettono in secondo piano la storia prediligendo altro e riescono più o meno a ottenere lo stesso effetto sul pubblico...devo pensare che DB vada bene perché si è fatto un nome mentre Grand Blue no perché "è l'ultimo arrivato"? O.o
Grand Blue è anche un anime Slice of Life quindi fa il suo dovere al meglio, descrive come passano le loro giornate o protagonisti...esistono persone reali che fanno lo stesso nella realtà quindi l'opera ha pure un fondo di verità!
Il fatto che faccia ridere o meno è una questione meramente soggettiva, i gusti son gusti...ma dire che DB ha una trama originale e interessante molto ben sviluppata quando mostra più o meno le stesse cose di GB e la profondità di un foglio di carta sacrificata per mostrare solo combattimenti faighi criticando GB di essere scadente e poco originale quando in altri modi fa lo stesso di DB mi pare proprio una gran boiata detta solo per sputtanare un'opera perchè sì...ho visto molta gente fare così in giro per il web, che almeno abbiano la coerenza di non trattare quello che per loro sono i difetti di un'opera come i pregi di un'altra quando sono presenti anche in essa! >. <"
E ora, scusate, ma devo prepararmi a immergermi in un Grand Blue di dislike! XD
Io 8.5, mi sono mantenuto basso
Secondo me date un po' troppa importanza al valore del voto, alla fine quello è un giudizio personale, ci sta che in alcuni casi la si possa pensare in un altro modo, lo scopo della rubrica in fondo è anche quello di stimolare il confronto tra chi la pensa diversamente, basta farlo con educazione nel caso...
No e perchè, mi piace come hai evidenziato i punti positivi di Gran Blue! Non mi piace che abbia dovuto usare Dragon Ball come paragone negativo per farlo
Io credo che entrambe le rubriche siano molto interessanti in quanto mi spingono e invogliano a scrivere sempre più recensioni. Per due volte è uscita una mia recensione su questa rubrica e sono stato felicissimo di ascoltare pareri positivi e negativi su di essa, senza parlare poi del fatto che prendere dei mi piace non può essere che motivo di soddisfazione per me, che mi spinge a migliorare nella scrittura e soprattutto a non mettere mai da parte l'idea di realizzare una nuova recensione quando vedo un anime ^^
Visivamente è un piacere per gli occhi, ha uno stile davvero unico ed affascinante. La storia è immersa in un'atmosfera poetica ed evocativa legata alla mitologia irlandese, e i sentimenti dei personaggi sono rappresentati con il giusto tocco di realismo, quanto basta perché arrivino dritti al cuore.
Forse leggere la trama trae un po' in inganno, chi è interessato principalmente al viaggio avventuroso dei protagonisti potrebbe rimanere deluso. Ma per chi invece apprezza le storie fiabesche, delicate e malinconiche, questo piccolo capolavoro è assolutamente consigliato.
I volumi di Tatsumi sono uno più bello dell'altro, ormai lui e Tsuge sono gli unici che riescono a farmi comprare i costosi (ma eleganti, indubbiamente) volumi Coconino/Oblomov. Una miniera di racconti di eccellente fattura.
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.