Una volta Zhuang Zi sognò d’essere una farfalla, che volava qua e là, felice di se stessa, e senza sapere d’essere Zhuang Zi. Quindi si svegliò, e gli sembrava d’essere, senza dubbio, Zhuang Zi. Ora però non sapeva piú se fosse Zhuang Zi che aveva sognato d’essere una farfalla, o una farfalla che sognava d’essere Zhuang Zi.
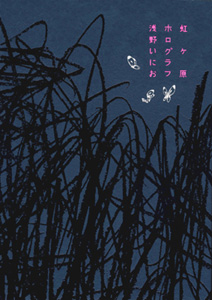 La farfalla è il sogno. Sogno che confonde, sogno maligno, allucinazione che risucchia nel proprio gorgo, che imprigiona in un labirinto privo d’uscita verso una Realtà ormai perduta.
La farfalla è il sogno. Sogno che confonde, sogno maligno, allucinazione che risucchia nel proprio gorgo, che imprigiona in un labirinto privo d’uscita verso una Realtà ormai perduta.La farfalla è un segno, è segnale. Segnale che il confine tra concreto e impalpabile è stato varcato, che sogno e realtà andranno collassando l’uno nell’altra, senza rimedio. È cosi che la farfalla ancora oggi vola, compare e svanisce, nell’immaginario dell’Asia Orientale. E anche in Giappone. Anche in anime e manga, quelli più e meno noti: è la farfalla che muove molli le ali nell’estate eterna di Lamú – Beautiful Dreamer (primo vero lungometraggio di Oshii Mamoru); è la farfalla che, a stormo, splende nel buio dell’ossessione nel film di Cowboy Bebop; è la farfalla che svela il torbido orrore ne Il vampiro che ride; è la farfalla del desiderio perverso e dell’imbroglio temporale nel film di Utena; è la farfalla che compie le sue incursioni, sottili e poi inarrestabili e frenetiche, in Paranoia Agent e in Paprika.
È la farfalla che ora solitaria nella notte, ora in coppia, ora in innumerevoli stormi lucenti, va intessendo, ingarbugliando e poi dipanando la trama de Il campo dell’arcobaleno...
Waking Life
Il sogno è elusivo, il sogno è ricordo deforme, desiderio inconfesso e terrore nascosto (è l’incubo). Il sogno è frammento di frammenti.
Il campo dell’arcobaleno procede per frammenti, Asano Inio li raccoglie quando la storia è già esplosa e cosi ce li consegna, sparsi, lasciando a noi il compito di ritrovarne il disegno.
E l’autore non sovrappone la sua voce agli eventi.
Il campo dell’arcobaleno è privo di commenti e quasi di didascalie; non ingannino le abbondanti voci fuoricampo: sono quasi sempre solo i monologhi, brevi e privi di filtri, di uno dei due protagonisti.
Suzuki, intorno ai dieci anni.
Suzuki, intorno ai dieci anni, si è lasciato alle spalle la scuola e il bullismo di cui era vittima, che l’aveva spinto giù dal tetto dell’edificio. E miracolosamente s’era salvato. Ma sulle spalle porta ancora e a lungo dovrà portarlo un disastro familiare fatto di abbandono e trascuratezza e mancanza di legami e di affetto. Dei genitori di Suzuki non ci viene mai mostrato il volto, non ci è concesso vederlo. Presenze rimosse, forse perché assenze o forse perché impossibili da affrontare (oggetti ambigui e irrisolti d’amore e d’odio).
Suzuki, intorno ai vent’anni.
Suzuki, intorno ai vent’anni, torna nella cittadina dove ha visto più che vissuto quei frammenti della sua infanzia.
Suzuki, che, possiede una scatoletta di latta in grado di esaudire un unico desiderio, in grado di dare il via alla Fine del Mondo.
Suzuki, l’unico personaggio di cui non sapremo, quasi fino all’ultima pagina, il nome proprio. Di cui non vedremo quasi nulla della vita da adulto, a differenza degli altri. Possiamo immaginarcela, forse, serena. Almeno per lui.
Frammenti di tempo
Il piccolo Suzuki vittima di bullismo, vittima di una famiglia disastrata, di una vita già alla deriva quando l’infanzia deve ancora concludersi? Vittima innocente di una vita crudele, di compagni di classe malvagi, di adulti indifferenti, insensibili, assenti?
Non proprio. Ne Il campo dell’arcobaleno il confine tra vittime e carnefici non è mai netto; anzi, va costantemente e più volte rovesciandosi mentre i personaggi trascorrono nel tempo, nei mesi, negli anni e i decenni. Suzuki stesso impara presto ad adattarsi alla sua nuova classe e alle nuove crudeltà, a osservare con indifferenza un bullismo che, ora (almeno inizialmente), non colpisce più lui, impara a starne fuori (e a farsene complice per mancato intervento); e noi osserviamo insieme a Suzuki che anche il goffo e lento Takahama, bersaglio della violenza, sa fare le sue carognate e che in parte è egli stesso complice delle persecuzioni subite; e osserviamo il fallimento di quella retorica del mondo adulto (dei genitori, della scuola) che cercano un buono da proteggere e un cattivo da punire ma intanto fa più danni di quanti ne eviti.
Il mondo de Il campo dell’arcobaleno è intriso di malessere, violenza e crudeltà. Violenza che esplode brutale, figlia del desiderio di possesso e di piacere; o anche senza alcuna ragione precisa: violenza fine a sé stessa. Ma prima ancora c’è la violenza strisciante e silenziosa, insidiosa, sottesa, che permea i gesti più quotidiani, i gelidi rapporti tra adulti, le necessità della vita quotidiana, della sopravvivenza economica, della ricerca frustrata d’affetto. Violenza nascosta nei dettagli, appena accennata, allusa dove meno la si saprebbe (o vorrebbe) vedere: il livido casualmente mostrato sulla spalla di una bimba, forse segno di violenza familiare (e chissà se da parte di padre e di madre); il bullo della classe picchiato dal maestro per “fini educativi”. E così via.
Il flusso vischioso dei rapporti umani scorre nel tempo ed è anche così che le posizioni di vittima e carnefice si scambiano con facilità. Nei mesi, negli anni e i decenni. I bambini crescono, i giovani maturano(?), i ricordi sbiadiscono, le persone mutano. Il bulletto gregario si ritrova con la divisa da poliziotto, a difesa dell’ordine pubblico. Il ragazzino sognatore e solitario si trasforma nel maniaco violentatore e alienato. Il capo dei bulli della classe, perso nei suoi fantasmi mentali, diviene un omicida forse in cerca di un impossibile riscatto. L’insegnante bonario e perbene si rivela un ricattatore e truffatore avido, cinico e meschino. L’amore giurato come eterno scivola in uno squallido divorzio. E così via, e così via. Non ci sono eroi, ne Il campo dell’arcobaleno; solo frammenti di personaggi trascinati in un vortice temporale scomposto.
È proprio frantumando la narrazione che Asano può estrarre a suo agio dal flusso continuo del tempo i diversi momenti, giustapponendoli per suggestione, e smascherando così l’inanità di sogni, e speranze, e illusioni; con cinico disincanto e sommessa disperazione Asano fa collidere tra loro le diverse fasi del tempo, dell’infanzia, della giovinezza, dell’età adulta, mostrandoli per quello che sono, polvere trascurabile.
In questo complesso quadro temporale i personaggi si sfiorano, si incontrano, si scontrano, trascinati in un gioco caleidoscopico su cui non hanno alcun controllo. Più che vivere la vita, la subiscono; alcuni di loro, di tanto in tanto, ne afferrano le occasioni che emergono in superficie, sperando che non portino ulteriori rovine (il rischio è sempre alto).
È un microcosmo in cui ognuno, per usare le parole di una dei personaggi, deve “vivere la propria vita con sotto i piedi le condutture delle fogne”. E dentro alle fogne c’è il mostro, un mostro oscuro che vive dentro ogni personaggio, che ognuno nutre e coccola dentro di sé, pregando che non esca alla luce.
Il sogno della farfalla
Il campo dell’arcobaleno è un doppio sogno.
Di Suzuki sappiamo quasi tutto, siamo quasi perennemente posti nella sua soggettiva, quasi impossibilitati a uscirne (perché è un sogno senza risveglio). Dell’altra sognatrice non sappiamo quasi nulla. Come dei genitori di Suzuki, anche di Kimura Yue non vediamo (quasi) mai il volto. Kimura Yue, persa nel sogno farmacologico del letto d’ospedale è uno dei due fuochi intorno a cui orbitano tutti gli altri personaggi e la narrazione; ma Kimura è un nucleo vuoto, invisibile, un buco nero oltre il cui orizzonte degli eventi non ci è consentito sbirciare. La conosciamo solo per sottrazione.
Forse lei è l’unica vera vittima della vicenda, ma è tale perché assente, perché impossibilitata ad agire, come se solo l’incoscienza (o la morte) permettessero l’innocenza perfetta. E allora si capisce perché sia tanto forte, in questo fumetto, l’ansia che arrivi, prima o poi, la Fine del Mondo, a cancellare ogni cosa. Perché il Mondo de Il campo dell’arcobaleno, è duro da sopportare, è un continuo dare e ricevere dolore, e accumulare colpa. E se la Fine del Mondo non viene, allora è il sogno, è trasfigurare la realtà in allucinazione che diventa quasi un’amara via di fuga.
Kimura, la sognatrice del Mondo, è essa stessa un sogno, un angelo candido e immacolato, tanto pura da diventare essa stessa oggetto d’odio profondo da chi la circonda o di desiderio morboso. Da possedere o da distruggere.
Certi bambini
C’è un genere trasversale, riconoscibile e diffuso ormai un po’ in tutto il mondo e in tutti i media: romanzi, televisione, cinema. Soprattutto certo cinema italiano. E poi fumetti. Anche quelli giapponesi. Quelli meno noti. Il campo dell’arcobaleno è stato pubblicato a puntate dal 2003 al 2005 sul magazine Quick Japan di Ohta Publishing.
Un genere trasversale e internazionale.
Storie di vita vissuta, di crudeltà quotidiane e straordinarie, di normalità degradata, storie d’attualità, più o meno impegnate, più o meno impregnate di critica sociale: esibire i mali della modernità, del mondo in cui viviamo. A metà tra catarsi e denuncia, i protagonisti sono spesso bambini e ragazzini, vittime ideali di un mondo adulto cinico e senz’anima. Inutile dire che gli scivoloni retorici sono più la regola che l’eccezione. Più che altro perché la ripetizione ossessiva, per quanto sentita e sincera, diventa presto manierismo scadente ed effimero, al servizio alla moda mediatica del momento. E la denuncia s’adagia su stereotipi giornalistici dando l’illusione d’una critica che sotto sotto è non poco conformista.
E Asano e il suo Il campo dell’arcobaleno? Riescono a trarsi in salvo da banalità e didascalismo? Non inganni l’apparente fredda analiticità del racconto. La voce dell’autore è quasi assente, l’intreccio è un ingranaggio misuratissimo e dal ritmo perfettamente calcolato. Leggerlo una volta non basta (ma nemmeno due), perché il primo impatto può disorientare; ma c’è da fidarsi: tutto torna perché gli incastri sono calcolati al millimetro. Le poche residue zone d’ombra risaltano ancor più per contrasto, anch’esse ingegnosamente previste.
Ma anche la neutralità, la freddezza e l’analiticità sono scelte. Il silenzio è anch’esso una voce. La mancanza di un commento dell’autore che giudichi è già esso un giudizio.
È per altri motivi che Il campo dell’arcobaleno riesce a non cascare nel flusso anonimo di altri prodotti di “denuncia sociale” buoni per una stagione e poi via. È la magistrale orchestrazione della sua struttura narrativa a farlo brillare, a lanciare la sfida al lettore. E a permettere all’autore di non rimanere sulla superficie del gioco, ma di elaborarlo in profondità, lavorando con le forme della narrativa disegnata per mostrare senza interventi importuni (perché l’autore ha creato tutto ex novo, ma poi s’è nascosto dietro le quinte, lasciando la macchina a funzionare da sola) una realtà fatta di alienazione e malessere; e d’ipocrisia diffusa, di comunicazioni mancate, di desiderio di fuga e dell’attesa di un qualche impossibile risveglio, al contempo desiderato e temuto.
Non si può avere tutto
L’edizione italiana? Un inusuale ampio formato: le pagine grandi permettono d’apprezzare appieno il tratto e la costruzione delle tavole di Asano. Copertina d’impatto, che riproduce esattamente quella originale. Dialoghi italiani discreti. Le onomatopee, com’è ormai “tradizione” Planet Manga, lasciate in originale: scelta discutibile, ma che alcuni lettori apprezzano.
A conti fatti il prezzo, non certo basso (9,90 euro) risulta sopportabile. Anche perché Il campo dell’arcobaleno non è un fumetto usa e getta. E non mira a un pubblico chissà quanto ampio (anche se lo meriterebbe).
Peccato che... peccato che l’opera di Asano ci venga consegnata in maniera un po’ brutale, senza neanche uno straccio di introduzione, di postfazione. Almeno qualche riga ci sarebbe stata: sull’autore, su chi è, su cos’ha fatto, su cosa ci apprestiamo a leggere o su cosa abbiamo appena letto. E invece niente. Peccato. Sarà per un’altra volta?
Autore: Yupa


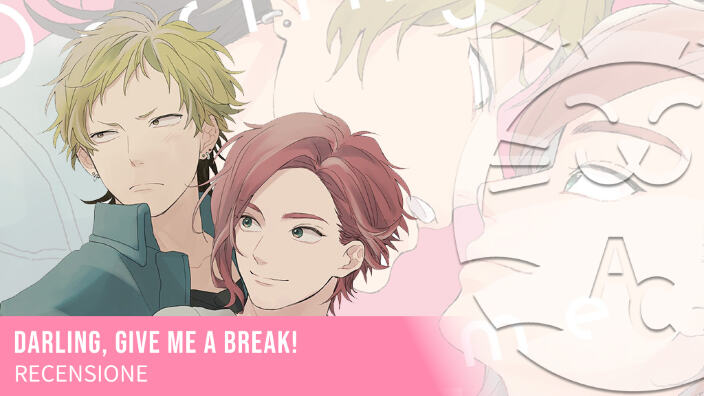

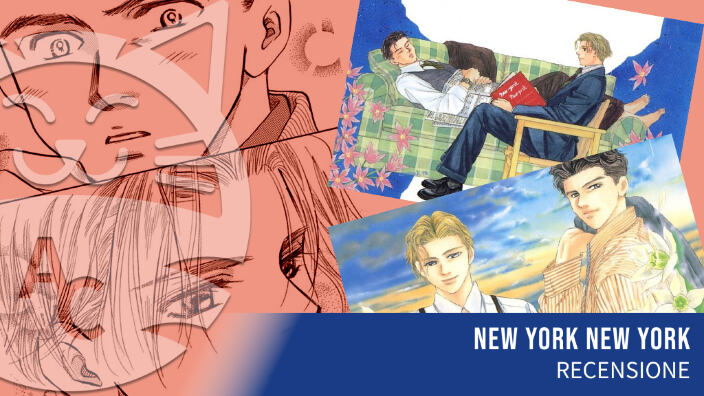
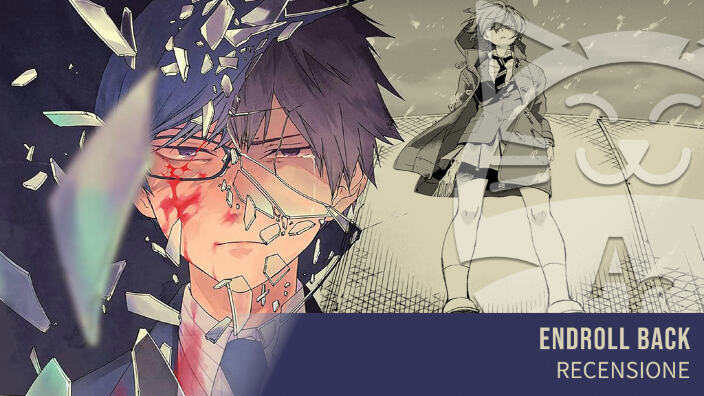
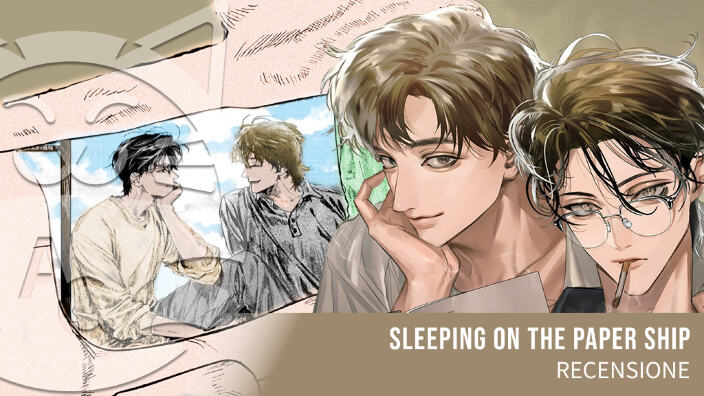
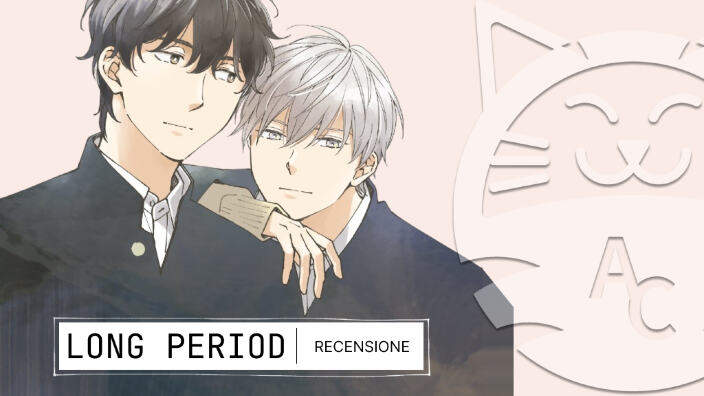

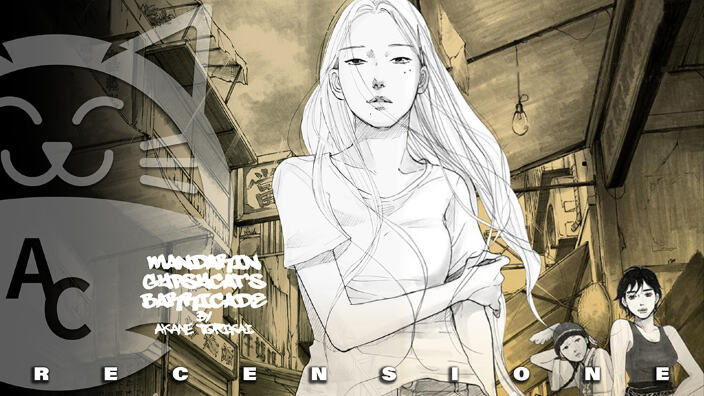

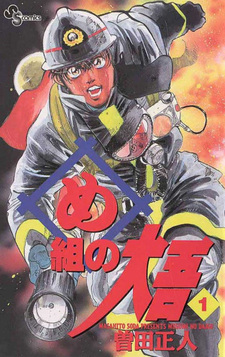
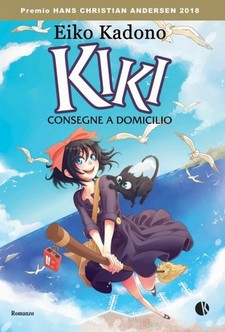
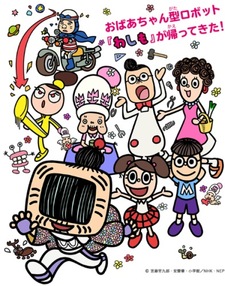
Cosa peraltro che è solamente di facciata, l'opera è inserita all'interno di un sistema di causa-effetto ben chiaro, con i personaggi che si muovono per eseguire questi punti chiave, ecco perché ci si trova un po' spiazzati nel leggere di Komatsuzaki (il bullo) che compie omicidi per "espiazione", è interpretazione sì, legittima sicuramente, ma forzata, l'unica cosa certa è che il suo operare è vincolato da un aspetto "metafisico" che è stato parecchio sottaciuto in questa recensione.
E che invece permane in tutte le azioni dei personaggi, caratteristica - inoltre - tipica della letteratura nipponica.
Fermo restando che la recensione appare gradevole e piacevole ;P
In una parola seguo alla lettera la storiella cinese. Suzuki e la farfalla in filosofia si direbbero manifestazioni diverse della medesima realtà esistente (non di quello che accade o sembra accadere). C'è la fantasia dell'autore a mettere il dubbio su quale delle due manifestazioni abbia iniziato a sognare l'altra. O se stiano sognando parallelamente (se l'essere è immutabile, tutte le sue espressioni possono coesistere senza modificarne la sostanza -sembra una lezione di teologia). Vabbe'... poi è solo una delle possibili interpretazioni.
Molto interessante il tuo commento, ci ripenserò quando rileggerò (spero presto!) per l'ennesima volta il volume di Asano.
Due sole cose:
1) Non so se Asano abbia voluto dare una chiave univoca di lettura al suo fumetto. Preferisco pensare che, com'è con le opere migliori, Il campo dell'arcobaleno sia leggibile in più modi, tutti con diversi (o uguali) gradi di legittimità: possiamo leggerlo come il dispiegarsi di un sogno (ovvero una realtà possibile, come tu dici) di un individuo che col suo sogno crea il mondo; ma anche come una rappresentazione cruda e problematica del reale, distorta in allucinazione da chi la vive in maniera alienata. Lo sguardo soggettivo dell'autore oscilla tra questi due poli e ci trascina con sé, senza fermarsi in maniera decisiva.
2) Continuo a essere convinto che Il campo dell'arcobaleno non sia semplicemente il sogno di Suzuki, ma un doppio sogno: Suzuki e Kimura. E questo mi pare chiaramente segnalato dall'autore. Ad esempio, nelle primissime tavole sono loro che vediamo nascere, e poi sono due le farfalle che vediamo volare. C'è la farfalla che si posa sulla testa di Suzuki, ma anche sulla targa che in ospedale porta il nome di Kimura c'è una farfalla...
Un doppio sogno, ovviamente paradossale come tutti i doppî sogni.
Ci saremmo dimenticati anche lo scorcio in cui la madre dice di aver sognato di essere farfalla e di aver seguito gli avvenimenti futuri, ma rischiamo di sognarcele la notte tutte ste farfalle. Pattiamo che il messaggio finale è positivo e che c'è un personaggio uno e trino (che ha avuto pure culo a cascare da una terrazza senza farsi troppo male).
^^
per quanto riguarda il finale come lo interpreti? alla fine siam chiaramente fuori dal sogno--tant'è vero che Amahiko si mette a piangere, a mo' di valvola di sfogo dopo tutto quel marciume che s'è sognato.
(tra l'altro c'è uno strano parallelismo: "tieni una salda forza di volontà" detto dall'Amahiko vecchio così come da Higure dopo l'episodio dell'incendio.... sembra quasi una contaminazione del sogno nella realtà, similmente a mulholland drive--pur funzionando di fatto al contrario).
alla fine si vede che Amahiko giovane non "vede" bene il vecchio, quindi potrebbe essere chiunque, e alla fine scompare pure e si vede una farfalla. Forse è un finale volutamente "labile" a livello di interpretazioni, ma vorrei comunque sapere la tua.
forse sto sovrainterpretando, ma la cosa regge a mio modo di vedere, se non fosse per il finale che si vede la famigliola felice con i 2 bimbi distinti. Ma si può benissimo considerare in ottica onirica pure quel passaggio.
Su Yue e sulla famigliola a sto punto sarebbe meglio rompere le palle direttamente ad Asano andandogli a bussare sotto casa: quando la madre dice che non sarà la fine del mondo ma l'inizio dell'eternità, intende che la storia si ripete inalterata all'infinito o ammette una qualche variante? E il dio che le ha detto di essersi stancato e che tutti spariranno è un richiamo alla fine del sogno?
Comunque sì, se ammetto che tutto sia la proiezione di un futuro possibile, allora la figura del vecchio è il sogno che sfuma nella realtà, come postumo di una sbornia fantastica.
In alternativa, siamo fumati del tutto (ma questa è una certezza).
Tornando a bomba su Yue, è parecchio interessante il fatto che Amahiko la immagini in coma, coma, in seguito a un'esperienza -come la sua- (la caduta). Come per volerla mettere a tacere mentre stava cadendo dal tetto della scuola, dicendo a sè stesso "ahò, tanto sto a morì, chissenefrega a sto punto delle belle cose" (banalizzo).
il risveglio di Yue e il ricongiungimento col fratello sono, temporalmente, gli ultimi eventi del sogno (la "fine" del sogno), escludendo l'epilogo non si vede un futuro più "futuro" di quello (e temporalmente la storia di amahiko arriva lì, non oltre). Morale della favola.... imho è il risveglio di Amahiko dopo che s'è immaginato una nefandezza dopo l'altra (evidentemente avendo le basi per immaginarsele). Però poi dio/sè stesso gli offre una scelta, sotto forma di scatoletta, incoraggiandolo e spronandolo a darsi da fare e non rimanere vittima dell'inedia com'era nel sogno ("in questa maniera vergognosa continuerò a vivere?").
e secondo me non siam tuonati, il manga offre basi concrete su cui intavolare certe discussioni. Saremmo tuonati se facessimo discorsi simili su naruto, per intenderci
La scatola mi ha fatto pensare dall'inizio alla storia di Urashima Taro: finché Suzuki la tiene chiusa lui della sua vita può fare quello che vuole; se le sue scelte o la realtà non lo soddisfano basta aprirla perché abbia inizio un lento sgretolamento del mondo-sogno (come per Taro questo prevede un ritorno alla realtà precedente, ma con un processo inverso all'invecchiamento istantaneo). Ad averne di scatole così...
propormi un'opera non facile come questa senza introduzione (magari con qualche nota in più sull'autore) vuole dire sopravvalutarmi (me, il mio tempo e la mia capacità di analisi).
per fortuna ci sono il vostro sito e lo spazio per il dibattito (che reputo molto importante per aiutarmi a capire) e per fortuna c'è kenzotenma che (come al solito
alla prima lettura l'opera non mi ha convinto. ma sinceramente tutte le analisi che avete fatto me l'hanno fatta rivalutare e la rileggerò.
grazie ancora
Non mi sbilancio ancora in analisi particolarmente approfondite poiché si tratta di un'impresa non facile da sostenere (e sopratutto bisogna avere molto tempo per argomentare tesi complicatissime, come avete fatto in molti).
Mi è sembrato che l'opera giochi molto sul dualismo, o meglio, su una sorta risoluzione degli opposti.
Ognuno di noi è sé stesso e parte di un tutto infinito ed eterno. Ognuno di noi è realtà ed è sogno. E' sé stesso e farfalla. E' Yue e Suzuki. Uomo e donna. E' vittima e carnefice. E' padre e figlio. Giovane e vecchio. Dio e uomo. Causa ed effetto.
Ma sopratutto, ognuno di noi è incredibilmente disturbato ed mostruosamente disumano, nel suo essere perfettamente umano.
Il tutto in una società dove lo scontro tra i nostri molteplici IO viene acuito sempre più fino alla rottura di quella corda tesissima. E allora giungerà fine del mondo.
per ora posso dire mooooolto bello, ma veramente tanto.
so concorde nel dire che la presenza di un'introduzione sarebbe stata molto utile e gradevole.
vorrei aggiungere:
ho comprato il volume e come mio solito guardo subito come è la copertina sotto la sovracopertina.... sovracopertina nera che mette molta malinconia... la copertina è rosa
penso che questo dia l'idea di come possa essere complesso il volume (perlomeno a me la messo subito in chiaro ^^)
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.