Riportiamo da LoSpazioBianco.it una parte dell'interessante analisi di Marco Pellitteri, direttore scientifico delle collane di saggistica della Tunuè, sulla situazione del mondo del fumetto e dell'editoria italiana. Rimandiamo all'articolo originale per i restanti punti.
---------------------------
Questo è un cahier de doléances. Un elenco di undici «cose» che, secondo me, a vario titolo fanno male al fumetto in Italia. Non a tutto il fumetto, naturalmente, ma a quei tipi di fumetti che da almeno una di queste cose sono toccati più o meno pesantemente; e non solo i fumetti ma «il fumetto» come sistema e settore culturale.
Sono solo undici… so che ce ne sarebbero molte altre. È inoltre possibile che non tutti i punti di questo elenco trovino d’accordo chi li leggerà: essi rappresentano la mia personale prospettiva. Ho cercato di argomentarli in modo ragionevole, sebbene nella sintesi.
La sequenza di questi punti si è formata a mano a mano che mi venivano in mente gli elementi che ritengo dolenti. Dunque essa è «casuale», perché a posteriori non ritengo che il punto 1 sia più problematico del punto 8 o che il punto 3 lo sia meno del punto 2. Al lettore il compito di formulare la sua graduatoria fra questi ed, eventualmente, altri punti critici. A differenza delle canoniche liste di lamentele, tuttavia, ho cercato qui di fornire almeno in alcuni casi, sempre in termini sintetici, qualche elemento costruttivo.
1. Gli uffici stampa delle case editrici di fumetti
La maggior parte delle case editrici di fumetti in Italia non possiedono un ufficio stampa capace di svolgere il proprio lavoro in modo «normale», cioè quotidianamente, usando gli strumenti di cui gli addetti stampa delle aziende solitamente si avvalgono: il telefono, il cellulare, il fax, l’e-mail, la rubrica telefonica, i biglietti da visita, gli elenchi telefonici cartacei e on-line, il direct mailing digitale, il rilascio settimanale di comunicati stampa fra loro coordinati. Si tratta di una situazione molto critica per due ragioni: la maggior parte delle case editrici di fumetti italiane non hanno il budget, o sostengono/ritengono di non averlo, per assumere uno o due addetti stampa capaci di svolgere questo mestiere a tempo pieno, in modo da generare dibattito sui titoli della casa editrice e vendita di copie; si rivolgono pertanto ad addetti stampa inesperti, poco noti ai giornalisti, con una rubrica di contatti nei media scarsamente nutrita, con le idee non proprio chiare sulle dinamiche del mestiere e che il più delle volte si dedicano all’attività promozionale in modo non continuativo durante la settimana; ma d’altro canto i compensi che gli editori si sentono di voler/poter proporre a tali addetti stampa – quando ciò avviene – sono sovente risibili, il che livella verso il basso, automaticamente, sia la qualità del servizio, sia l’età e l’esperienza di chi sarà disposto ad accettare determinate condizioni retributive, sia la motivazione nello svolgere tali mansioni promozionali.
Per risolvere questo problema, che danneggia innanzitutto gli introiti degli editori, dal momento che un editore senza un ufficio stampa è un soggetto invisibile al di fuori del ristretto circolo dei lettori abituali di fumetti, occorrerebbe una mentalità realmente imprenditoriale, la stessa che manca affinché, per esempio, quegli stessi editori si dotino di un esperto di marketing aziendale o di traduttori e supervisori attenti (si vedano i punti seguenti).
Un ultimo elemento d’interesse è l’uso mistificante che viene attualmente fatto della comunicazione via internet. Aggiornare il sito internet dell’editore va bene, ma cercare di acquisire contatti sui social network sta assumendo troppo peso nella giornata lavorativa degli addetti agli uffici stampa: le pagine di una casa editrice su di un social network sono frequentate soprattutto da persone che o ruotano intorno alla casa editrice o che comunque già la conoscono, e non sono granché utili ad acquisire nuovi acquirenti. Sarebbe ora che i giovani addetti stampa si svegliassero e capissero che per vendere i libri ci vuol altro: il web è uno strumento formidabile per trovare nuovi lettori/acquirenti, ma bisogna saperlo usare.
2. Affidarsi a traduttori inesperti, o disattenti, o poco motivati, o…
Il tradurre prevede la conoscenza della lingua da cui si traduce, certamente; ma ancor di più prevede la conoscenza approfondita della lingua verso cui si traduce e, inoltre, la capacità previa di saper scrivere bene nell’idioma di destinazione.
Malgrado alcune indubbie eccellenze (basti pensare al lavoro di Andrea Plazzi sulle opere di Will Eisner), non pochi traduttori e traduttrici che traducono fumetti da altre lingue in italiano a me paiono a volte scarsamente capaci di esercitare con costanza la dovuta attenzione su ciò che cercano di rendere in italiano a livello sia semantico, sia lessicale, sia sintattico.
Per un lettore adulto di cultura medio-alta (una discreta parte dei lettori di fumetti, oggi) è fastidioso il leggere dialoghi e didascalie con la punteggiatura sbagliata, con la consecutio temporum piena di errori, con un’errata interpretazione dei riferimenti culturali originari, con frasi idiomatiche riportate in modo maldestro e perfino con singole parole dall’ortografia sbilenca.
A completare il quadro v’è la frequente inconsapevolezza di vari traduttori circa le distinzioni linguistiche fra l’italiano cosiddetto standard e le espressioni regionali e dialettali: parole come «rosicare» o interiezioni come «ohi», per esempio, sono usate pressoché solo nel Lazio e ad adoperarle nelle loro traduzioni sono traduttori originali del Lazio; lo stesso discorso vale per traduttori di altre regioni, i quali non credo inseriscano il loro dialetto come omaggio campanilistico ma a causa della loro mancata percezione circa la differenza fra ciò che è italiano e ciò che non lo è. Si pensi poi a quei casi in cui il traduttore non conosce la distinzione fra «tu» e «te», fra apostrofi e accenti… e tanti altri errori da matita rossa o blu.
Il problema di questo stato di cose nel fumetto italiano non riguarda solo le case editrici piccole e con scarsi budget (le quali si affidano spesso a traduttori promettenti ma ancora inesperti, costretti a lavorare in tempi molto ristretti ecc.) ma anche le case editrici maggiori (sia quelle specializzate in fumetti, sia i grandi editori di varia). Se in questo settore dell’imprenditoria, come in altri, ci si affidasse regolarmente a provini per valutare la professionalità e l’abilità dei candidati (prove di traduzione e di supervisione), molti problemi verrebbero risolti a monte; a meno che i valutatori stessi non siano scarsamente capaci di valutare i valutandi.
Il problema di fondo, duole dirlo, è che non sempre gli editori hanno la sensibilità e la cultura necessaria per capire che una traduzione eseguita male genera fastidio nei lettori e fa sì che il fumetto mal tradotto non venga acquistato né dai lettori generici, né dagli appassionati, né dalle biblioteche e dalle scuole (si veda il punto 4). La traduzione non è una mera fase tecnica: richiede cultura, preparazione, attenzione, tempo e un adeguato compenso. La corsa al ribasso anche in questo settore dell’editoria (non solo a fumetti) sta creando danni al fumetto tutto: l’effetto, dall’esterno, è che a volte il fumetto sia una forma espressiva non solo per illetterati, ma realizzata da illetterati. Il che, se fosse vero, mostrerebbe che in questo caso la famosa profezia autoavverantesi si è concretizzata dall’interno, colmo dei colmi.
3. Affidarsi a supervisori poco esperti e poco attenti
Il supervisore o, con terminologia inglese, l’editor, è una figura fondamentale del lavoro di produzione editoriale.
Dai risultati riscontrabili dall’esterno, cioè da parte dei lettori, è evidente che molte case editrici di fumetti non si avvalgono di supervisori in grado di svolgere in modo impeccabile il loro mestiere. Laddove un traduttore inesperto o frettoloso commette un qualche tipo di errore (vedi il punto dedicato alla traduzione); laddove uno sceneggiatore alle prime armi o disattento compie o riporta errori di punteggiatura, sintassi o grammatica o anacronismi nel lessico o nelle ambientazioni; laddove un calligrafo sbaglia nel riportare l’ortografia e la sillabazione delle parole; laddove un disegnatore lasciato troppo libero commette errori di visualizzazione o addirittura «copia» (com’è accaduto in passato); in tutti questi casi, un bravo supervisore dev’essere severo e dirigere il lavoro con mano ferma, in modo che il lavoro degli altri professionisti sia sempre tenuto sotto sorveglianza e, in tal modo, ne venga esaltato perché ripulito dagli errori.
In nome di una travisata «libertà» artistica, pare invece che l’anarchia produttiva di non pochi fumettisti, unita alla loro moderata cultura e capacità di documentazione, abbia favorito errori dal punto di vista della coerenza scenico-sceneggiativa, del linguaggio e quindi della gradevolezza e fruibilità, specialmente nell’ambito delle serie, miniserie e romanzi a fumetti degli editori minori.
Case editrici come la Bonelli, che si affidano a supervisori di collana e ad autori mediamente assai colti e le cui pubblicazioni passano attraverso più fasi di revisione, sono fra le poche a essere pressoché esenti da questi problemi.
Evidentemente occorrerebbe agli altri editori maggiore attenzione a questo tipo di metodo, per conseguire risultati migliori.
Si tenga inoltre presente, fenomeno deleterio, che le case editrici, specie quelle grandi ma non solo, tendono ad affidare la traduzione all’editor stesso che cura il libro/albo. Spesso il medesimo editor/traduttore esegue anche le varie correzioni di bozze. Bisogna essere davvero molto bravi e appassionati per ridurre al minimo la quantità di refusi ed errori di concetto, ed effettuare un numero molto alto di riletture. E anche così, alcuni errori rimangono, visto che una singola figura, anche se di particolare bravura, non può tecnicamente riuscire a svolgere il lavoro di più persone.
Questo e il precedente punto sono le cause principali del problema esposto in quello seguente.
6. Gli editori che da anni e ancor oggi pubblicano i manga in edizione ribaltata
Fin dal 1995 la Star Comics, rischiando con Dragon Ball, rese evidente non solo che i lettori italiani di manga erano propensi ad abituarsi subito alla pubblicazione di manga non ribaltati (quindi col senso di lettura alla giapponese), ma anche che gradirono molto questa soluzione. È una questione molto interessante, che riguarda un segno di distinzione nel gusto, un avvicinamento culturale al modo di lettura dei giapponesi, una corrispondenza maggiore all’esperienza di lettura dei manga da parte dei lettori nipponici. Che ancora qualche anno fa alcuni grossi editori pubblicassero opere come Jenny la tennista o Lady Oscar in edizione ribaltata, trasformando sistematicamente tennisti e spadaccini destrimani in mancini, aveva a mio avviso del grottesco. Ma altri editori hanno rilevato i diritti di almeno alcuni di questi classici manga di successo, proponendone riedizioni non ribaltate.
La questione del ribaltamento dei manga non riguarda primariamente una faccenda di leggibilità e di direzionalità percettiva. Come ho scritto sopra, essa riguarda il gusto dei fan dei manga, la loro identità di lettori molto spesso nettamente distinta rispetto a quella dei seguaci di altri fumetti (occidentali), il desiderio, che trova oggi piena soddisfazione, di poter trovare nella lettura da destra a sinistra la sequenzialità e la direzionalità originariamente predisposte dagli autori nipponici. Il non voler soddisfare questo semplice desiderio di quei fan che di fatto mantengono in vita il mercato dei manga in Italia, per inseguire ingenuamente e ostinatamente la chimera di un fantomatico gruppo di lettori «casuali» (anziani? ignoranti? pigri? semi analfabeti?) presuntamente non abituati o non abituabili alla lettura non ribaltata, mi è incomprensibile.
9. La distribuzione per com’è oggi, fra «edicole», librerie «di varia» e «fumetterie»
Innanzitutto, mi pare faccia male al fumetto il fatto che occorra stampare un numero esorbitante di copie di un albo o rivista per fare in modo che essi siano distribuiti nel circuito nazionale delle cosiddette «edicole» (termine che a me pare poco corretto, poiché l’edicola sarebbe di fatto un tabernacolo…); in teoria sarebbe giusto concedere la possibilità di apparire nelle edicole anche a editori in grado di stampare in tirature inferiori alle 10.000 copie, ma credo che questa soglia sia un vero e proprio filtro «razzista» d’ingresso, poiché le edicole sono perennemente sovraffollate.
Le «edicole» del fumetto sono divenute comunque, dagli anni Novanta, le «fumetterie», altro termine ambiguo in vari modi: si tratta di negozi la cui gestione, per lo più nata spontaneamente da appassionati, si è rivelata lontana dagli obiettivi che una libreria dovrebbe prefissarsi, cioè quelli miranti all’allargamento costante della propria clientela.
Inoltre, le fumetterie dovrebbero avere, a mio parere, la «missione» di farsi quale sorta di biblioteche per esercitare un apostolato del fumetto in grado di far sì che la clientela possa ampliare le proprie prospettive sui fumetti. Per esempio, a ciascun lettore di manga potrebbe essere proposta (per un massimo, per esempio, di tre volte per ciascun cliente) una lettura di prova di un fumetto italiano o americano o europeo o sudamericano: ti presto per una settimana questo albo o volume mediante cauzione, e dopo averlo letto me lo restituisci e io ti ridò i soldi; se ti è piaciuto a tal punto da volerlo tenere, mi tengo i soldi e tu ti tieni l’albo. Invece ognuno guarda al suo e la disposizione dei fumetti sugli scaffali rispecchia questa concezione a compartimenti stagni del fumetto da parte dei gestori, che in quanto appassionati essi stessi hanno, da quel che ho visto, una visione quasi sempre limitata della loro stessa merce: i manga sono messi con i manga, i supereroi con i supereroi, tutto il resto non si sa dove. È vero che sono i lettori stessi che spesso preferiscono questa compartimentazione, ma ciò più che altro perché sono sempre stati abituati così. Spezzando questo circolo vizioso con iniziative di vario genere e con una differente strategia espositiva sarebbe possibile ampliare le prospettive degli acquirenti e implementare l’arco generazionale della clientela, proprio in una fase in cui le edicole sono sempre meno frequentate da giovani lettori di fumetti, se non per i manga.
Infine, a far male al fumetto in Italia sono secondo me le librerie «di varia». Non ci si faccia trarre in inganno dal fatto che le librerie hanno adesso, spesso, una sezione dedicata ai fumetti. Che tipi di fumetti sono presentati in questo scaffale? Solo alcuni, quelli pubblicati dagli editori maggiori, tranne rare eccezioni. Il problema maggiore della gestione dello scaffale dei fumetti in libreria è tipologico: ci sono soprattutto fumetti in formato cartotecnico «libro» (cartonati, brossurati, comunque in forma di volume), il che sposta presso i frequentatori abituali delle librerie la concezione del fumetto da un’idea di lettura d’intrattenimento a un’idea di lettura in qualche modo più impegnativa, il che sarà anche vero nel caso dei fumetti più densi di contenuti e di maggior livello letterario, ma questo processo genera anche la falsa idea che i cosiddetti graphic novel siano altro dai fumetti seriali venduti nelle edicole. Ma c’è anche un altro problema ed è di tipo strettamente espositivo: diversamente da quanto accade in fumetteria, luogo frequentato per lo più da chi già pratica questo tipo di letture, i fumetti, per essere efficaci nei confronti dell’acquisto in libreria, vanno esposti frontalmente, perché sono una forma visiva: devono invogliare alla prensione e alla visione da parte dell’avventore, quindi andrebbero disposti su grate o su espositori frontali, a dispetto di qualsiasi idea intellettualistica sul fumetto come forma di lettura impegnata.
Fonti:
LoSpazioBianco.it
Questo è un cahier de doléances. Un elenco di undici «cose» che, secondo me, a vario titolo fanno male al fumetto in Italia. Non a tutto il fumetto, naturalmente, ma a quei tipi di fumetti che da almeno una di queste cose sono toccati più o meno pesantemente; e non solo i fumetti ma «il fumetto» come sistema e settore culturale.
Sono solo undici… so che ce ne sarebbero molte altre. È inoltre possibile che non tutti i punti di questo elenco trovino d’accordo chi li leggerà: essi rappresentano la mia personale prospettiva. Ho cercato di argomentarli in modo ragionevole, sebbene nella sintesi.
La sequenza di questi punti si è formata a mano a mano che mi venivano in mente gli elementi che ritengo dolenti. Dunque essa è «casuale», perché a posteriori non ritengo che il punto 1 sia più problematico del punto 8 o che il punto 3 lo sia meno del punto 2. Al lettore il compito di formulare la sua graduatoria fra questi ed, eventualmente, altri punti critici. A differenza delle canoniche liste di lamentele, tuttavia, ho cercato qui di fornire almeno in alcuni casi, sempre in termini sintetici, qualche elemento costruttivo.
1. Gli uffici stampa delle case editrici di fumetti
La maggior parte delle case editrici di fumetti in Italia non possiedono un ufficio stampa capace di svolgere il proprio lavoro in modo «normale», cioè quotidianamente, usando gli strumenti di cui gli addetti stampa delle aziende solitamente si avvalgono: il telefono, il cellulare, il fax, l’e-mail, la rubrica telefonica, i biglietti da visita, gli elenchi telefonici cartacei e on-line, il direct mailing digitale, il rilascio settimanale di comunicati stampa fra loro coordinati. Si tratta di una situazione molto critica per due ragioni: la maggior parte delle case editrici di fumetti italiane non hanno il budget, o sostengono/ritengono di non averlo, per assumere uno o due addetti stampa capaci di svolgere questo mestiere a tempo pieno, in modo da generare dibattito sui titoli della casa editrice e vendita di copie; si rivolgono pertanto ad addetti stampa inesperti, poco noti ai giornalisti, con una rubrica di contatti nei media scarsamente nutrita, con le idee non proprio chiare sulle dinamiche del mestiere e che il più delle volte si dedicano all’attività promozionale in modo non continuativo durante la settimana; ma d’altro canto i compensi che gli editori si sentono di voler/poter proporre a tali addetti stampa – quando ciò avviene – sono sovente risibili, il che livella verso il basso, automaticamente, sia la qualità del servizio, sia l’età e l’esperienza di chi sarà disposto ad accettare determinate condizioni retributive, sia la motivazione nello svolgere tali mansioni promozionali.
Per risolvere questo problema, che danneggia innanzitutto gli introiti degli editori, dal momento che un editore senza un ufficio stampa è un soggetto invisibile al di fuori del ristretto circolo dei lettori abituali di fumetti, occorrerebbe una mentalità realmente imprenditoriale, la stessa che manca affinché, per esempio, quegli stessi editori si dotino di un esperto di marketing aziendale o di traduttori e supervisori attenti (si vedano i punti seguenti).
Un ultimo elemento d’interesse è l’uso mistificante che viene attualmente fatto della comunicazione via internet. Aggiornare il sito internet dell’editore va bene, ma cercare di acquisire contatti sui social network sta assumendo troppo peso nella giornata lavorativa degli addetti agli uffici stampa: le pagine di una casa editrice su di un social network sono frequentate soprattutto da persone che o ruotano intorno alla casa editrice o che comunque già la conoscono, e non sono granché utili ad acquisire nuovi acquirenti. Sarebbe ora che i giovani addetti stampa si svegliassero e capissero che per vendere i libri ci vuol altro: il web è uno strumento formidabile per trovare nuovi lettori/acquirenti, ma bisogna saperlo usare.
2. Affidarsi a traduttori inesperti, o disattenti, o poco motivati, o…
Il tradurre prevede la conoscenza della lingua da cui si traduce, certamente; ma ancor di più prevede la conoscenza approfondita della lingua verso cui si traduce e, inoltre, la capacità previa di saper scrivere bene nell’idioma di destinazione.
Malgrado alcune indubbie eccellenze (basti pensare al lavoro di Andrea Plazzi sulle opere di Will Eisner), non pochi traduttori e traduttrici che traducono fumetti da altre lingue in italiano a me paiono a volte scarsamente capaci di esercitare con costanza la dovuta attenzione su ciò che cercano di rendere in italiano a livello sia semantico, sia lessicale, sia sintattico.
Per un lettore adulto di cultura medio-alta (una discreta parte dei lettori di fumetti, oggi) è fastidioso il leggere dialoghi e didascalie con la punteggiatura sbagliata, con la consecutio temporum piena di errori, con un’errata interpretazione dei riferimenti culturali originari, con frasi idiomatiche riportate in modo maldestro e perfino con singole parole dall’ortografia sbilenca.
A completare il quadro v’è la frequente inconsapevolezza di vari traduttori circa le distinzioni linguistiche fra l’italiano cosiddetto standard e le espressioni regionali e dialettali: parole come «rosicare» o interiezioni come «ohi», per esempio, sono usate pressoché solo nel Lazio e ad adoperarle nelle loro traduzioni sono traduttori originali del Lazio; lo stesso discorso vale per traduttori di altre regioni, i quali non credo inseriscano il loro dialetto come omaggio campanilistico ma a causa della loro mancata percezione circa la differenza fra ciò che è italiano e ciò che non lo è. Si pensi poi a quei casi in cui il traduttore non conosce la distinzione fra «tu» e «te», fra apostrofi e accenti… e tanti altri errori da matita rossa o blu.
Il problema di questo stato di cose nel fumetto italiano non riguarda solo le case editrici piccole e con scarsi budget (le quali si affidano spesso a traduttori promettenti ma ancora inesperti, costretti a lavorare in tempi molto ristretti ecc.) ma anche le case editrici maggiori (sia quelle specializzate in fumetti, sia i grandi editori di varia). Se in questo settore dell’imprenditoria, come in altri, ci si affidasse regolarmente a provini per valutare la professionalità e l’abilità dei candidati (prove di traduzione e di supervisione), molti problemi verrebbero risolti a monte; a meno che i valutatori stessi non siano scarsamente capaci di valutare i valutandi.
Il problema di fondo, duole dirlo, è che non sempre gli editori hanno la sensibilità e la cultura necessaria per capire che una traduzione eseguita male genera fastidio nei lettori e fa sì che il fumetto mal tradotto non venga acquistato né dai lettori generici, né dagli appassionati, né dalle biblioteche e dalle scuole (si veda il punto 4). La traduzione non è una mera fase tecnica: richiede cultura, preparazione, attenzione, tempo e un adeguato compenso. La corsa al ribasso anche in questo settore dell’editoria (non solo a fumetti) sta creando danni al fumetto tutto: l’effetto, dall’esterno, è che a volte il fumetto sia una forma espressiva non solo per illetterati, ma realizzata da illetterati. Il che, se fosse vero, mostrerebbe che in questo caso la famosa profezia autoavverantesi si è concretizzata dall’interno, colmo dei colmi.
3. Affidarsi a supervisori poco esperti e poco attenti
Il supervisore o, con terminologia inglese, l’editor, è una figura fondamentale del lavoro di produzione editoriale.
Dai risultati riscontrabili dall’esterno, cioè da parte dei lettori, è evidente che molte case editrici di fumetti non si avvalgono di supervisori in grado di svolgere in modo impeccabile il loro mestiere. Laddove un traduttore inesperto o frettoloso commette un qualche tipo di errore (vedi il punto dedicato alla traduzione); laddove uno sceneggiatore alle prime armi o disattento compie o riporta errori di punteggiatura, sintassi o grammatica o anacronismi nel lessico o nelle ambientazioni; laddove un calligrafo sbaglia nel riportare l’ortografia e la sillabazione delle parole; laddove un disegnatore lasciato troppo libero commette errori di visualizzazione o addirittura «copia» (com’è accaduto in passato); in tutti questi casi, un bravo supervisore dev’essere severo e dirigere il lavoro con mano ferma, in modo che il lavoro degli altri professionisti sia sempre tenuto sotto sorveglianza e, in tal modo, ne venga esaltato perché ripulito dagli errori.
In nome di una travisata «libertà» artistica, pare invece che l’anarchia produttiva di non pochi fumettisti, unita alla loro moderata cultura e capacità di documentazione, abbia favorito errori dal punto di vista della coerenza scenico-sceneggiativa, del linguaggio e quindi della gradevolezza e fruibilità, specialmente nell’ambito delle serie, miniserie e romanzi a fumetti degli editori minori.
Case editrici come la Bonelli, che si affidano a supervisori di collana e ad autori mediamente assai colti e le cui pubblicazioni passano attraverso più fasi di revisione, sono fra le poche a essere pressoché esenti da questi problemi.
Evidentemente occorrerebbe agli altri editori maggiore attenzione a questo tipo di metodo, per conseguire risultati migliori.
Si tenga inoltre presente, fenomeno deleterio, che le case editrici, specie quelle grandi ma non solo, tendono ad affidare la traduzione all’editor stesso che cura il libro/albo. Spesso il medesimo editor/traduttore esegue anche le varie correzioni di bozze. Bisogna essere davvero molto bravi e appassionati per ridurre al minimo la quantità di refusi ed errori di concetto, ed effettuare un numero molto alto di riletture. E anche così, alcuni errori rimangono, visto che una singola figura, anche se di particolare bravura, non può tecnicamente riuscire a svolgere il lavoro di più persone.
Questo e il precedente punto sono le cause principali del problema esposto in quello seguente.
6. Gli editori che da anni e ancor oggi pubblicano i manga in edizione ribaltata
Fin dal 1995 la Star Comics, rischiando con Dragon Ball, rese evidente non solo che i lettori italiani di manga erano propensi ad abituarsi subito alla pubblicazione di manga non ribaltati (quindi col senso di lettura alla giapponese), ma anche che gradirono molto questa soluzione. È una questione molto interessante, che riguarda un segno di distinzione nel gusto, un avvicinamento culturale al modo di lettura dei giapponesi, una corrispondenza maggiore all’esperienza di lettura dei manga da parte dei lettori nipponici. Che ancora qualche anno fa alcuni grossi editori pubblicassero opere come Jenny la tennista o Lady Oscar in edizione ribaltata, trasformando sistematicamente tennisti e spadaccini destrimani in mancini, aveva a mio avviso del grottesco. Ma altri editori hanno rilevato i diritti di almeno alcuni di questi classici manga di successo, proponendone riedizioni non ribaltate.
La questione del ribaltamento dei manga non riguarda primariamente una faccenda di leggibilità e di direzionalità percettiva. Come ho scritto sopra, essa riguarda il gusto dei fan dei manga, la loro identità di lettori molto spesso nettamente distinta rispetto a quella dei seguaci di altri fumetti (occidentali), il desiderio, che trova oggi piena soddisfazione, di poter trovare nella lettura da destra a sinistra la sequenzialità e la direzionalità originariamente predisposte dagli autori nipponici. Il non voler soddisfare questo semplice desiderio di quei fan che di fatto mantengono in vita il mercato dei manga in Italia, per inseguire ingenuamente e ostinatamente la chimera di un fantomatico gruppo di lettori «casuali» (anziani? ignoranti? pigri? semi analfabeti?) presuntamente non abituati o non abituabili alla lettura non ribaltata, mi è incomprensibile.
9. La distribuzione per com’è oggi, fra «edicole», librerie «di varia» e «fumetterie»
Innanzitutto, mi pare faccia male al fumetto il fatto che occorra stampare un numero esorbitante di copie di un albo o rivista per fare in modo che essi siano distribuiti nel circuito nazionale delle cosiddette «edicole» (termine che a me pare poco corretto, poiché l’edicola sarebbe di fatto un tabernacolo…); in teoria sarebbe giusto concedere la possibilità di apparire nelle edicole anche a editori in grado di stampare in tirature inferiori alle 10.000 copie, ma credo che questa soglia sia un vero e proprio filtro «razzista» d’ingresso, poiché le edicole sono perennemente sovraffollate.
Le «edicole» del fumetto sono divenute comunque, dagli anni Novanta, le «fumetterie», altro termine ambiguo in vari modi: si tratta di negozi la cui gestione, per lo più nata spontaneamente da appassionati, si è rivelata lontana dagli obiettivi che una libreria dovrebbe prefissarsi, cioè quelli miranti all’allargamento costante della propria clientela.
Inoltre, le fumetterie dovrebbero avere, a mio parere, la «missione» di farsi quale sorta di biblioteche per esercitare un apostolato del fumetto in grado di far sì che la clientela possa ampliare le proprie prospettive sui fumetti. Per esempio, a ciascun lettore di manga potrebbe essere proposta (per un massimo, per esempio, di tre volte per ciascun cliente) una lettura di prova di un fumetto italiano o americano o europeo o sudamericano: ti presto per una settimana questo albo o volume mediante cauzione, e dopo averlo letto me lo restituisci e io ti ridò i soldi; se ti è piaciuto a tal punto da volerlo tenere, mi tengo i soldi e tu ti tieni l’albo. Invece ognuno guarda al suo e la disposizione dei fumetti sugli scaffali rispecchia questa concezione a compartimenti stagni del fumetto da parte dei gestori, che in quanto appassionati essi stessi hanno, da quel che ho visto, una visione quasi sempre limitata della loro stessa merce: i manga sono messi con i manga, i supereroi con i supereroi, tutto il resto non si sa dove. È vero che sono i lettori stessi che spesso preferiscono questa compartimentazione, ma ciò più che altro perché sono sempre stati abituati così. Spezzando questo circolo vizioso con iniziative di vario genere e con una differente strategia espositiva sarebbe possibile ampliare le prospettive degli acquirenti e implementare l’arco generazionale della clientela, proprio in una fase in cui le edicole sono sempre meno frequentate da giovani lettori di fumetti, se non per i manga.
Infine, a far male al fumetto in Italia sono secondo me le librerie «di varia». Non ci si faccia trarre in inganno dal fatto che le librerie hanno adesso, spesso, una sezione dedicata ai fumetti. Che tipi di fumetti sono presentati in questo scaffale? Solo alcuni, quelli pubblicati dagli editori maggiori, tranne rare eccezioni. Il problema maggiore della gestione dello scaffale dei fumetti in libreria è tipologico: ci sono soprattutto fumetti in formato cartotecnico «libro» (cartonati, brossurati, comunque in forma di volume), il che sposta presso i frequentatori abituali delle librerie la concezione del fumetto da un’idea di lettura d’intrattenimento a un’idea di lettura in qualche modo più impegnativa, il che sarà anche vero nel caso dei fumetti più densi di contenuti e di maggior livello letterario, ma questo processo genera anche la falsa idea che i cosiddetti graphic novel siano altro dai fumetti seriali venduti nelle edicole. Ma c’è anche un altro problema ed è di tipo strettamente espositivo: diversamente da quanto accade in fumetteria, luogo frequentato per lo più da chi già pratica questo tipo di letture, i fumetti, per essere efficaci nei confronti dell’acquisto in libreria, vanno esposti frontalmente, perché sono una forma visiva: devono invogliare alla prensione e alla visione da parte dell’avventore, quindi andrebbero disposti su grate o su espositori frontali, a dispetto di qualsiasi idea intellettualistica sul fumetto come forma di lettura impegnata.
Fonti:
LoSpazioBianco.it





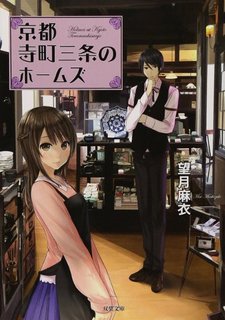
La scomparsa di Sergio Bonelli.
Ciao Sergio
E non penso che coi fumetti sia molto diverso...
Non voglio generalizzare ma il mio "fumettaro" (o presunto tale) da quando ha iniziato a vendere di tutto (videogame più di tutti) è diventato un completo ignorante, sull'argomento sbaglia tutto e non è mai aggiornato su niente... (peccato che è l'unico fumettaro decente nel raggio di 40Km circa...). Cert volte sono io ad istruirlo (non scherzo, purtroppo) e a spiegare cosa prendere oltre alle ristampe di naruto e dragon ball...
Problema accentuato dal punto 1 della sintesi del sig. Pellitteri.
Una cosa sola non mi pare corretta. Star Comics ha rischiato ben poco con il primo DB, non esageriamo. Fu un obbligo da parte di Shueisha il non ribaltamento, non una scelta italiana e DB era un titolo attesissimo giunto nelle nostre edicole e fumetterie quando la sua versione televisiva era già un cult (parlo della prima versione, non quella ridoppiata e distorta da Mediaset).
Concordo anche sulla poca lungimiranza degli editori, ma far loro capire che non puoi vendere lo stesso titolo due volte alla stessa persona è - credetemi ci ho provato - un'impresa da eroi.
@Galois. Non esagerare. Il mio negozio di fiducia ha quasi solo fumetti (tutti) e gadget e DVD sono un business del tutto secondario.
Diciamo che, più o meno, questi punti mi erano noti o li avevo intuiti, ma questo scritto mi è servito a metterli meglio in luce; soprattutto, i primi 3 punti, in quanto spesso è volentieri ho avuto l'impressione che uffici stampa ed editor non esistano affatto nelle case editrici di manga nostrane (parlo solo di manga perché i fumetti americani non li leggo), e sull'incompetenza dei traduttori sono rimasto spesso allibito e condivido le paure di Pellitteri: come si può infatti pretendere di far riconoscere il valore del fumetto, che dai più viene considerato al massimo come una forma d'intrattenimento ma senza alcuna valenza culturale, quando poi leggendolo nei dialoghi non si sa andare a capo, la differenza tra apostrofi e accenti è sconosciuta, si mettono frasi giovanili a buffo, e chi più ne ha più ne metta? Se io fossi uno scettico che mi avvicino ai manga per dare un giudizio e ho la sfortuna di incappare in un fantomatico Blue Exorcist 1, per fare un esempio, lo butterei davvero nel WC e tirerei lo scarico, dopodiché la mia idea negativa sui fumetti sarebbe davvero incontrastabile, e come darmi torto?
Ma d'altronde si sa, "ognuno guarda al proprio" e gli editori non hanno la lungimiranza di modificare o presentare i loro prodotti in modo tale da invogliare altre persone a fruirne; no, loro pretendono che qualsiasi cosa loro immettano nel mercato vada esaurito tutto e subito, secondo la più elementare logica di marketing italiota (avete presente il noto presentatore che, per un tot di tempo, ha urlato in ogni telegiornale che gli italiani si meritano la m***a perché non hanno seguito il suo Sanremo come da suoi programmi? La mentalità è quella) e si cerca di lucrare solo su lettori già "formati", soprattutto quelli casual che si autodefiniscono "otaku" (cosa c'è a Roma il 3 Febbraio? L'Otaku Day, appunto).
Sul fronte traduzione, inoltre, penso sia esemplificativa la tremenda gaffe di Panini relativa a City Hunter, se non sbaglio: "uno dei fattori che ha portato al presente prezzo dell'edizione deluxe è il costo della traduzione dal giapponese", e qualche tempo dopo è comparso un refuso che faceva capire che l'intera resa italiana viene effettuata sulla base dell'edizione francese, fossi io un compratore avrei droppato la serie solo per la beffa.
Ma finiamola qui, altrimenti ci sarebbe un discorso infinito da affrontare.
E noi siamo ben forniti di traduttori disattenti o incapaci di eseguire bene il loro lavoro. E' da anni che non solo sbagliano differenti traduzioni dal Giapponese - del più svariato genere, dalla resa dei nomi ai caratteri base - ma anche nella nostra lingua. Almeno il diletto con la seconda lingua, ossia la nostra, credo sia d'obbligo in questo lavoro. Il lavoro di pessima qualità, svolto sino ad ora da stampe indecenti e obbrobriose traduzioni, viene peggiorato infine dall'editor. Non posso che condividere le sue idee, sperando che migliorino il loro lavoro.
Non vedo invece il problema per le librerie. Non mi pare che creano chissà quali distinzioni con i fumetti venduti in edicola, se non che, come era scritto, in libreria si vendono principalmente edizioni cartonate e volumi unici.
Inoltre non si può pretendere che tutti fumetti vengano esposti frontalmente, specialmente se la libreria non è molto grande, occuperebbero parecchio spazio inutilizzato.
In merito ai manga ribaltati non ne compro più. Se tutti non li comprassimo, vedete che gli editori che si ostinano a propagandare "ignoranza" la smetterebbero. In fondo lo fanno solo per i soldi, se non arrivano è una sconfitta su tutta la linea.
La questione degli editor la posso comprendere: ognuno dovrebbe fare il suo ruolo.
E' giusto dare un'occasione ai giovani ma dovrebbero essere almeno per un po' affiancati ad un editor senior, per cogliere almeno le prime malizie del mestiere.
Ogni mestiere ha le sue malizie. Così vale per tutti: artisti, traduttori...
Ma vale anche per tutti gli altri settori, in generale in Italia oggi gli "investitori" non vogliono investire nel futuro...
Finisco con la questione della grande distribuzione. Esiste una nota catena commerciale francese, che nel suo reparto fumetti oltre alle graphic novel e alle edizione cartonate dei comics ha anche edizioni di Planet, Strar, D/Books, Jpop... o anime con Dynit, Kaze, Yamato, Sony ecc.
In confronto all'equivalente dei marchi di grande distribuzione italiani c'è un abisso; si sa i Francesi sono avanti per queste cose, ma se riescono a trapiantare un po' di buon senso in tali iniziative è solo un bene (a calcio però nemici come prima
*Clap Clap Clap*
Dai risultati riscontrabili dall'esterno, cioè da parte dei lettori, è evidente che molte case editrici di fumetti non si avvalgono di supervisori in grado di svolgere in modo impeccabile il loro mestiere
arrivata a questa frase ho pensato che le orecchie di chi lavora alla planet dovrebbero fischiare fino a sanguinare!
Io la vedo in maniera opposta: proprio perché adoro i manga, esigo che siano pubblicati in edizioni di qualità.
Ma un male non indifferente IMHO è l'opinione che del fumetto troppo spesso si ha in Italia come roba per bambini. Gli unici che superano questo pregiudizio a livello nazionale sono le vignette satiriche. Questo accade anche per mancanza di Graphic Novel ad alto tasso di pubblico e di vendite, indigene o importate che fossero.
Se poi si pensa che da noi negli anni '60 Diabolik era fumetto per adulti. E quanto la censura sia stata deleteria in quegli anni... In America il vietato ai minori negli stessi anni era R. Crumb, non so se mi spiego...
1) La mancanza di uffici stampa seri è il motivo per cui il fumetto, in Italia, continua a restare di nicchia... nel senso più sconsolante del termine.
2) Immagino che il lavoro di un traduttore sia decisamente duro, e che spesso sia difficoltoso rendere correttamente il senso di un'espressione che in lingua originale è chiarissima, ma che non corrisponde a nessuna frase simile in italiano... tuttavia, devo proprio dire che mal sopporto espressioni dialettali messe in bocca a personaggi che, a rigor di logica, dovrebbero parlare giapponese: mi vengono i brividi ogni volta che penso alle sparate in dialetto che ogni tanto compaiono in Un marzo da leoni
3) In futuro, mi piacerebbe molto lavorare come editor. Spero di non cadere negli errori che Pellitteri ha messo in evidenza...
6) Per quel che riguarda il punto 6, davvero ci sono ancora case editrici che propongono manga ribaltati?
9) Non posso dire di essere completamente d'accordo. Non amo acquistare manga in edicola (ma il discorso vale anche per i libri, o per i dvd), per due motivi: innanzitutto, i gestori delle edicole sono davvero poco informati su quel che vendono; seconda cosa, forse perchè abituati a vendere giornali, ovvero merce a basso prezzo e in costante ricambio, gli edicolanti trattano i fumetti come se maneggiassero carta straccia. Trovo invece che la fumetteria sia il posto perfetto per comprare manga: il commesso mi dà consigli, mi segnala le nuove uscite, è disponibile nel caso in cui io abbia bisogno di ordinare qualcosa di particolare o per qualsiasi chiarimento. Forse un servizio del genere non si può avere nemmeno nelle librerie, se non in quelle piccole, anche se credo sarebbe un bene vedere un numero maggiore di fumetti nelle librerie, o almeno in quelle della grande distribuzione (tipo Feltrinelli, per capirsi: qui i manga si trovano, ma quasi per caso).
Per quel che riguarda l'ampliare i propri orizzonti... beh, conosco gente che mangia da tutta una vita gli stessi biscotti, mentre altri cambiano tipo tutte le settimane. Credo sia questione di attitudini, c'è chi è più propenso alle novità, e chi è più abitudinario. Anche riguardo ai fumetti.
beh in secret unrequired love hanno tentato di rendere la parlata nel dialetto del kansai che usava il protagonista per fare il buffone con il dialetto napoletano. è stata una scelta di adattamento (che ad esempio io non ho gradito molto) e l'hanno anche spiegato in una nota se non sbaglio.
Mica tutti sono "sponsorizzati" come Naruto e One Piece attraverso gli anime che trasmettevano su Italia 1,altri manga bene o male (almeno per quanto mi riguarda),ne sono venuta a conoscenza grazie a internet o per mia curiosità sfogliando in fumetteria ma ciò non toglie che se avessero fatto almeno un minimo di pubblicità anche su riviste per ragazzi o ,perchè no,una rivista addetta solo per i fumetti (un po come per i videogiochi insomma),il loro mercato secondo me avrebbe avuto più successo .
Questo punto mi trova particolarmente d'accordo. Io sono di Bergamo e sono un frequente cliente di una delle tre fumetterie che ci sono. Ultimamente (Diciamo nell'ultimo anno) mi trovo a dover girare anche per le altre due fumetterie (anzi, solo per un altra, perchè una l'ho boicottata da sempre) perchè i distributori non portano mai i volumi in tempo. Non sono pignolo, so aspettare anche una settimana, due, ma qui si parla di mesi di fumetti e manga arretrati! Ho una casella in fumetteria e molto spesso mi arrivano numeri nuovi che però saltano quelli vecchi!!! E i ragazzi della fumetteria che mi dicono? "quel numero non ci è mai arrivato!!!" Io sto perdendo la pazienza.
Per concludere io come motivazione ai mali del fumetto in Italia aggiungerei il fatto che le case editrici pubblicano troppi manga incompleti o sospesi oppure in contemporanea con le uscite giapponesi solo perchè vendono. Non ce la faccio più a seguire 200000 manga che escono con la frequenza di un contagoccie! Basta, non sono bravo ad esprimermi, spero abbiate capito!
le opinioni espresse le condivido in parte,perchè non è mai facile soddisfare pienamente i gusti di un'esigenza di pubblico a mio modo di vedere molto vasta,quando invece bisognerebbe tenere presente di un fattore assai importante:il tempo di assimilazione delle opere nipponiche.
nel nostro paese c'è stata una tardiva cultura a tali opere,almeno dal punto di vista del cartaceo perchè fino a prima degli anni 90 in italia faceva da padrone quasi esclusivamente la walt disney company italia,con tutti i suoi periodici e di tutte le salse.
poi è stata una corsa ai manga dalla seconda metà degli anni 90 in poi,la situazione di produzione è sì in pareggio se non a tratti superiore,però il pubblico italiano non è ancora in grado di "far cominciare a leggere i manga" ai ragazzini,visto che si scelgono fiabe oppure si cade comunque in qualche fiabesca avventura sempre della disney,quindi direi che c'è un approccio già deviato fin dall'inizio,per poi recuperare tra anime e manga solo poi,quindi ritengo ci sia da questo punto di vista una "cultura a metà",di cui sicuramente ne traggono vantaggio fumetti più "datati".
dei punti sottolineati dall'intervistato,non vedo affermazioni che conducono a questo problema del fumetto,in specie quello giapponese in italia,da questo punto di vista ritengo discutibile l'intervista,il punto 6 andava invece a mio avviso marcato su questo discorso,perchè poi è quello che in un certo senso dà origine agli altri punti da lui elencati.
può darsi che tra qualche anno i gusti dei lettori cambieranno ancora,e forse questa intervista acquisterà o meno più credibilità,ma credo che per renderle delle semplici risposte in una sola intervista su tale problema,si sia generalizzato troppo sui punti,quando invece tutti i punti potevano essere analizzati meglio in una intervista con più dettagli sulla questione,in fondo,molti dei dettagli illustrati ne eravamo già a conoscenza,siamo sì d'accordo che è un bene rinfrescare la memoria,ma bisognerebbe rendere le risposte con un metro di giudizio che risponda in maniera più ampia alle esigenze di chi in tale mondo ci sguazza da anni,certo non è il mio caso,ma per molti di voi qui presenti credo proprio di sì.
quanto ai manga ribaltati mi bastano quelli della vecchia granata press
Andrò a leggere gli altri punti perche' questi li condivido (soprattutto la parte dei prestiti sotto pegno)
eh? ma vuoi paragonare un qualsiasi manga a colossi come il re leone, la bella e la bestia, la sirenetta e company? ma stiamo scherzando?
inoltre che mi significa "non è ancora in grado di"... la frase da usare, probabilmente è: NON VUOLE far cominciare a... e hanno tutte le ragioni di sto mondo per non farlo. specie com'è la situazione attuale dei manga (e la grossa scarsità di valore contenutistico che hanno la stragrande maggioranza di loro).
non è ancora in grado proprio per la mancanza di questa cultura,proprio in piccola età,diciamoci la verità,nessuno di noi da bimbi ha visto prima l'uomo tigre e poi topolino-paperino,semmai è quasi sempre accaduto il contrario.
inoltre il primo contatto col mondo nipponico lo abbiamo tutti avuto con gli anime prima e più tardi,molto più tardi coi manga,quindi ritengo sia logico che le altre conseguenze girino su ciò affermato da pellitteri.
forse ribalteremo il concetto quando saremo noi con le generazioni future a proporre prima ai nostri discendenti le opere nipponiche e solo poi in un secondo momento topolino-paperino et similia.
inoltre prima di diventare colossi,la walt disney ha sperimentato,in egual modo dei nipponici,non ce lo dimentichiamo,si sfidano su titoli che conoscono in tutto il mondo,non certo su quelli mordi e fuggi che dopo una stagione non se li piglia manco l'uomo nero.
Di manga e anime ce ne stanno per tutte le età, da quelli per bambini a quelli per adulti, per carità. Ma parlando di bambini molto piccoli, 3 o 4 anni, è difficile trovare un cartone ( in questo caso parlo di film non di serie con più episodi) adatto a loro. Non che non ce ne siano, i bambini piccoli esistono anche in Giappone, ma qui è più difficile reperirli. (parlo dei cartoni non dei bambini
Inoltre forse (e dico forse) ad un bambino occidentale, inizialmente potrebbe sembrare più comprensibile un fumetto dalla mentalità occidentale (passatemi il termine) che un manga.
Questo discorso vale anche per i cartoni animati, forse in maniera più lieve a motivo dell' adattamento italiano.
a hgaxf
Scusa, tu dici "perché dovrei leggere anche altri fumetti se a me piacciono i manga?" e subito dopo affermi che chiunque ami il fumetto dovrebbe leggere i manga. Allora il discorso dell' "ampliare il nostro spettro" vale solo per gli altri?
Ora devo andare ci risentiamo dopo.
in ogni caso i primi 3 son quelli che toccano molte case editrici per me...e senza far nomi,dico che sarebbe veramente necessario riporre rimedio.XD
Forse in qlc regione non lo si conosceva, ma in Lombrardia si era visto eccome ed era già attesissimo. Infatti fu un successo facile, al contrario di City Hunter che nessuno conosceva e non andò come loro speravano...
DB era un successo sicuro, tant'è che fu da subito quindicinale.
@shaoranlover. Attenzione che anche in Giappone usano il gergo giovanile negli shonen, per cui non escludo che la scelta di Planet sia un adeguarsi al registro usato nella versione originale. Se un personaggio parla da zotico in versione giapponese, non deve parlare in rima in quella italiana (CdZ?) o sarebbe un errore di adattamento. Quel che invece non reggo sono i periodi ipotetici con l'imperfetto e le mancate declinazioni dei participi passati...ah, non dimentichiamo "gli" al posto di "loro". Non serve un master in linguistica per sapere queste nozioni di base!
@demone dell'oscurità. Non sono del tutto convinto che la mia generazione abbia visto Topolino prima di un anime...
@Dany87: il dialetto del Kansai è usatissimo nei manga, specie per i personaggi sbruffoni o cmq atipici. Il non rendere questa sfumatura è un tradimento al testo originale. Resta cmq da definire quale dialetto italiano sia più adatto a sostituirlo (dalle mie parti si associa più a quello romano, stile cinepanettoni).
Da laureato in lingua e civiltà giapponese ti dico che il parlare dei personaggi degli shounen non è da zotico: parolacce a parte (che poi mi paiono esserci solo nei più moderni e tamarri, immagino sia il caso di Bleach ma Dragon Ball, dalle puntate che ho visto e conoscendo lo stile di Toriyama, credo proprio ne sia privo), il loro gergo è sì ridotto in alcune parti ma non è necessariamente volgare o scorretto o giovanile: la lingua giapponese ha la possibilità di elidere alcune parti del discorso (particelle, verbi, etc.) senza che questo sia scorretto grammaticalmente, anzi, soprattutto negli anime shounen, questa è una scelta che aiuta parecchio a incrementare l'immediatezza e il pathos andando pure a beneficiare lo spettatore che non deve sorbirsi discorsi troppo prolissi.
Il fatto è che questa caratteristica non esiste in italiano: essendo la nostra una lingua morfologicamente più complessa del giapponese, non appena si apportano delle elisioni è quasi inevitabile sfociare nell'errore, e a questo punto l'unica soluzione è tradurre in italiano corretto, l'unico ammissibile sulla carta stampata.
Probabilmente sono quegli stessi problemi che non vengono visti per niente, anche quando un fumetto/casa editrice è in crisi e ci si chiede "cosa c'è che non va?".
Tra parentesi, a che serve mettere il nome del proofreader in fumetto che presenta errori grossolani?
La maggior parte delle case editrici di fumetti in Italia non possiedono un ufficio stampa capace
- 9. La distribuzione per com'è oggi, fra «edicole», librerie «di varia» e «fumetterie»
I mali del fumetto Italiano sono riassunti perfettamente nel punto 1 e 9. S'è in qualche modo si potesse porre rimedio a questi due punti sarebbe una grande conquista, pultroppo attualmente non è così, ed il futuro è grigio.
Temo comunque che la colpa sia anche dei lettori, anche se scommetto che molti replicheranno dicendo che non sono d'accordo. Ci siamo adattati agli mp3 come forma di fruizione musicale (nonostante siano un prodotto scadente utile solo per ascoltare la musica in giro, non su un buon impianto stereo), dei film scaricati sul pc (orrore degli orrori: gli screener) invece che una serata al cinema, le scan invece dell'acquisto del manga (sì van bene per farsi un'idea ma avete letto che lavoro fanno in Bonelli? Nessuno che traduce per passione è in grado di farlo). E ci ritroviamo a comprare manga e libri editi con i piedi. Mi domanda però, un po' da pessimista, quanti ormai se ne accorgano, a dire la verità.
Comunque è assolutamente vero che non ci si può aspettare che un manga/fumetto/comic vengano considerati cultura se sono trattati in questa maniera (neanche il fantasy lo sarà mai, se la Fanucci continua così, purtroppo).
Certo un elemento importante e da non sottovalutare è la ridicola pubblicità che fanno per i manga... ma devo dirvelo io Panini e Star Comics di provare a fare uno spot in tv magari subito dopo o prima della messa in onda di Dragon Ball o Naruto ???
Ah già dimenticavo che ormai avete perso il treno, visto che quasi tutti gli anime sono scomparsi dal palinsesto dei primi 6 canali tv....
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.