Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle recensioni su anime e manga, realizzate degli utenti di AnimeClick.it.
Se volete farne parte anche voi... rimboccatevi le maniche e recensite!
Ricordiamo che questa rubrica non vuole essere un modo per giudicare in maniera perentoria i titoli in esame, ma un semplice contesto in cui proporre delle analisi che forniscano, indipendentemente dal loro voto finale, spunti interessanti per la nascita di discussioni, si auspica, costruttive per l'utenza.
Per saperne di più continuate a leggere.
Se volete farne parte anche voi... rimboccatevi le maniche e recensite!
Ricordiamo che questa rubrica non vuole essere un modo per giudicare in maniera perentoria i titoli in esame, ma un semplice contesto in cui proporre delle analisi che forniscano, indipendentemente dal loro voto finale, spunti interessanti per la nascita di discussioni, si auspica, costruttive per l'utenza.
Per saperne di più continuate a leggere.
Recensione di Shiryu of Dragon
-
Nausicaä, così com'è ritratta da Miyazaki, è davvero un gran personaggio: forte, intelligente, ricercatrice, una guerriera pacifista e un'ambasciatrice d'amore. Non è un eufemismo definirla una figura sacra. Chi non l'apprezzerebbe? È anche un personaggio tormentato, e la sua sofferenza è espressa davvero bene.
Altro aspetto che è impossibile non notare riguarda la perizia con la quale sono rappresentati un tempo e un mondo distopici. È un film del 1984 e si vede, però in quanto a qualità figurativa degli ambienti e dei fondali è indubbiamente un passo avanti rispetto a diversi altri prodotti d'animazione dell'epoca.
Le musiche sono in buona parte figlie di quel particolare decennio, gli anni '80. La colonna sonora porta a volte ad un connubio davvero singolare e interessante con le scene del film, e dal mio punto di vista non stona affatto, in generale. A parte quel canto bambinesco che ricorre più volte nel film, che ho trovato un po' random, un po' fuori posto e gratuitamente lezioso.
C'è da dire che, nonostante i temi estremamente seri (guerra, violenza e inquinamento atmosferico), questo film porta ancora quella ingenuità figurativa che era tipica in tanti anime degli anni '60 e '70. Ne è un esempio il fatto che, nella Valle del Vento, tutti gli uomini siano rappresentati con dei baffoni enormi in faccia. Mi ricorda lontanamente come Leiji Matsumoto - anche il suo stile è figlio di un filone dell'animazione assai datato - sia solito rappresentare (a parte poche eccezioni) i personaggi secondari bassi, piccoli e brutti: in grande contrasto con i personaggi più importanti, che invece sono di bell'aspetto.
Questa lieve ingenuità figurativa, insieme a quella leziosità che ricorda un po' la "Heidi" nipponica del lontano 1974, forse stona un po' in un film come "Nausicaä". Non che essere infantile sia un difetto a prescindere, ma forse voler sembrare per forza un cartone animato per bambini, in un film che parla di problemi così seri, è un po' limitante. Anche se non lo ritengo un limite particolarmente fastidioso: il film è godibile comunque. Per certi versi, il fascino di Nausicaä sta anche in questo: in definitiva ella non rinuncia alla propria femminilità e alla propria gentilezza, ma non per questo è un personaggio debole.
Il ritmo narrativo è a volte un po' strano e forse poteva essere orchestrato un po' meglio. Giustamente c'è molta azione, ma c'è anche qualche momento più statico e non sempre è inserito bene.
La parte finale assume un po' troppo le tonalità di un deus ex machina, il che non è un problema di per sé, ma non si concilia bene in un contesto distopico. Il colore della veste indossata da Nausicaä cambia da un momento all'altro senza una benché minima motivazione o contestualizzazione, solo perché la trama richiede che la veste debba essere di un certo colore.
La conclusione, come in "La Principessa Mononoke", mi è sembrata un po' facilona e utopistica, ma comunque gradevole. E come in "Mononoke Hime", trovo che anche qui due ore di film non siano sufficienti affinché il potenziale di quest'opera venga sfruttato appieno.
I doppiaggi italiani non mi piacciono particolarmente, né quello della vecchia edizione Rai, un po' troppo artificioso nelle sue interpretazioni vocali e in alcuni momenti anch'esso un po' troppo lezioso, né quello targato Lucky Red, troppo letterale nelle traduzioni dei dialoghi. Nessuno dei due, comunque, rovina in maniera consistente la visione del film.
In generale, è davvero un bel lungometraggio: distopico nel senso educativo del termine e a tratti regala anche delle grandi emozioni. Forse non il capolavoro che molti dicono, per le ragioni che ho esposto; ma, per quanto mi riguarda, è un titolo che consiglio assolutamente.
Altro aspetto che è impossibile non notare riguarda la perizia con la quale sono rappresentati un tempo e un mondo distopici. È un film del 1984 e si vede, però in quanto a qualità figurativa degli ambienti e dei fondali è indubbiamente un passo avanti rispetto a diversi altri prodotti d'animazione dell'epoca.
Le musiche sono in buona parte figlie di quel particolare decennio, gli anni '80. La colonna sonora porta a volte ad un connubio davvero singolare e interessante con le scene del film, e dal mio punto di vista non stona affatto, in generale. A parte quel canto bambinesco che ricorre più volte nel film, che ho trovato un po' random, un po' fuori posto e gratuitamente lezioso.
C'è da dire che, nonostante i temi estremamente seri (guerra, violenza e inquinamento atmosferico), questo film porta ancora quella ingenuità figurativa che era tipica in tanti anime degli anni '60 e '70. Ne è un esempio il fatto che, nella Valle del Vento, tutti gli uomini siano rappresentati con dei baffoni enormi in faccia. Mi ricorda lontanamente come Leiji Matsumoto - anche il suo stile è figlio di un filone dell'animazione assai datato - sia solito rappresentare (a parte poche eccezioni) i personaggi secondari bassi, piccoli e brutti: in grande contrasto con i personaggi più importanti, che invece sono di bell'aspetto.
Questa lieve ingenuità figurativa, insieme a quella leziosità che ricorda un po' la "Heidi" nipponica del lontano 1974, forse stona un po' in un film come "Nausicaä". Non che essere infantile sia un difetto a prescindere, ma forse voler sembrare per forza un cartone animato per bambini, in un film che parla di problemi così seri, è un po' limitante. Anche se non lo ritengo un limite particolarmente fastidioso: il film è godibile comunque. Per certi versi, il fascino di Nausicaä sta anche in questo: in definitiva ella non rinuncia alla propria femminilità e alla propria gentilezza, ma non per questo è un personaggio debole.
Il ritmo narrativo è a volte un po' strano e forse poteva essere orchestrato un po' meglio. Giustamente c'è molta azione, ma c'è anche qualche momento più statico e non sempre è inserito bene.
La parte finale assume un po' troppo le tonalità di un deus ex machina, il che non è un problema di per sé, ma non si concilia bene in un contesto distopico. Il colore della veste indossata da Nausicaä cambia da un momento all'altro senza una benché minima motivazione o contestualizzazione, solo perché la trama richiede che la veste debba essere di un certo colore.
La conclusione, come in "La Principessa Mononoke", mi è sembrata un po' facilona e utopistica, ma comunque gradevole. E come in "Mononoke Hime", trovo che anche qui due ore di film non siano sufficienti affinché il potenziale di quest'opera venga sfruttato appieno.
I doppiaggi italiani non mi piacciono particolarmente, né quello della vecchia edizione Rai, un po' troppo artificioso nelle sue interpretazioni vocali e in alcuni momenti anch'esso un po' troppo lezioso, né quello targato Lucky Red, troppo letterale nelle traduzioni dei dialoghi. Nessuno dei due, comunque, rovina in maniera consistente la visione del film.
In generale, è davvero un bel lungometraggio: distopico nel senso educativo del termine e a tratti regala anche delle grandi emozioni. Forse non il capolavoro che molti dicono, per le ragioni che ho esposto; ma, per quanto mi riguarda, è un titolo che consiglio assolutamente.
Plastic Memories
6.5/10
Ambientato in un futuro non così distante dalla nostra attualità, dalle tinte variopinte, pastellate e di sbiadite luci al neon, dove in lontananza si scorgono freddi scenari che vorrebbero ricalcare la classica visione di un cyber-mondo nipponico figlio della fine degli anni novanta (ma con poco successo), ci viene raccontata la breve vicenda di “Plastic Memories”, una storiella romantica camuffata da leggero, insipido sci-fi.
Il gusto pretto, cupo, gelido e virtuale dei prodotti degli ultimi trent’anni figli di “Blade Runner” qui viene quasi totalmente meno, lasciando spazio a una commedia dalle animazioni altalenanti (apprezzabili nei momenti cardine, capaci altrimenti di sfiorare appena la sufficienza), dalla cromatica pallida ma azzeccata, dalle acconciature bizzarre che dicono ben poco e dal plot talmente banale da non riuscire mai a stupire, nonostante la più che buona gestione della vena drammatica presente soprattutto nella seconda metà della sua interezza.
“Plastic Memories” non è assolutamente un prodotto da bocciare: sebbene in dose minima, v’è un pizzico della caducità e del decadimento che il grande Ridley Scott - tramite Roy Batty e il mitico Deckard - ci fece amare attraverso il magnifico e glorioso “cacciatore di taglie” Blade Runner, poc’anzi citato - ed è doveroso rimarcarlo nuovamente, poiché è ai celeberrimi “replicanti in servizio” che quest’anime chiaramente si ispira, senza mai osare avvicinarsi neanche lontanamente. Si desidera mantenere la vicenda esclusivamente adolescenziale, romantica e leggermente avventurosa (con picchi di pathos e azione proprio a metà serie), senza mai addentrarsi negli oscuri, piovosi e terribili meandri del cyberpunk puro: scelta ovviamente voluta, desiderando mantenere un determinato target fino alla fine.
Non si chiamano “replicanti” ma “giftia”, e il loro ciclo vitale è di 81920 ore. Il protagonista della vicenda è un adolescente di nome Tsukasa, che entra a far parte di un ufficio adibito proprio al recupero dei giftia a fine ciclo, che poi saranno riprogrammati per una nuova esistenza, dimenticando ergo la vita precedente e ripartendo da “zero”.
Probabilmente “Plastic Memories” fallisce proprio nei personaggi (non tutti, ma solo con alcuni), troppo banali e stereotipati per suscitare grande interesse. Tsukasa è il classico ragazzo dal bell’aspetto, zuccherosamente gentile, il solito imbranato con quel fare da stoccafisso piatto e anonimo di cui probabilmente si invaghiranno più di una delle controparti femminili presenti nell’anime. I suoi buoni propositi sono encomiabili, il faccino pulito da bravo ragazzo e il suo innaturale imbarazzo lo rendono estremamente noioso: come lui ne abbiamo visti a decine in passato, e a decine ce ne siamo dimenticati poche settimane dopo.
Non che i comprimari brillino di luce propria: direttamente da “Neon Genesis Evangelion” troviamo ivi la brutta copia di Asuka (stessi capelli, stesso caratteraccio da tsundere in preda agli ormoni e all’umore cangiante, stesso disagio nel relazionarsi al prossimo, ma un cuore insospettabilmente gentile); poi ecco Isla, la co-protagonista “loli” su cui verte tutta la vicenda e di cui nulla pare davvero originale. Annotiamo poi la presenza del solito collega di lavoro più anziano, navigato, donnaiolo, sempre mezzo ubriaco e dalla capigliatura incomprensibile; non manca la sua versione femminile dai capelli rosso fiammante e dal passato travagliato, e così via discorrendo. Sia chiaro: non che l’intero entourage sia piatto e insulso, ma si percepisce che, con un po' più di originalità, coraggio e desiderio di variare, i risultati sarebbero stati sicuramente più intriganti.
I tredici episodi si snodano attraverso un mix di (superficiale) approfondimento dei loro caratteri, di momenti tristi, talvolta drammaticamente strazianti, di attimi di serenità preziosa, e non manca un po’ di umorismo a bilanciare il tutto, nonostante esso si riveli sovente una sequenza di gag incredibilmente banali, talvolta infantili o incentrate su doppi sensi erotici da terza media. I personaggi spiccano raramente, la qualità delle animazioni non sempre aiuta a sorprendere e focalizzare sulle loro emozioni, anche se, nel complesso, la somma di tutti questi elementi genera un totale sufficientemente godibile.
La cosa migliore di “Plastic Memories” rimane quindi la diatriba morale riguardo i giftia. Il “cogito ergo sum” cartesiano si ripropone in forma differente, ma il dilemma etico è quello che da sempre riempie l’immaginario umano: l’intelligenza artificiale può davvero sostituire quella umana, e un “robot” che si comporta, ragiona, pensa e vive come un essere umano può essere considerato a tutti gli effetti uguale a un essere umano?
In un futuro prossimo dove questa tecnologia ormai è divenuta eccezionale, quando l’IA è dispone di capacità identiche a quelle dell’intelletto umano, distinguere l’organico dal cibernetico è quasi impossibile. E allora ecco che l’artificiale si sovrappone, appanna e confonde, e ci si ricorda che, quando l’uomo oltrepassa la linea che lo differisce dagli dei, finirà per forza di cose per fare i conti con la propria moralità.
Fino a che punto ci si può spingere per far felici noi stessi? Di quanto egoismo si deve disporre per riempire i nostri vuoti con surrogati artificiali che col tempo cominceremo a ritenere identici se non migliori di noi? E una volta che le differenze diventano impercettibili, cosa accade? Film, romanzi e fumetti di gloriosi autori ce ne hanno parlato ampiamente, nel corso degli anni. Le leggi dello stesso Asimov riecheggiano come un monito fantascientifico ma quanto mai reale, dove spingersi troppo oltre potrebbe mettere a rischio la percezione dell’umanità come noi oggi la intendiamo.
Sono domande spontanee che ci siamo fatti tutti almeno una volta nella vita. Se le macchine potessero parlare e pensare, cosa ci racconterebbero? Se un computer dall’aspetto identico a quello di una donna attraente, dall’odore calamitante, dalla superficie simile a una pelle morbida e vellutata e dalla profondità cibernetica pari alla rete neurale di un essere umano potesse parlare e interagire con noi, cosa ai nostri occhi lo renderebbe differente da una donna in carne ed ossa? Il suo concepimento? Il materiale di cui è composta? O il fatto che gli stessi esseri umani sono non genitori, ma dei-creatori di questa creatura?
In “Plastic Memories” siamo andati oltre i dilemmi morali, e nell’universo in cui Tsukasa, Isla e compagni vivono, i giftia sono considerati ormai al pari degli esseri umani, ma si mantiene un occhio di riguardo quando il ciclo vitale è al termine, onde evitare scompensi di sistema o ancor più singolari e problematici accadimenti che inevitabilmente sono legati al malfunzionamento di una “macchina”.
Umanizzare una creazione artificiale la rende viva e identica a noi a tutti gli effetti, con quel rischio tenero, dolce e pericoloso di potersi affezionare ad essa. E quando il ciclo del giftia termina, è come se sopraggiungesse una sorta di morte in tutto e per tutto, in attesa di una reincarnazione artificiale che tuttavia non esclude l’immenso dolore di chi deve accommiatarsi da esso.
Se c’è una cosa che senza ombra di dubbio accomuna repliche ed esseri umani, è sicuramente l’astratto concetto di “morte”. Un rintocco inevitabile e necessario per poter valorizzare la vita stessa. Un essere umano non conosce il giorno esatto in cui morirà, e per fortuna, potremmo dire. Probabilmente, esserne a conoscenza potrebbe dimostrarsi un fardello troppo atroce per la psiche, mentre per i giftia non pare essere così.
Con un concetto di fondo simile, l’intero prodotto acquista più credibilità, peccato però che siano evidenti alcune forzature di trama, un deus ex machina atto a incanalare e mostrare questo genere di situazioni, e non sempre tutto scorre in modo naturale.
La gestione dei tempi non è male: pause, tempi morti e flashback vengono utilizzati in modo più che gradevole; raramente il ritmo si scopre poco chiaro o confusionario, ma, come anticipato, è la storia d’amore a far da padrona. Intuibile inizialmente, blanda poi, crescente e anche capace di commuovere nella seconda parte: la parte finale è il pezzo forte, nonostante un finale telefonato e per nulla sorprendente, ma che calza perfettamente.
Il comparto sonoro non è deludente, ma poco ci manca: poche tracce memorabili, qualche momento degno di nota, ending e opening carine, ma niente di trascendentale.
I ricordi possono essere armi a doppio taglio: più belli essi sono e tanto ci scaldano il cuore, più possono rivelarsi fonte di dolore, se legati a qualcuno che è non più al nostro fianco. Una riflessione che tutti conosciamo, ma che spesso non ci sovviene, e che in “Plastic Memories” torna a galla nei momenti clou, regalandogli un’ampia sufficienza, ma nulla più.
Un lavoro moderatamente apprezzabile, che non mancherà di intrattenere e alleggerire. Consigliato più a chi predilige storie romantiche adolescenziali che sci-fi vero e proprio, nonostante lo stampo sia similarmente futuristico e vagamente cyber.
Il gusto pretto, cupo, gelido e virtuale dei prodotti degli ultimi trent’anni figli di “Blade Runner” qui viene quasi totalmente meno, lasciando spazio a una commedia dalle animazioni altalenanti (apprezzabili nei momenti cardine, capaci altrimenti di sfiorare appena la sufficienza), dalla cromatica pallida ma azzeccata, dalle acconciature bizzarre che dicono ben poco e dal plot talmente banale da non riuscire mai a stupire, nonostante la più che buona gestione della vena drammatica presente soprattutto nella seconda metà della sua interezza.
“Plastic Memories” non è assolutamente un prodotto da bocciare: sebbene in dose minima, v’è un pizzico della caducità e del decadimento che il grande Ridley Scott - tramite Roy Batty e il mitico Deckard - ci fece amare attraverso il magnifico e glorioso “cacciatore di taglie” Blade Runner, poc’anzi citato - ed è doveroso rimarcarlo nuovamente, poiché è ai celeberrimi “replicanti in servizio” che quest’anime chiaramente si ispira, senza mai osare avvicinarsi neanche lontanamente. Si desidera mantenere la vicenda esclusivamente adolescenziale, romantica e leggermente avventurosa (con picchi di pathos e azione proprio a metà serie), senza mai addentrarsi negli oscuri, piovosi e terribili meandri del cyberpunk puro: scelta ovviamente voluta, desiderando mantenere un determinato target fino alla fine.
Non si chiamano “replicanti” ma “giftia”, e il loro ciclo vitale è di 81920 ore. Il protagonista della vicenda è un adolescente di nome Tsukasa, che entra a far parte di un ufficio adibito proprio al recupero dei giftia a fine ciclo, che poi saranno riprogrammati per una nuova esistenza, dimenticando ergo la vita precedente e ripartendo da “zero”.
Probabilmente “Plastic Memories” fallisce proprio nei personaggi (non tutti, ma solo con alcuni), troppo banali e stereotipati per suscitare grande interesse. Tsukasa è il classico ragazzo dal bell’aspetto, zuccherosamente gentile, il solito imbranato con quel fare da stoccafisso piatto e anonimo di cui probabilmente si invaghiranno più di una delle controparti femminili presenti nell’anime. I suoi buoni propositi sono encomiabili, il faccino pulito da bravo ragazzo e il suo innaturale imbarazzo lo rendono estremamente noioso: come lui ne abbiamo visti a decine in passato, e a decine ce ne siamo dimenticati poche settimane dopo.
Non che i comprimari brillino di luce propria: direttamente da “Neon Genesis Evangelion” troviamo ivi la brutta copia di Asuka (stessi capelli, stesso caratteraccio da tsundere in preda agli ormoni e all’umore cangiante, stesso disagio nel relazionarsi al prossimo, ma un cuore insospettabilmente gentile); poi ecco Isla, la co-protagonista “loli” su cui verte tutta la vicenda e di cui nulla pare davvero originale. Annotiamo poi la presenza del solito collega di lavoro più anziano, navigato, donnaiolo, sempre mezzo ubriaco e dalla capigliatura incomprensibile; non manca la sua versione femminile dai capelli rosso fiammante e dal passato travagliato, e così via discorrendo. Sia chiaro: non che l’intero entourage sia piatto e insulso, ma si percepisce che, con un po' più di originalità, coraggio e desiderio di variare, i risultati sarebbero stati sicuramente più intriganti.
I tredici episodi si snodano attraverso un mix di (superficiale) approfondimento dei loro caratteri, di momenti tristi, talvolta drammaticamente strazianti, di attimi di serenità preziosa, e non manca un po’ di umorismo a bilanciare il tutto, nonostante esso si riveli sovente una sequenza di gag incredibilmente banali, talvolta infantili o incentrate su doppi sensi erotici da terza media. I personaggi spiccano raramente, la qualità delle animazioni non sempre aiuta a sorprendere e focalizzare sulle loro emozioni, anche se, nel complesso, la somma di tutti questi elementi genera un totale sufficientemente godibile.
La cosa migliore di “Plastic Memories” rimane quindi la diatriba morale riguardo i giftia. Il “cogito ergo sum” cartesiano si ripropone in forma differente, ma il dilemma etico è quello che da sempre riempie l’immaginario umano: l’intelligenza artificiale può davvero sostituire quella umana, e un “robot” che si comporta, ragiona, pensa e vive come un essere umano può essere considerato a tutti gli effetti uguale a un essere umano?
In un futuro prossimo dove questa tecnologia ormai è divenuta eccezionale, quando l’IA è dispone di capacità identiche a quelle dell’intelletto umano, distinguere l’organico dal cibernetico è quasi impossibile. E allora ecco che l’artificiale si sovrappone, appanna e confonde, e ci si ricorda che, quando l’uomo oltrepassa la linea che lo differisce dagli dei, finirà per forza di cose per fare i conti con la propria moralità.
Fino a che punto ci si può spingere per far felici noi stessi? Di quanto egoismo si deve disporre per riempire i nostri vuoti con surrogati artificiali che col tempo cominceremo a ritenere identici se non migliori di noi? E una volta che le differenze diventano impercettibili, cosa accade? Film, romanzi e fumetti di gloriosi autori ce ne hanno parlato ampiamente, nel corso degli anni. Le leggi dello stesso Asimov riecheggiano come un monito fantascientifico ma quanto mai reale, dove spingersi troppo oltre potrebbe mettere a rischio la percezione dell’umanità come noi oggi la intendiamo.
Sono domande spontanee che ci siamo fatti tutti almeno una volta nella vita. Se le macchine potessero parlare e pensare, cosa ci racconterebbero? Se un computer dall’aspetto identico a quello di una donna attraente, dall’odore calamitante, dalla superficie simile a una pelle morbida e vellutata e dalla profondità cibernetica pari alla rete neurale di un essere umano potesse parlare e interagire con noi, cosa ai nostri occhi lo renderebbe differente da una donna in carne ed ossa? Il suo concepimento? Il materiale di cui è composta? O il fatto che gli stessi esseri umani sono non genitori, ma dei-creatori di questa creatura?
In “Plastic Memories” siamo andati oltre i dilemmi morali, e nell’universo in cui Tsukasa, Isla e compagni vivono, i giftia sono considerati ormai al pari degli esseri umani, ma si mantiene un occhio di riguardo quando il ciclo vitale è al termine, onde evitare scompensi di sistema o ancor più singolari e problematici accadimenti che inevitabilmente sono legati al malfunzionamento di una “macchina”.
Umanizzare una creazione artificiale la rende viva e identica a noi a tutti gli effetti, con quel rischio tenero, dolce e pericoloso di potersi affezionare ad essa. E quando il ciclo del giftia termina, è come se sopraggiungesse una sorta di morte in tutto e per tutto, in attesa di una reincarnazione artificiale che tuttavia non esclude l’immenso dolore di chi deve accommiatarsi da esso.
Se c’è una cosa che senza ombra di dubbio accomuna repliche ed esseri umani, è sicuramente l’astratto concetto di “morte”. Un rintocco inevitabile e necessario per poter valorizzare la vita stessa. Un essere umano non conosce il giorno esatto in cui morirà, e per fortuna, potremmo dire. Probabilmente, esserne a conoscenza potrebbe dimostrarsi un fardello troppo atroce per la psiche, mentre per i giftia non pare essere così.
Con un concetto di fondo simile, l’intero prodotto acquista più credibilità, peccato però che siano evidenti alcune forzature di trama, un deus ex machina atto a incanalare e mostrare questo genere di situazioni, e non sempre tutto scorre in modo naturale.
La gestione dei tempi non è male: pause, tempi morti e flashback vengono utilizzati in modo più che gradevole; raramente il ritmo si scopre poco chiaro o confusionario, ma, come anticipato, è la storia d’amore a far da padrona. Intuibile inizialmente, blanda poi, crescente e anche capace di commuovere nella seconda parte: la parte finale è il pezzo forte, nonostante un finale telefonato e per nulla sorprendente, ma che calza perfettamente.
Il comparto sonoro non è deludente, ma poco ci manca: poche tracce memorabili, qualche momento degno di nota, ending e opening carine, ma niente di trascendentale.
I ricordi possono essere armi a doppio taglio: più belli essi sono e tanto ci scaldano il cuore, più possono rivelarsi fonte di dolore, se legati a qualcuno che è non più al nostro fianco. Una riflessione che tutti conosciamo, ma che spesso non ci sovviene, e che in “Plastic Memories” torna a galla nei momenti clou, regalandogli un’ampia sufficienza, ma nulla più.
Un lavoro moderatamente apprezzabile, che non mancherà di intrattenere e alleggerire. Consigliato più a chi predilige storie romantiche adolescenziali che sci-fi vero e proprio, nonostante lo stampo sia similarmente futuristico e vagamente cyber.
Come si può creare la società “perfetta”? Può l’uomo considerarsi la specie predominante del pianeta, senza fare uso di violenza verso i propri simili? Può instaurare una sorta di gerarchia apparentemente funzionante e pacifica, che permetta un avanzamento migliorativo del pianeta?
Queste sono le domande base di “Shinsekai Yori”, opera del 2012, tratta da un romanzo di Yosuke Kishi. A differenza di trasposizioni animate tratte da fumetti, o originali, le radici di questo titolo influiscono facilmente sul tipo di narrazione proposta, che offre sì svariate scene d’azione (per quanto poco adrenaliniche), ma si basa quasi completamente su spiegazioni e dialoghi dettagliati. Il che costituisce, insieme a un ritmo decisamente lento e verboso, e a tematiche piuttosto mature, uno dei motivi per cui la serie viene spesso snobbata dalla massa, in favore di titoli più commerciali.
La trama vede per protagonista una società futuristica che, in seguito a una specie di apocalittica catastrofe, appare come in decadenza, seppur controllata da una ferrea gerarchia di persone. Protagonisti sono cinque ragazzi, Saki, Shun, Satoru, Mamoru e Maria, dapprima bambini e poi adolescenti che, come qualunque altro personaggio presentato, detengono il “potere degli dèi”, ovvero la telecinesi. Inizialmente, la storia procede lenta e senza particolari colpi di scena; la società in cui i ragazzi vivono è apparentemente perfetta. Ma pian piano vengono fuori le prime falle. Al fine di evitare aggressività negli individui, e violenza gli uni verso gli altri, si impone una sorta di controllo mentale che oltretutto incita alla sessualità precoce (anche tra individui dello stesso sesso), per rilasciare gli istinti in maniera controllata. Anche gli omicidi tra esseri umani vengono bloccati dal limitatore biologico, che farebbe morire chiunque nutra il desiderio di eliminare un individuo.
Ma ecco che viene fuori la duplice critica di cui “Shinsekai Yori” si fa carico: la prima verso la società, la seconda - benché molto più marginale - verso la religione (qui rappresentata dal monaco che, pur di preservare i segreti della società, ruba i poteri ai protagonisti, perché non possano maturare una propria individualità che si ribelli alla vita collettiva imposta da altri). In questa istituzione apparentemente perfetta, la perfezione si preserva eliminando tutto ciò che costituisce un ingranaggio rotto, tutto ciò che è diverso, tutto ciò che è sovversivo. Gli individui che non sono in grado di conformarsi al sistema vengono isolati o eliminati, di modo che i singoli non possano distruggere l’ingranaggio generale che muove le fila. Anche il semplice adattarsi con difficoltà costituisce vergogna: basti pensare alla Saki di inizio serie che, ottenendo il proprio potere in ritardo rispetto ai suoi amici, si intristisce credendo di non poter essere all’altezza degli altri.
Ma è proprio nel momento in cui vengono a galla queste macchinazioni da parte di chi “sta in alto”, che i protagonisti iniziano a domandarsi se questa società funzioni davvero, se rispetto al mondo distrutto che vi era una volta ci si è mossi verso un miglioramento effettivo, o se invece c’è stato un decadimento dell’umanità. E oltre ad interrogarsi sulla legittimità di una società così disfunzionale, l’anime scava molto più a fondo, andando a proporre riflessioni sulla natura umana.
I personaggi in questo senso vengono analizzati piuttosto bene. Alcuni, in effetti, risultano stonare un po’, in quanto analizzati senza particolare perizia in un contesto così affascinante; altri, come la stessa Saki, crescono a poco a poco, maturando sempre più quale debba essere il proprio ruolo, e quello dei “subordinati”. Questi ultimi sono i mostroratti, esseri deformi e mostruosi che, non possedendo il potere degli dèi, vengono considerati alla stregua di schiavi, e venerano gli umani come dei, non avendo la forza di ribellarsi.
Ma è proprio in questo scenario che fa la comparsa Squealer, forse il personaggio più riuscito di tutta la serie. Manipolatore, codardo, viscido, orribile e ripugnante: questo è come ci appare per tutta la durata dei venticinque episodi. Eppure, Squealer è forse quello che più rappresenta l’eroe. Novello Prometeo, Squealer intende ribellarsi dalla sua condizione di schiavo e sottomesso, non accettando più la mortificazione della carne e dello spirito in favore di persone che si credono gli dèi di una società così fasulla.
Ed è in fondo proprio grazie a Squealer se viene fuori la tematica migliore della serie, l’equilibrio tra bene e male. Sostanzialmente, in moltissime serie, o film, o romanzi, la distinzione fra le due è sempre precisa e ovvia. “Shinsekai Yori” invece dimostra che non tutto debba essere per forza bianco o nero, ma che esistono le sfumature. Non si può essere solo buoni o cattivi, solo eroi o carnefici, e chi si autoproclama come eroe di una società perfetta, promuovendo la non-violenza, non per forza sta facendo del bene.
Sono sostanzialmente bugia e ignoranza a far funzionare le cose, e la sapienza che viene ricercata da Saki è punita severamente: “Ognuno muore senza comprendere nulla. È così che funziona il mondo, dopotutto” (Yusuke Kishi)
Purtroppo, tra i motivi per i quali la serie non ha ricevuto un enorme successo nonostante la sua potenza verbale e visiva, c’è anche quello della poca cura tecnica riservata alle animazioni, che rendono davvero indigesti alcuni passaggi. Ed è un peccato, perché, in compenso, l’uso dei colori è magistrale quanto la colonna sonora, in cui peraltro compare come leitmotiv il pezzo di Antonin Dvorak, “From the New World”, che dà anche il titolo alla serie. Pezzo musicale che, peraltro, compare in “Mawaru Penguindrum” proprio in una scena che presenta tematiche molto simili a quelle proposte qui, ovvero il terrore di come un personaggio “diverso” possa essere eliminato, per non distruggere un meccanismo funzionante.
Sostanzialmente, se si chiude un occhio su questo evidente difetto e non si è allergici a ritmi molto lenti, per quanto ricchi di plot twist, consiglio caldamente la visione a chi se lo fosse lasciato sfuggire.
Queste sono le domande base di “Shinsekai Yori”, opera del 2012, tratta da un romanzo di Yosuke Kishi. A differenza di trasposizioni animate tratte da fumetti, o originali, le radici di questo titolo influiscono facilmente sul tipo di narrazione proposta, che offre sì svariate scene d’azione (per quanto poco adrenaliniche), ma si basa quasi completamente su spiegazioni e dialoghi dettagliati. Il che costituisce, insieme a un ritmo decisamente lento e verboso, e a tematiche piuttosto mature, uno dei motivi per cui la serie viene spesso snobbata dalla massa, in favore di titoli più commerciali.
La trama vede per protagonista una società futuristica che, in seguito a una specie di apocalittica catastrofe, appare come in decadenza, seppur controllata da una ferrea gerarchia di persone. Protagonisti sono cinque ragazzi, Saki, Shun, Satoru, Mamoru e Maria, dapprima bambini e poi adolescenti che, come qualunque altro personaggio presentato, detengono il “potere degli dèi”, ovvero la telecinesi. Inizialmente, la storia procede lenta e senza particolari colpi di scena; la società in cui i ragazzi vivono è apparentemente perfetta. Ma pian piano vengono fuori le prime falle. Al fine di evitare aggressività negli individui, e violenza gli uni verso gli altri, si impone una sorta di controllo mentale che oltretutto incita alla sessualità precoce (anche tra individui dello stesso sesso), per rilasciare gli istinti in maniera controllata. Anche gli omicidi tra esseri umani vengono bloccati dal limitatore biologico, che farebbe morire chiunque nutra il desiderio di eliminare un individuo.
Ma ecco che viene fuori la duplice critica di cui “Shinsekai Yori” si fa carico: la prima verso la società, la seconda - benché molto più marginale - verso la religione (qui rappresentata dal monaco che, pur di preservare i segreti della società, ruba i poteri ai protagonisti, perché non possano maturare una propria individualità che si ribelli alla vita collettiva imposta da altri). In questa istituzione apparentemente perfetta, la perfezione si preserva eliminando tutto ciò che costituisce un ingranaggio rotto, tutto ciò che è diverso, tutto ciò che è sovversivo. Gli individui che non sono in grado di conformarsi al sistema vengono isolati o eliminati, di modo che i singoli non possano distruggere l’ingranaggio generale che muove le fila. Anche il semplice adattarsi con difficoltà costituisce vergogna: basti pensare alla Saki di inizio serie che, ottenendo il proprio potere in ritardo rispetto ai suoi amici, si intristisce credendo di non poter essere all’altezza degli altri.
Ma è proprio nel momento in cui vengono a galla queste macchinazioni da parte di chi “sta in alto”, che i protagonisti iniziano a domandarsi se questa società funzioni davvero, se rispetto al mondo distrutto che vi era una volta ci si è mossi verso un miglioramento effettivo, o se invece c’è stato un decadimento dell’umanità. E oltre ad interrogarsi sulla legittimità di una società così disfunzionale, l’anime scava molto più a fondo, andando a proporre riflessioni sulla natura umana.
I personaggi in questo senso vengono analizzati piuttosto bene. Alcuni, in effetti, risultano stonare un po’, in quanto analizzati senza particolare perizia in un contesto così affascinante; altri, come la stessa Saki, crescono a poco a poco, maturando sempre più quale debba essere il proprio ruolo, e quello dei “subordinati”. Questi ultimi sono i mostroratti, esseri deformi e mostruosi che, non possedendo il potere degli dèi, vengono considerati alla stregua di schiavi, e venerano gli umani come dei, non avendo la forza di ribellarsi.
Ma è proprio in questo scenario che fa la comparsa Squealer, forse il personaggio più riuscito di tutta la serie. Manipolatore, codardo, viscido, orribile e ripugnante: questo è come ci appare per tutta la durata dei venticinque episodi. Eppure, Squealer è forse quello che più rappresenta l’eroe. Novello Prometeo, Squealer intende ribellarsi dalla sua condizione di schiavo e sottomesso, non accettando più la mortificazione della carne e dello spirito in favore di persone che si credono gli dèi di una società così fasulla.
Ed è in fondo proprio grazie a Squealer se viene fuori la tematica migliore della serie, l’equilibrio tra bene e male. Sostanzialmente, in moltissime serie, o film, o romanzi, la distinzione fra le due è sempre precisa e ovvia. “Shinsekai Yori” invece dimostra che non tutto debba essere per forza bianco o nero, ma che esistono le sfumature. Non si può essere solo buoni o cattivi, solo eroi o carnefici, e chi si autoproclama come eroe di una società perfetta, promuovendo la non-violenza, non per forza sta facendo del bene.
Sono sostanzialmente bugia e ignoranza a far funzionare le cose, e la sapienza che viene ricercata da Saki è punita severamente: “Ognuno muore senza comprendere nulla. È così che funziona il mondo, dopotutto” (Yusuke Kishi)
Purtroppo, tra i motivi per i quali la serie non ha ricevuto un enorme successo nonostante la sua potenza verbale e visiva, c’è anche quello della poca cura tecnica riservata alle animazioni, che rendono davvero indigesti alcuni passaggi. Ed è un peccato, perché, in compenso, l’uso dei colori è magistrale quanto la colonna sonora, in cui peraltro compare come leitmotiv il pezzo di Antonin Dvorak, “From the New World”, che dà anche il titolo alla serie. Pezzo musicale che, peraltro, compare in “Mawaru Penguindrum” proprio in una scena che presenta tematiche molto simili a quelle proposte qui, ovvero il terrore di come un personaggio “diverso” possa essere eliminato, per non distruggere un meccanismo funzionante.
Sostanzialmente, se si chiude un occhio su questo evidente difetto e non si è allergici a ritmi molto lenti, per quanto ricchi di plot twist, consiglio caldamente la visione a chi se lo fosse lasciato sfuggire.
I collegamenti ad Amazon fanno parte di un programma di affiliazione: se effettui un acquisto o un ordine attraverso questi collegamenti, il nostro sito potrebbe ricevere una commissione.
















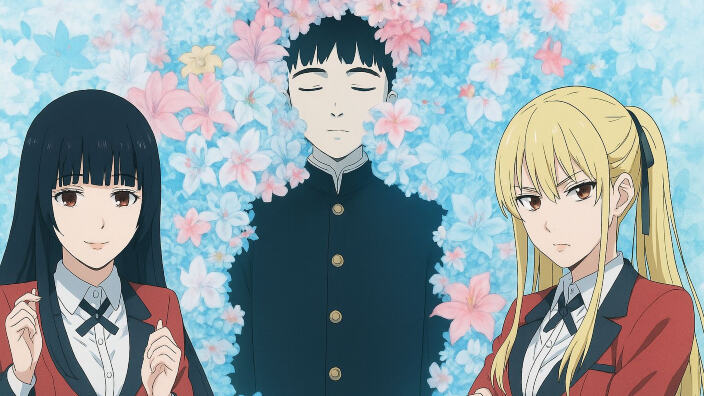


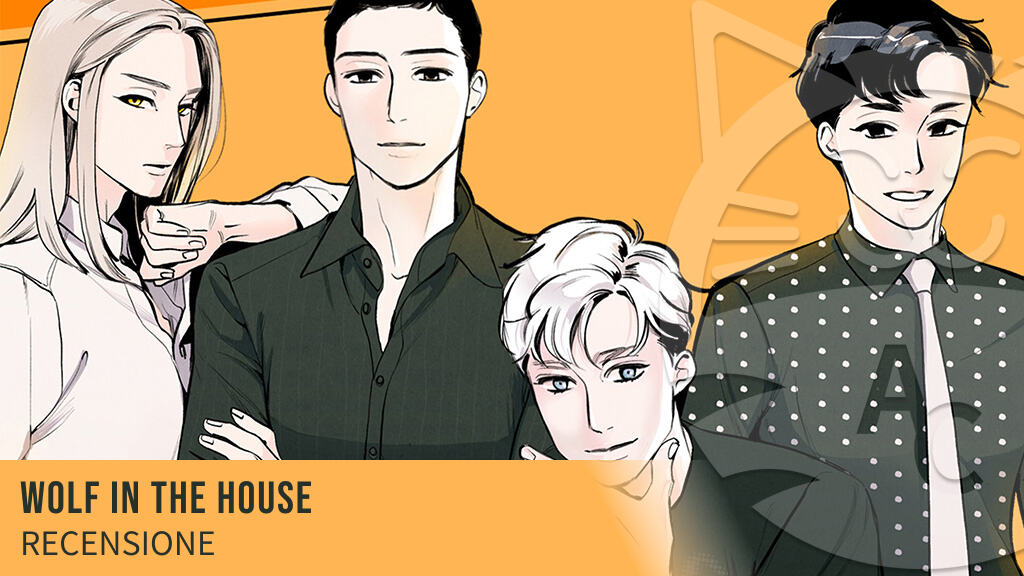




Bisognerebbe prenderla e studiarla per come oggi questa generazione guardi i film e tiri fuori simili riflessioni...
Certo almeno un 7 pieno glielo avrei dato.
Voto molto, troppo basso, io avrei dato un 9 pieno...
Musiche, disegni e sfondi ancora oggi fanno la loro figura, per l'epoca a mio parere erano addirittura eccellenti... per il resto:
Non userei i termini "lezioso" e "facilona"... la caratterizzazione del personaggio (così come per "Mononoke Hime") è ben fatta e ben chiara, senza quel lato perderebbe quel qualcosa grazie al quale riesce a prendere alcune decisioni durante lo scorrere della storia, invece per quanto riguarda il finale è in linea con la strada presa dal lungometraggio, più che "facilona" io dire coerente.
"Nausicaä della Valle del Vento" è un piccolo capolavoro, pochi altri film possono dire di essere invecchiati così bene.
Da vedere, consigliato!
[img]https://lh3.googleusercontent.com/21vLt3hVYI5ce_s-gB1-gdLMr0vriEF60WWkiBj9XsndJUTt7MgXHZVXtLyiHjAF2mNt_DoAp0EsUwQuSI3Ml5fG5BXemFcQGgUbNDEy[/img]
Detto questo, il film di Nausicaa vale almeno un 8,5/10, anche se è " stile è figlio di un filone dell'animazione assai datato" (WTF?). Certo, il manga è praticamente un 10, ma l'anime è ottimo. Da guardare in originale, con sottotitoli adeguati però.
Ho guardato, curiosamente abbiamo gusti simili ...
Allora vuol dire che è si è piegato alla corrente di oggi.
QUel mondo creato in Nausicaa, all'epoca, era avanti ed è unico tutt'oggi.
Come personaggio, poi, è stato per non so quanti anni il preferito di ogni amante di animazione, testimoniato con sondaggi e altro ...scalzato con l'arrivo di Nadia nel 89 ...
Plastic Memories è piuttosto insignificante, un semplice 6 sarebbe bastato.
Shinsekai Yori è una serie particolare e di spessore, ma il voto lo trovo troppo alto. Anche se mi è piaciuto personalmente non mi ha lasciato molto, forse perchè i personaggi non sono riusciti a trasmettermi niente di particolare.
@miriam22 guarda qui, diamine, gia solo plastic memories è ben piu lungo della rece dei sospiri. cavolo...eh si........ahahahha
beh, c'era piu tempo libero...ahahahahahahah...
Più che monco l'anime ha un suo finale ben definito, tant'è che il villain principale è un personaggio che nel manga diventa un personaggio di supporto alla nostra eroina Nausicaa. In pratica più che una trilogia di film bisognerebbe realizzare una bella serie di almeno 26 o più episodi ripartendo da zero. Purtroppo non credo che Miyazaki sia interessato ad un progetto del genere, forse un giorno lontano lo studio Ghibli potrebbe produrlo, ma ci vuole un regista davvero in gamba, che forse non è ancora nemmeno nato!
Dallo studio non sono mai usciti nuovi film dopo il principale e non credo che per ora cambieranno strada, ma mai dire mai...
Sul film ho già scritto, per me merita parecchio anche così.
Sicuro che merita, è solo un peccato che il manga di Nausicaa, così ricco di personaggi unici e messaggi profondi non sia stato animato completamente, un po' come è un peccato che Alita nel 2021 abbia ricevuto solo 2 striminziti OAV e un film hollywoodiano che non rende assolutamente giustizia all'opera originale.
Mi trovi assolutamente d'accordo, ma questo penso valga per tutti... avessero messo in piedi un progetto più "completo" o più ampio ne sarebbe sicuramente uscito un risultato ancora migliore e più approfondito...
Non posso che essere d'accordo anche su Alita, peccato veramente, hanno perso una buona occasione...
Leggendo questi vecchi classici, ogni tanto noto somiglianze con lavori più recenti e penso "ah, ecco da dove ne viene l'ispirazione!"
Poi anche i disegni diventano sempre più belli, più si va avanti.
Anche i personaggi dei cattivi sono interessanti, Kushana è una persona che ha commesso errori, ma che è cmq una persona intelligente e per bene.
Poi c'è anche il simbolismo di tutti i dettagli.
Il finale, poi.... molto interessante anche quello.
Con tutti i film scrausi che compra e trasmette su Rai 4 potrebbe probabilmente comprare qualche serie decente all'anno, farle doppiare e riportare in auge l'anime night settimanale.
Seeee magari... In Rai vedono gli anime come i cavoli a merenda, da sempre. Freccero e Morelli con Rai 4 facevano quello che potevano ai tempi, ma quando Freccero se ne è andato l'hanno rovinata. Ormai è una guerra persa. Se per miracolo dovesse esserci un ritorno, dopo un po' ci penserebbero le solite mummie anti-anime a chiudere i rubinetti: come appunto hanno fatto con Rai 4 e Rai Gulp, e prima ancora con Rai 2.
A me piacerebbe avere anche una serie TV (animata, giapponese, forse Madhouse farebbe un ottimo lavoro) di Eden di Hiroki Endo.
Ma non penso che, dopo tutto questo tempo, qualcuno lo proponga. Non si sa mai però.
Brava (ottima scelta Eden) non si sa mai... (hanno annunciato anche l'anime di Spriggan a distanza di tanti anni).
Alla vostra lista aggiungo MPD Psycho e Battle Royale e sarei una foca molto felice.
Sarà logico per Miyazaki
Infatti adoro "Now and then, Here and There" che descrive una situazione tipo alla Miyazaki, ma con le conseguenze della realtà.
Non tutte le distopie devono finir male, così come il genere umano non si è estinto - o almeno non ancora - di fronte a pandemie, guerre, siccità, carestie, inquinamento...non è che una storia deve sempre avere un finale tragico per essere epica.
E comunque sì, il manga di Nausicaa è molto meglio del film.
Si, ma i baffoni?
Ti sei offeso per i baffoni?
No, mi chiedevo solo che problema avessi con i baffoni...😂
Osservo che nella vecchia animazione giapponese, e con vecchia mi riferisco principalmente a quella fino agli anni '70 (ma in parte anche '80), in buona parte i personaggi secondari venivano in qualche modo omologati anche figurativamente. Gli ometti con il baffone gigante mi sembra una raffigurazione abbastanza cartoonesca e macchiettistica, un poco naif. Detto questo è solo un'osservazione, non una critica. Un po' come in Capitan Harlock, molti personaggi secondari sono dei nanetti bruttini, mentre Harlock è il figone di turno, alto slanciato e col capello ribelle. E a me piace la serie di Capitan Harlock.
Ma da quel punto di vista, disegnatori come che so, Hideo Yamamoto (l'autore di "Homunculus") hanno fatto cose più interessanti. Tutto qui. 😂
Poi in realtà l'aspetto che per me ha abbassato molto la valutazione di questo film di Nausicaa è il finale... Nausicaa è una specie di figura sacra, è un messia. E a me interessa di più un approccio realistico. Da quel punto di vista preferisco alcuni film di Isao Takahata come Kaguya Hime, Pioggia di Ricordi o Una tomba per le lucciole. Detto questo, il film in questione mi piace. E ho l'impressione che alcuni abbiano definito la mia recensione un "obbrobrio" solo perché non ho innalzato Nausicaa a capolavoro del secolo, oppure perché non ho detto che è una schifezza immane. Per alcuni le vie di mezzo sono un optional.
Comunque chi ha usato la parola "obbrobrio" ha nei suoi anime preferiti Evangelion, visto questo capisco tutto !
Nausicaa è un'opera con un approccio parecchio realistico, a prescindere dal fatto che la protagonista sia vista come un messia o la salvatrice del mondo. In fondo non è altro che una novella Giovanna D'Arco finita in mezzo ad una guerra più grande di lei. La differenza è che una si trovava a combattere contro gli inglesi nel XV secolo, l'altra in un mondo post-apocalittico in rovina, contro diverse minacce. Ma Nausicaa non diventa messia perché prescelta da qualche divinità, lo diventa suo malgrado a causa del susseguirsi degli eventi e grazie ai suoi pregi ed anche i suoi difetti.
Nausicaa è letteralmente "il condottiero in abito blu" profetizzato dalla vecchia indovina, e dopo che lei viene investita dall'orda di Vermi Re viene salvata dagli stessi perché... perché lei è Nausicaa. Everybody loves a happy ending...
Nausicaa è una ragazza trascinata in una successione di eventi più grande di lei, esattamente come Giovanna D'Arco. Lascia stare le profezie...
Perché non devo considerare il film nella sua interezza e ignorarne delle parti?
Perché focalizzarsi su una profezia che non ha poi questa grande importanza, soprattutto nel manga dove viene praticamente (e giustamente) dimenticata nella seconda parte della storia, quando ciò che conta è il "cammino dell'eroina"?
Beh, ma io parlo del film, il manga è tutt'altra questione e sicuramente mi è piaciuto molto di più del film.
Profezia o meno, il finale del film mi è sembrato gratuitamente lieto.
E ci credo, non c'era il tempo di espandere ulteriormente la storia, il ”lieto fine” era l'unica strada percorribile a quel punto. Il finale del manga è sicuramente migliore, ma ci sarebbe voluto almeno un altro film (se non 2) per arrivarci. In ogni caso, da estimatore di finali non troppo allegri, un finale ottimista ogni tanto male non fa.
Tutto si può fare, non era l'unica strada percorribile.
Io ho recensito il film indipendente dalla storia originale cartacea e da cosa avrebbero e non avrebbero potuto fare, perché non è detto che chiunque guardi quel film si sia anche letto il fumetto.
Ho visto il film di Nausicaa prima di sapere chi fosse Miyazaki o lo studio Ghibli (a momenti manco sapevo fosse stato prodotto in Giappone) a puntate su Big, mitica trasmissione per ragazzi di rai1, poi diverse volte nei decenni successivi, quando finalmente è stato possibile reperirlo in home video. Ho sempre pensato che fosse un gran bel film con un finale più che adeguato, soddisfacente per la maggior parte del pubblico. Certo, dopo aver letto il manga mi sarebbe piaciuto vedere animato tutto il ricco e sfaccettato mondo che Miyazaki ha creato, pieno di personaggi e situazioni memorabili. Magari tra 50 anni qualcuno ci metterà le mani sopra, finalmente, e darà vita e colore alla "vera" Nausicaa.
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.