Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle recensioni su anime e manga, realizzate degli utenti di AnimeClick.it.
Se volete farne parte anche voi... rimboccatevi le maniche e recensite!
Ricordiamo che questa rubrica non vuole essere un modo per giudicare in maniera perentoria i titoli in esame, ma un semplice contesto in cui proporre delle analisi che forniscano, indipendentemente dal loro voto finale, spunti interessanti per la nascita di discussioni, si auspica, costruttive per l'utenza.
Per saperne di più continuate a leggere.
Se volete farne parte anche voi... rimboccatevi le maniche e recensite!
Ricordiamo che questa rubrica non vuole essere un modo per giudicare in maniera perentoria i titoli in esame, ma un semplice contesto in cui proporre delle analisi che forniscano, indipendentemente dal loro voto finale, spunti interessanti per la nascita di discussioni, si auspica, costruttive per l'utenza.
Per saperne di più continuate a leggere.
Neon Genesis Evangelion
9.5/10
Utente109323
-
Cosa dire dell’anime più amato, odiato e studiato della recente animazione giapponese che non sia già stato detto? Cominciamo per ora con un semplice consiglio: recuperatelo nella versione con lo storico doppiaggio italiano, probabilmente il migliore che sia mai stato fatto in Italia per un anime.
Trovarsi a scrivere qualcosa su un’opera così completa e complessa come “Neon Genesis Evangelion” è un po’ come volersi esprimere in modo originale sulla Gioconda: tutto è già stato espresso, analizzato e assimilato dai vari appassionati. Eppure, nonostante questo, il messaggio nascosto fra le pieghe dell’opera di Anno non cessa di sgomentarci e farci riflettere come la prima volta. Sappiamo a memoria ogni snodo narrativo, conosciamo ogni personaggio come fosse un nostro parente, ci scopriamo a recitare alcune battute prima ancora che queste vengano pronunciate. Ma ad ogni visione, che sia Netflix o il sito di streaming più scadente, un sussulto ci scuote fin nel profondo, ci fa riflettere e invogliare a rivederlo. E questo perché, sebbene noi non troviamo quasi più nulla da dire su di lui, “Neon Genesis Evangelion” ha e avrà ancora tanto da dire a noi come solo i più grandi classici (senza specificare di animazione) sanno fare.
Tutto ciò non sarebbe mai stato possibile se Hideaki Anno, grande maestro di sensibilità prima ancora che genio visionario, non avesse saputo mettere nell’opera tutto sé stesso, frase che in questo caso non risulta affatto un semplice modo di dire. Se ci guardiamo intorno durante la serie non possiamo che rintracciarlo dovunque: gli sguardi sfuggevoli di Shinji, il raro sorriso di Rei, la sprezzante maschera di superiorità di Asuka, ogni espressione o scenario ci rimanda inevitabilmente al suo creatore, quel giovane otaku fragile e depresso che fino a poco tempo prima aveva meditato anche il suicidio.
E’ uno schiaffo che scuote l’anima “Neon Genesis Evangelion”, un risveglio autoimposto, un grido d’amore e al tempo stesso di repulsione nei confronti della vita, che, seppur insidiosa e piena di delusioni, vale la pena di essere affrontata e vissuta, non da spettatori ma da protagonisti attivi; prendendo il coraggio a due mani si può finalmente calcare quel caotico palcoscenico che è il mondo, andando incontro ai rischi ma soprattutto agli altri esseri umani che insieme con noi percorrono lo stesso cammino insidioso. “Congratulazioni”, dicono infatti i personaggi a Shinji, alter ego dell’Anno insicuro e solitario, per aver accettato la sfida di uscire dalla zona di comfort. Applauso che viene riservato anche a tutti coloro che sapranno compiere il medesimo grande passo. Poco importa se alcuni anni dopo lo stesso Anno ritratterà in parte la sua visione ottimistica del finale di serie con lo splendido “End of Evangelion”: il messaggio di incitamento resta sempre lo stesso.
La profonda attualità dell’opera sta proprio in questo: con un’intuizione quasi premonitrice il grande regista ha saputo anticipare e descrivere quelle che oggi si configurano come grandi problematiche sociali, come il mal di vivere. Sono persone profondamente sole quelle descritte in modo magistrale dalla serie, costantemente interconnesse fra di loro, ma in realtà incapaci di comunicare davvero. Il senso di desolazione e di inquietudine, che permea i primi episodi in modo minore, si fa più asfissiante man mano che gli episodi passano, compiendo quello che è un totale ripiegamento della serie su sé stessa; via la questione della fine del mondo, via il problema degli intrighi politici, tutto passa in secondo piano per portare all’attenzione degli spettatori il grande dramma che si sta consumando sotto gli occhi di tutti: il deterioramento e la fine dei rapporti umani.
E così accade che Gendo sia incapace di rivolgere anche una sola parola d’affetto al figlio, che Misato non possa instaurare una relazione stabile con Kaji o meglio ancora che Shinji non riesca ad esprimere i suoi sentimenti ad Asuka.
La sessualità latente è in effetti un altro motore di riflessione in “Neon Genesis Evangelion”, che stimola e sospinge quello che a conti fatti è il rapporto più complesso dell’intero anime: Shinji e Asuka sono due personaggi costruiti con un gusto e un’intelligenza unici, apparentemente diversi ma in realtà complementari, che tuttavia si dimostrano incapaci di esprimersi nel modo che l’altro vorrebbe, facendo naufragare ogni possibile apertura, l’incomunicabilità declinata in amore.
Questi e tanti altri argomenti si susseguono in ventisei puntate che, in un crescendo di emozioni, paralizzano lo spettatore anche e soprattutto per la componente visiva: Anno recupera quelli che sono i design dei robot di Go Nagai degli anni ’80 per omaggiarli e reinterpretarli in un modo del tutto originale. Gli affascinanti EVA sono creature ben più che artificiali caratterizzate da uno stile semplice ma iconico, che non tralascia nessun dettaglio. Lo Studio Gainax, con il character design curato da Yoshiyuki Sadamoto, fa il resto, confezionando un prodotto di tutto rispetto per quanto riguarda gli sfondi e le animazioni, seppur funestate in alcuni frangenti da ristrettezze di budget, non sempre aggirate nel migliore dei modi, ma comunque godibili. Fino ad arrivare agli ormai celeberrimi e chiacchierati episodi 25-26, in cui la povertà di risorse si sposa alla perfezione con le ambizioni visionarie di Anno, che riesce a creare qualcosa di mai visto prima.
E proprio ad Hideaki Anno vanno dedicate altre due parole per il suo lavoro da regista: consapevole di certe limitazioni e forte di un’idea ben precisa, egli ha saputo creare qualcosa che si avvicina al grande cinema d’autore, con soluzioni visive degne dei migliori artisti (poi superate da “End of Evangelion”), in grado di dare nuovo volto e nuova dignità all’animazione giapponese, che da quel lontano 1995 settano altri standard qualitativi: un lavoro semplicemente sensazionale.
Tanto ci potrebbe essere ancora da speculare, ma preferisco concludere con un altro consiglio: oltre a guardare “Neon Genesis Evangelion”, lasciate che sia “Neon Genesis Evangelion” a guardarvi dentro. Fate in modo che le vicende di Shinji, Asuka e Rei diventino anche le vostre; solo così alla fine vi accorgerete di essere diventati parte di loro stessi.
Trovarsi a scrivere qualcosa su un’opera così completa e complessa come “Neon Genesis Evangelion” è un po’ come volersi esprimere in modo originale sulla Gioconda: tutto è già stato espresso, analizzato e assimilato dai vari appassionati. Eppure, nonostante questo, il messaggio nascosto fra le pieghe dell’opera di Anno non cessa di sgomentarci e farci riflettere come la prima volta. Sappiamo a memoria ogni snodo narrativo, conosciamo ogni personaggio come fosse un nostro parente, ci scopriamo a recitare alcune battute prima ancora che queste vengano pronunciate. Ma ad ogni visione, che sia Netflix o il sito di streaming più scadente, un sussulto ci scuote fin nel profondo, ci fa riflettere e invogliare a rivederlo. E questo perché, sebbene noi non troviamo quasi più nulla da dire su di lui, “Neon Genesis Evangelion” ha e avrà ancora tanto da dire a noi come solo i più grandi classici (senza specificare di animazione) sanno fare.
Tutto ciò non sarebbe mai stato possibile se Hideaki Anno, grande maestro di sensibilità prima ancora che genio visionario, non avesse saputo mettere nell’opera tutto sé stesso, frase che in questo caso non risulta affatto un semplice modo di dire. Se ci guardiamo intorno durante la serie non possiamo che rintracciarlo dovunque: gli sguardi sfuggevoli di Shinji, il raro sorriso di Rei, la sprezzante maschera di superiorità di Asuka, ogni espressione o scenario ci rimanda inevitabilmente al suo creatore, quel giovane otaku fragile e depresso che fino a poco tempo prima aveva meditato anche il suicidio.
E’ uno schiaffo che scuote l’anima “Neon Genesis Evangelion”, un risveglio autoimposto, un grido d’amore e al tempo stesso di repulsione nei confronti della vita, che, seppur insidiosa e piena di delusioni, vale la pena di essere affrontata e vissuta, non da spettatori ma da protagonisti attivi; prendendo il coraggio a due mani si può finalmente calcare quel caotico palcoscenico che è il mondo, andando incontro ai rischi ma soprattutto agli altri esseri umani che insieme con noi percorrono lo stesso cammino insidioso. “Congratulazioni”, dicono infatti i personaggi a Shinji, alter ego dell’Anno insicuro e solitario, per aver accettato la sfida di uscire dalla zona di comfort. Applauso che viene riservato anche a tutti coloro che sapranno compiere il medesimo grande passo. Poco importa se alcuni anni dopo lo stesso Anno ritratterà in parte la sua visione ottimistica del finale di serie con lo splendido “End of Evangelion”: il messaggio di incitamento resta sempre lo stesso.
La profonda attualità dell’opera sta proprio in questo: con un’intuizione quasi premonitrice il grande regista ha saputo anticipare e descrivere quelle che oggi si configurano come grandi problematiche sociali, come il mal di vivere. Sono persone profondamente sole quelle descritte in modo magistrale dalla serie, costantemente interconnesse fra di loro, ma in realtà incapaci di comunicare davvero. Il senso di desolazione e di inquietudine, che permea i primi episodi in modo minore, si fa più asfissiante man mano che gli episodi passano, compiendo quello che è un totale ripiegamento della serie su sé stessa; via la questione della fine del mondo, via il problema degli intrighi politici, tutto passa in secondo piano per portare all’attenzione degli spettatori il grande dramma che si sta consumando sotto gli occhi di tutti: il deterioramento e la fine dei rapporti umani.
E così accade che Gendo sia incapace di rivolgere anche una sola parola d’affetto al figlio, che Misato non possa instaurare una relazione stabile con Kaji o meglio ancora che Shinji non riesca ad esprimere i suoi sentimenti ad Asuka.
La sessualità latente è in effetti un altro motore di riflessione in “Neon Genesis Evangelion”, che stimola e sospinge quello che a conti fatti è il rapporto più complesso dell’intero anime: Shinji e Asuka sono due personaggi costruiti con un gusto e un’intelligenza unici, apparentemente diversi ma in realtà complementari, che tuttavia si dimostrano incapaci di esprimersi nel modo che l’altro vorrebbe, facendo naufragare ogni possibile apertura, l’incomunicabilità declinata in amore.
Questi e tanti altri argomenti si susseguono in ventisei puntate che, in un crescendo di emozioni, paralizzano lo spettatore anche e soprattutto per la componente visiva: Anno recupera quelli che sono i design dei robot di Go Nagai degli anni ’80 per omaggiarli e reinterpretarli in un modo del tutto originale. Gli affascinanti EVA sono creature ben più che artificiali caratterizzate da uno stile semplice ma iconico, che non tralascia nessun dettaglio. Lo Studio Gainax, con il character design curato da Yoshiyuki Sadamoto, fa il resto, confezionando un prodotto di tutto rispetto per quanto riguarda gli sfondi e le animazioni, seppur funestate in alcuni frangenti da ristrettezze di budget, non sempre aggirate nel migliore dei modi, ma comunque godibili. Fino ad arrivare agli ormai celeberrimi e chiacchierati episodi 25-26, in cui la povertà di risorse si sposa alla perfezione con le ambizioni visionarie di Anno, che riesce a creare qualcosa di mai visto prima.
E proprio ad Hideaki Anno vanno dedicate altre due parole per il suo lavoro da regista: consapevole di certe limitazioni e forte di un’idea ben precisa, egli ha saputo creare qualcosa che si avvicina al grande cinema d’autore, con soluzioni visive degne dei migliori artisti (poi superate da “End of Evangelion”), in grado di dare nuovo volto e nuova dignità all’animazione giapponese, che da quel lontano 1995 settano altri standard qualitativi: un lavoro semplicemente sensazionale.
Tanto ci potrebbe essere ancora da speculare, ma preferisco concludere con un altro consiglio: oltre a guardare “Neon Genesis Evangelion”, lasciate che sia “Neon Genesis Evangelion” a guardarvi dentro. Fate in modo che le vicende di Shinji, Asuka e Rei diventino anche le vostre; solo così alla fine vi accorgerete di essere diventati parte di loro stessi.
Texhnolyze
7.0/10
Ci sono corde che non si spezzano mai, tese su abissi profondi ma robuste come ponti che sanno dove portano.
Uno di questi ponti è Chiaki J. Konaka, sceneggiatore culto della nuova animazione seriale nipponica. Konaka è un cultore di quelle filosofie "dell'oltre", che non rivelano le loro mete e possono lasciare oscuro anche il percorso. Col suo stile, dal sapore criptico e dal peso autoriale, spesso riesce però a fornire un affresco composito di realtà che altrimenti non sarebbero proponibili al di fuori della speculazione.
A volte però le istanze descrittive non hanno basi così salde come si spera.
Nell'anime "Texhnolyze" di Hiroshi Hamazaki (sceneggiato da Konaka) si coglie perfettamente il rischio insito nell'ansia descrittiva di temi e modelli filosofici che dai testi allo schermo possono diventare dei ponti traballanti.
L'idea è quella di proporre un mondo ipotetico, un racconto metaforico che non offre allo spettatore facili interpretazioni. Col suo approccio che si può definire a pieno titolo cinematografico, l'anime è un meccanismo complesso, fatto di simbologie e richiami culturali. Un gioco di incastri, dove ogni elemento ha una sua semantica.
La trama si rivela mano a mano nel corso dei ventidue episodi, dove assistiamo al dipanarsi delle disavventure di una cittadina di nome Lux. Questo centro è preda di bande e gruppi organizzati che, a vari livelli, si contendono il potere e le gerarchie urbane, in un clima di conflittualità costante o di pace apparente.
Tre fazioni in particolare sono protagoniste degli eventi principali.
L'Organo, una sorta di enclave mafiosa che ricorda la yakuza per struttura ed estetica, e di cui il maggior esponente è Onishi.
L'Unione, un omaggio alle organizzazioni rivoluzionarie afroamericane alla Black Panthers.
Il Racan, un gruppo più piccolo guidato da Shinji, costituito perlopiù da giovani teppisti che vivono alla giornata, insinuandosi nei giochi di potere del loro piccolo mondo.
Mondo al quale si affianca il piccolo villaggio di Gabe, una realtà appartata, che vive di un tradizionalismo istituzionalizzato in un culto e in una setta, incentrati sulla figura di Ran, una profetessa bambina, oracolo dalle visioni profetiche.
In questo composito scenario vagano altri protagonisti, come Ichise, un reietto dell'Organo che cerca la sua ragione per sopravvivere, anche grazie ai miraggi della tecnica fornitagli dalla scienziata Kaneda (detta Doc); e come Yoshi, un misterioso e anonimo ometto dall'apparenza innocua.
Lux è una città in preda al totale degrado, moderna ma allo stesso tempo richiamo ad espressioni antiche (come evocato dal suo nome), teatro di sviluppo del texhnolyze, una sofisticata tecnologia che permette la fusione biomeccanica fra l'Uomo e la techne, grazie alla quale si possono sostituire arti mancanti e perfezionare il corpo umano. Un risultato ottenuto anche grazie al raffia, sostanza a metà fra il mistico e il tecnico, la cui estrazione e produzione è la fonte di sostentamento di Lux.
Il tutto all'ombra della Classe (al cui vertice siede Kano, un'eminenza grigia), altro misterioso ente che sembra osservare e dirigere dall'alto le miserie e i drammi degli abitanti della città.
L'affresco è pregno di temi e binari simbolici che appagano lo spettatore con la forza espressiva del cyberpunk e con rimandi mistici, giochi di potere e intimismo teatrale.
Il palcoscenico è una via di mezzo fra un deserto post-apocalittico e un primitivismo vibrante. Una sintesi fra le aberrazioni distopiche della techne e l'arcaismo teosofico di Lux(or?), al cui centro campeggia un obelisco dal vivido senso faraonico, emblema dal sapore biblico che evoca la religione cristiana nella premessa dell'origine stessa della città, rifugio sotterraneo, avello infernale per sconfitti ed esuli da una superficie paradiso miltonianamente perduto.
Lux è definita come il nono cerchio dell'Inferno, in chiara derivazione dantesca, ma allo stesso tempo è un'utopica illusione circonfusa di luce (lux?), un eterno nulla, orologio senza orologiaio, ma col suo icastico gnomone che sovrasta e osserva tutto e tutti, occhio sul baratro ove strisciano i dannati.
La contrapposizione manichea tra il materico e lo spirituale, tra l'utilitaristico e il mistico, tra il
texhnolyze e il raffia, è affiancata da dualismi e paralleli che trovano una loro ragion d'essere ma che appesantiscono un quadro che vive di un insospettabile barocchismo.
I giochi sui doppi contrapposti, su richiami circolari a continui ritorni, si palesano in un complesso sistema speculare dove tutto è inizio e fine allo stesso tempo, ognuno e ogni cosa è in relazione di definizione a qualcos'altro.
L'Organo è la forza di sistema, lo status quo che si impone con i suoi simulacri e le sue livree di presunto dominio. La prassi burocratica la cui vetrina del texhnolyze offre sempre lo stesso codice da legge della giungla.
L'Unione è la risposta contraria, l'alternativa alla sottomissione dell'individuo agli schemi prometeici della tecnica. La voce degli esclusi che, sotto la bandiera di "Anima, Corpo, Verità, Salvezza, Vendetta!", cerca la fuga dagli ingranaggi chapliniani dei tempi moderni.
Il Racan è la deriva anarcoide, strada obbligata degli ultimi fra gli ultimi nella piramide del destino.
Gabe e il suo culto sono la sintesi del messianismo, della resa esoterica al Fato delfico che non concepisce nulla al di là di ciò che si presume scritto nelle stelle.
Gli stessi personaggi non sfuggono al gioco di specchi, dove i ruoli sono fissi e involutivi.
Onishi è la forza devozionale, la garanzia di ordine gerarchico retto dalla costanza samuraica.
Ichise è l'ansia dell'Io che annaspa in eterno per cercare l'uscita dal non essere.
Shinji è il guitto senza scopi, vittima di un torpore autoreferenziale.
Doc è la fede negli idoli del progresso e della Scienza.
Ran è la deriva pitica dell'imponderabile, Cassandra ontologicamente prigioniera.
Kano è il profeta eterodosso che eleva il fanatismo a forma d'arte.
Questi artifici tortili però alla lunga divengono freddi ghirigori, dove la passionalità e il vigore decantano in semantiche che sanno di ornamentale più che di concreto.
Le maschere, quelle vere e quelle metaforiche, finiscono per omologarsi in una galleria di sguardi vuoti, oltre la sfera del semiotico, divenendo feticci dagli occhi senza anima.
La vis citazionista impera, soppesando le sbavature con segnacoli dal forte impatto ammonitore. La struttura del mondo, platonicamente diviso tra due realtà, tra sopra e sotto, tra Inferno e Paradiso, Vita e Morte, si deforma nel tentativo di rendere sempre quel gioco di circolarità dello spazio e del tempo, scombinando le certezze e ribaltando le definizioni.
Così ecco che la superficie si rivela essere un Paradiso falso, abitato da spettri, un trono vuoto, sfinge che parla per enigmi che nessuno ascolta; la Classe si rivela un falso demiurgo che vuole imporre l'ennesimo ordo seclorum sotto l'egida di Parche decrepite, che citano le streghe di macbethiana memoria. E Lux è il nulla senza fine, una voragine che si autoalimenta, come una divinità annoiata che specula sulla sua immortalità.
Il gioco dei rimandi è così netto da diventare parte integrante dei sottotesti tematici.
Se la semidesertica Lux sembra uscire da un ipotetico Medio Oriente in cui la fusione tra tecnologia e urbanesimo sembra già un concetto obsoleto, la superficie è invece una sequela diafana ed eterea di opere di Hopper dove trionfa l'art déco, rendendo egregiamente il concetto di vetustà dell'Eden, illusione ormai plausibile quanto gli sfondi di un set cinematografico.
Il tono distopico delle vicende è un'interessante parabola dai contenuti anche sociali, con la dicotomia tra il mondo sotto/sopra che ricorda la semantica fabiana della contrapposizione tra Eloi e Morlock ideata da H.G. Wells, ma con un interessante rovesciamento degli schemi dove, sempre in fede al gioco speculare, le vittime diventano carnefici e viceversa.
Un topos fantapolitico che cita anche importanti precursori come Zardoz.
I richiami simbolici, come l'obelisco (che ermeticamente funge da catalizzatore mistico e tecnologico), il tessuto antropologico (che in Gabe trova una summa nella cultura shintoista o nell'estetica del teatro No, più volte citato) o la simbiosi organico/meccanico (che si espleta in contorte fusioni fra il subliminale e il sovraliminale), sono un cardine talmente portante dell'opera che alla lunga diventa un canone affascinante ma dalla complessa natura rizomatica. Una complessità che lascia spazio a possibili smagliature nell'ordito ottenuto.
L'equilibrio dell'anime è infatti vittima di diverse idiosincrasie che stemperano il quadro complessivo.
Una di queste è il richiamo al pensiero e alla filosofia di Nietzsche.
Se sono intuibili (non sempre) gli omaggi all'eterno ritorno o alla volontà delle "bestie selvatiche", spesso il gioco diventa dispersivo e fumoso. In particolare riguardo alla figura dell'ubermensch, che vive sottotraccia un po' in tutte le dramatis personae, ma che si tende a identificare soprattutto col personaggio di Yoshi.
E anche qui siamo di fronte a una resa disarmonica.
Yoshi non contempla tutte le caratteristiche del modello iperantropico. Abbraccia il nichilismo attivo, gode di pura e catartica estasi nella demolizione degli idoli, ma non li abbatte tutti. Abbandona il "no" della superficie per il "sì" del sottosuolo, ma poi si informa e si intromette nel risiko di Lux. Anche lui si serve del texhnolyze, e si fa viatico della techne, l'idolo per eccellenza.
L'archetipo nietzschiano non avrebbe interesse per gli eventi e le architetture dello Stato. Non crede nella Scienza o nelle sirene della realtà (o delle pseudo-realtà). Non persegue trame né schemi teleologici.
L'amor fati del misterioso ometto coi baffi non sa di olimpica osmosi col mondo, ma di puntata sul gioco d'azzardo. Se ne va col sorriso sulle labbra, ma nel tentativo di squarciare luci soteriche.
Al vero pagliaccio non interessa il fato degli spettatori.
L'oltreuomo non è un vigile che indica strade epifaniche ma un bambino che squarta i suoi giocattoli perché hanno il marchio di fabbrica. Non vaga nell'ombra o in incognito, ma arde sulla terra come un secondo sole.
Il vero ubermensch avrebbe danzato sulle note di Mozart o dell'heavy metal, ebbro dell'esaltazione panica del leone che urla "Ich will". Un titano dell'edoné che gronda gioie consunte e sprizza promesse infrante.
Yoshi invece è solo un turista della vacuità, un pastore della noia che urina sulle file di formiche per infantile diletto. Il suo nichilismo non odora di sardonico furore ma di asettico onanismo.
Non è lo scettro di Shiva né uno dei volti di Brahma, solo un impiegato che simula uno sguardo da gatto sornione.
Abbandona il suo sacro assenso per il mediocre "sì" dei servi, torna cammello dopo aver scrollato la soma.
La potenza tecnica dell'anime è invece pienamente coerente.
I tempi soffusi ed eterei si alternano a momenti di azione e violenza cangiante dove, pur non cedendo alle lusinghe dello splatter, si coglie pienamente la consistenza materica del caos organico o del metallo urlante.
Un punto di forza è il chara di Yoshitoshi ABe, che regala una galleria di figure formi e informi, eleganti o dimesse, ripugnanti e seducenti. La perizia di ABe si coglie per esempio nella resa delle figure anziane, che evocano un'avvenenza perduta ma ancora vibrante quanto quella dei giovani, come ad esempio quella di personaggi maschili come Ichise o Kano, dall'estetica sensuale e androgina, paradigma di quella iconodulia del bello che ricorda l'omoerotica del mondo greco.
Le evocative scene di stampo ascetico, accompagnate da un comparto musicale dal sound altrettanto spirituale, sono alternate a sprazzi di futurismo techno dove l'arrangiamento è in linea col tono sci-fi della trama.
"Texhnolyze" aspira a proporre grandi temi con enfasi metaforica e vis speculativa, citazioni e trame complesse. Ma il risultato non è sempre ben coordinato, lasciando spazio a tecnicismi e virtuosismi che ammortizzano il peso tematico e simbolico.
La potenza ermetica di Konaka è sempre presente, ma le sue vette sono livellate da ritmi di regia altalenanti e climax reiterati non sempre originali.
Si percepiscono meno lo sperimentalismo e il pothos ermeneutico che facevano la grandezza di altre sue firme come "Serial Experiments Lain".
A dispetto delle sempre eleganti istanze anastasiche del culto di Gabe, l'aquila e il serpente ridono delle maschere di "Texhnolyze". Un'opera senza dubbio ambiziosa e singolare, ma che cammina su un campo minato non sempre con la dovuta attenzione, rischiando molto. Forse troppo.
Uno di questi ponti è Chiaki J. Konaka, sceneggiatore culto della nuova animazione seriale nipponica. Konaka è un cultore di quelle filosofie "dell'oltre", che non rivelano le loro mete e possono lasciare oscuro anche il percorso. Col suo stile, dal sapore criptico e dal peso autoriale, spesso riesce però a fornire un affresco composito di realtà che altrimenti non sarebbero proponibili al di fuori della speculazione.
A volte però le istanze descrittive non hanno basi così salde come si spera.
Nell'anime "Texhnolyze" di Hiroshi Hamazaki (sceneggiato da Konaka) si coglie perfettamente il rischio insito nell'ansia descrittiva di temi e modelli filosofici che dai testi allo schermo possono diventare dei ponti traballanti.
L'idea è quella di proporre un mondo ipotetico, un racconto metaforico che non offre allo spettatore facili interpretazioni. Col suo approccio che si può definire a pieno titolo cinematografico, l'anime è un meccanismo complesso, fatto di simbologie e richiami culturali. Un gioco di incastri, dove ogni elemento ha una sua semantica.
La trama si rivela mano a mano nel corso dei ventidue episodi, dove assistiamo al dipanarsi delle disavventure di una cittadina di nome Lux. Questo centro è preda di bande e gruppi organizzati che, a vari livelli, si contendono il potere e le gerarchie urbane, in un clima di conflittualità costante o di pace apparente.
Tre fazioni in particolare sono protagoniste degli eventi principali.
L'Organo, una sorta di enclave mafiosa che ricorda la yakuza per struttura ed estetica, e di cui il maggior esponente è Onishi.
L'Unione, un omaggio alle organizzazioni rivoluzionarie afroamericane alla Black Panthers.
Il Racan, un gruppo più piccolo guidato da Shinji, costituito perlopiù da giovani teppisti che vivono alla giornata, insinuandosi nei giochi di potere del loro piccolo mondo.
Mondo al quale si affianca il piccolo villaggio di Gabe, una realtà appartata, che vive di un tradizionalismo istituzionalizzato in un culto e in una setta, incentrati sulla figura di Ran, una profetessa bambina, oracolo dalle visioni profetiche.
In questo composito scenario vagano altri protagonisti, come Ichise, un reietto dell'Organo che cerca la sua ragione per sopravvivere, anche grazie ai miraggi della tecnica fornitagli dalla scienziata Kaneda (detta Doc); e come Yoshi, un misterioso e anonimo ometto dall'apparenza innocua.
Lux è una città in preda al totale degrado, moderna ma allo stesso tempo richiamo ad espressioni antiche (come evocato dal suo nome), teatro di sviluppo del texhnolyze, una sofisticata tecnologia che permette la fusione biomeccanica fra l'Uomo e la techne, grazie alla quale si possono sostituire arti mancanti e perfezionare il corpo umano. Un risultato ottenuto anche grazie al raffia, sostanza a metà fra il mistico e il tecnico, la cui estrazione e produzione è la fonte di sostentamento di Lux.
Il tutto all'ombra della Classe (al cui vertice siede Kano, un'eminenza grigia), altro misterioso ente che sembra osservare e dirigere dall'alto le miserie e i drammi degli abitanti della città.
L'affresco è pregno di temi e binari simbolici che appagano lo spettatore con la forza espressiva del cyberpunk e con rimandi mistici, giochi di potere e intimismo teatrale.
Il palcoscenico è una via di mezzo fra un deserto post-apocalittico e un primitivismo vibrante. Una sintesi fra le aberrazioni distopiche della techne e l'arcaismo teosofico di Lux(or?), al cui centro campeggia un obelisco dal vivido senso faraonico, emblema dal sapore biblico che evoca la religione cristiana nella premessa dell'origine stessa della città, rifugio sotterraneo, avello infernale per sconfitti ed esuli da una superficie paradiso miltonianamente perduto.
Lux è definita come il nono cerchio dell'Inferno, in chiara derivazione dantesca, ma allo stesso tempo è un'utopica illusione circonfusa di luce (lux?), un eterno nulla, orologio senza orologiaio, ma col suo icastico gnomone che sovrasta e osserva tutto e tutti, occhio sul baratro ove strisciano i dannati.
La contrapposizione manichea tra il materico e lo spirituale, tra l'utilitaristico e il mistico, tra il
texhnolyze e il raffia, è affiancata da dualismi e paralleli che trovano una loro ragion d'essere ma che appesantiscono un quadro che vive di un insospettabile barocchismo.
I giochi sui doppi contrapposti, su richiami circolari a continui ritorni, si palesano in un complesso sistema speculare dove tutto è inizio e fine allo stesso tempo, ognuno e ogni cosa è in relazione di definizione a qualcos'altro.
L'Organo è la forza di sistema, lo status quo che si impone con i suoi simulacri e le sue livree di presunto dominio. La prassi burocratica la cui vetrina del texhnolyze offre sempre lo stesso codice da legge della giungla.
L'Unione è la risposta contraria, l'alternativa alla sottomissione dell'individuo agli schemi prometeici della tecnica. La voce degli esclusi che, sotto la bandiera di "Anima, Corpo, Verità, Salvezza, Vendetta!", cerca la fuga dagli ingranaggi chapliniani dei tempi moderni.
Il Racan è la deriva anarcoide, strada obbligata degli ultimi fra gli ultimi nella piramide del destino.
Gabe e il suo culto sono la sintesi del messianismo, della resa esoterica al Fato delfico che non concepisce nulla al di là di ciò che si presume scritto nelle stelle.
Gli stessi personaggi non sfuggono al gioco di specchi, dove i ruoli sono fissi e involutivi.
Onishi è la forza devozionale, la garanzia di ordine gerarchico retto dalla costanza samuraica.
Ichise è l'ansia dell'Io che annaspa in eterno per cercare l'uscita dal non essere.
Shinji è il guitto senza scopi, vittima di un torpore autoreferenziale.
Doc è la fede negli idoli del progresso e della Scienza.
Ran è la deriva pitica dell'imponderabile, Cassandra ontologicamente prigioniera.
Kano è il profeta eterodosso che eleva il fanatismo a forma d'arte.
Questi artifici tortili però alla lunga divengono freddi ghirigori, dove la passionalità e il vigore decantano in semantiche che sanno di ornamentale più che di concreto.
Le maschere, quelle vere e quelle metaforiche, finiscono per omologarsi in una galleria di sguardi vuoti, oltre la sfera del semiotico, divenendo feticci dagli occhi senza anima.
La vis citazionista impera, soppesando le sbavature con segnacoli dal forte impatto ammonitore. La struttura del mondo, platonicamente diviso tra due realtà, tra sopra e sotto, tra Inferno e Paradiso, Vita e Morte, si deforma nel tentativo di rendere sempre quel gioco di circolarità dello spazio e del tempo, scombinando le certezze e ribaltando le definizioni.
Così ecco che la superficie si rivela essere un Paradiso falso, abitato da spettri, un trono vuoto, sfinge che parla per enigmi che nessuno ascolta; la Classe si rivela un falso demiurgo che vuole imporre l'ennesimo ordo seclorum sotto l'egida di Parche decrepite, che citano le streghe di macbethiana memoria. E Lux è il nulla senza fine, una voragine che si autoalimenta, come una divinità annoiata che specula sulla sua immortalità.
Il gioco dei rimandi è così netto da diventare parte integrante dei sottotesti tematici.
Se la semidesertica Lux sembra uscire da un ipotetico Medio Oriente in cui la fusione tra tecnologia e urbanesimo sembra già un concetto obsoleto, la superficie è invece una sequela diafana ed eterea di opere di Hopper dove trionfa l'art déco, rendendo egregiamente il concetto di vetustà dell'Eden, illusione ormai plausibile quanto gli sfondi di un set cinematografico.
Il tono distopico delle vicende è un'interessante parabola dai contenuti anche sociali, con la dicotomia tra il mondo sotto/sopra che ricorda la semantica fabiana della contrapposizione tra Eloi e Morlock ideata da H.G. Wells, ma con un interessante rovesciamento degli schemi dove, sempre in fede al gioco speculare, le vittime diventano carnefici e viceversa.
Un topos fantapolitico che cita anche importanti precursori come Zardoz.
I richiami simbolici, come l'obelisco (che ermeticamente funge da catalizzatore mistico e tecnologico), il tessuto antropologico (che in Gabe trova una summa nella cultura shintoista o nell'estetica del teatro No, più volte citato) o la simbiosi organico/meccanico (che si espleta in contorte fusioni fra il subliminale e il sovraliminale), sono un cardine talmente portante dell'opera che alla lunga diventa un canone affascinante ma dalla complessa natura rizomatica. Una complessità che lascia spazio a possibili smagliature nell'ordito ottenuto.
L'equilibrio dell'anime è infatti vittima di diverse idiosincrasie che stemperano il quadro complessivo.
Una di queste è il richiamo al pensiero e alla filosofia di Nietzsche.
Se sono intuibili (non sempre) gli omaggi all'eterno ritorno o alla volontà delle "bestie selvatiche", spesso il gioco diventa dispersivo e fumoso. In particolare riguardo alla figura dell'ubermensch, che vive sottotraccia un po' in tutte le dramatis personae, ma che si tende a identificare soprattutto col personaggio di Yoshi.
E anche qui siamo di fronte a una resa disarmonica.
Yoshi non contempla tutte le caratteristiche del modello iperantropico. Abbraccia il nichilismo attivo, gode di pura e catartica estasi nella demolizione degli idoli, ma non li abbatte tutti. Abbandona il "no" della superficie per il "sì" del sottosuolo, ma poi si informa e si intromette nel risiko di Lux. Anche lui si serve del texhnolyze, e si fa viatico della techne, l'idolo per eccellenza.
L'archetipo nietzschiano non avrebbe interesse per gli eventi e le architetture dello Stato. Non crede nella Scienza o nelle sirene della realtà (o delle pseudo-realtà). Non persegue trame né schemi teleologici.
L'amor fati del misterioso ometto coi baffi non sa di olimpica osmosi col mondo, ma di puntata sul gioco d'azzardo. Se ne va col sorriso sulle labbra, ma nel tentativo di squarciare luci soteriche.
Al vero pagliaccio non interessa il fato degli spettatori.
L'oltreuomo non è un vigile che indica strade epifaniche ma un bambino che squarta i suoi giocattoli perché hanno il marchio di fabbrica. Non vaga nell'ombra o in incognito, ma arde sulla terra come un secondo sole.
Il vero ubermensch avrebbe danzato sulle note di Mozart o dell'heavy metal, ebbro dell'esaltazione panica del leone che urla "Ich will". Un titano dell'edoné che gronda gioie consunte e sprizza promesse infrante.
Yoshi invece è solo un turista della vacuità, un pastore della noia che urina sulle file di formiche per infantile diletto. Il suo nichilismo non odora di sardonico furore ma di asettico onanismo.
Non è lo scettro di Shiva né uno dei volti di Brahma, solo un impiegato che simula uno sguardo da gatto sornione.
Abbandona il suo sacro assenso per il mediocre "sì" dei servi, torna cammello dopo aver scrollato la soma.
La potenza tecnica dell'anime è invece pienamente coerente.
I tempi soffusi ed eterei si alternano a momenti di azione e violenza cangiante dove, pur non cedendo alle lusinghe dello splatter, si coglie pienamente la consistenza materica del caos organico o del metallo urlante.
Un punto di forza è il chara di Yoshitoshi ABe, che regala una galleria di figure formi e informi, eleganti o dimesse, ripugnanti e seducenti. La perizia di ABe si coglie per esempio nella resa delle figure anziane, che evocano un'avvenenza perduta ma ancora vibrante quanto quella dei giovani, come ad esempio quella di personaggi maschili come Ichise o Kano, dall'estetica sensuale e androgina, paradigma di quella iconodulia del bello che ricorda l'omoerotica del mondo greco.
Le evocative scene di stampo ascetico, accompagnate da un comparto musicale dal sound altrettanto spirituale, sono alternate a sprazzi di futurismo techno dove l'arrangiamento è in linea col tono sci-fi della trama.
"Texhnolyze" aspira a proporre grandi temi con enfasi metaforica e vis speculativa, citazioni e trame complesse. Ma il risultato non è sempre ben coordinato, lasciando spazio a tecnicismi e virtuosismi che ammortizzano il peso tematico e simbolico.
La potenza ermetica di Konaka è sempre presente, ma le sue vette sono livellate da ritmi di regia altalenanti e climax reiterati non sempre originali.
Si percepiscono meno lo sperimentalismo e il pothos ermeneutico che facevano la grandezza di altre sue firme come "Serial Experiments Lain".
A dispetto delle sempre eleganti istanze anastasiche del culto di Gabe, l'aquila e il serpente ridono delle maschere di "Texhnolyze". Un'opera senza dubbio ambiziosa e singolare, ma che cammina su un campo minato non sempre con la dovuta attenzione, rischiando molto. Forse troppo.
WorldEnd
7.0/10
Recensione di dawnraptor
-
“WorldEnd” (per brevità) è un anime in dodici episodi tratto da una light novel sicuramente più ampia delle vicende che descrive.
Partendo con ordine, ho trovato adeguati i fondali e le animazioni, molto piacevole il chara design. Ho gradito particolarmente la rappresentazione degli occhi dei protagonisti, anche se in un paio di occasioni parevano concavi invece che convessi. Gradevole anche la rappresentazione delle ali. Sufficienti i mostri. I doppiatori fanno lodevolmente il loro lavoro.
La storia che qui si racconta ruota attorno alle vicende di una coppia formata da Willem Kmetsch, un militare, e Chtholly Nota Seniorious, una ragazza che scopriamo presto essere qualcosa di diverso da quello che appare.
L’ambientazione è apparentemente quella di un mondo in guerra: cinquecento anni dopo la grande catastrofe che ha visto l’umanità estinguersi ad opera di “bestie” mostruose, i pochi superstiti, in una moltitudine di razze animali antropomorfe, sopravvivono su isole nel cielo, assediati dai mostri in superficie.
Willem, che è rimasto pietrificato per cinque secoli, viene riportato in vita e gli viene affidata la cura delle armi più particolari: le uniche che possano brandire delle spade magiche che, solo loro, possono ferire e uccidere le “bestie”. Willem è l’unico essere umano rimasto, unico esemplare di una razza che viene, a torto o a ragione, accusata di aver distrutto il pianeta. Oggi l’avere aspetto umano è, molto spesso, causa di disprezzo e odio. Un episodio sarà dedicato a problematiche sociali di integrazione sociale vs. segregazione.
Su questo sfondo si sviluppa la timida storia d’amore tra Chtholly e Willem, un giovane di età incerta, che prima di essere pietrificato aveva dei figli (edit: si tratta di compagni di orfanotrofio? Grazie, pippo311lp), e che nasconde comunque un passato oscuro. Allo stesso modo, anche Chtholly ha un passato misterioso e un futuro molto incerto, così come tutte le sue compagne, il cui unico scopo nella vita è - o dovrebbe essere - combattere per gli altri e morire alla bisogna.
Le premesse per un anime magnifico c’erano tutte, ma qualcosa è andato storto. In una serie di soli dodici episodi è stato dato, almeno per la mia opinione di spettatrice, decisamente troppo tempo alle interazioni tra le ragazze e le bambine e alla vita quotidiana in quello che potrebbe essere considerato una specie di collegio, a scapito dell’azione e di qualche spiegazione in più su quelle che sono le cause della situazione in essere.
Per essere un mondo in guerra, assediato dalle “bestie” su tutti i fronti, non si avverte nessuna sensazione di agitazione, solo una gran tristezza che permea ogni cosa, soprattutto per via del triste destino delle fate. Ci sono pochissime battaglie, e quelle poche mancano spesso di pathos. L’attesa per il ritorno delle guerriere non genera ansia in chi guarda, è tutto molto piatto. Soprattutto, moltissime cose non vengono spiegate. Se un’idea di chi siano le fate e di come siano venute in essere le “bestie” alla fine ce la facciamo, continueremo per sempre a domandarci da dove arrivino tutte le razze animali antropomorfe che ora popolano le isole nel cielo, visto che cinquecento anni sono pochi per una mutazione. Non è chiarissima nemmeno la situazione dei capintesta. Il finale aperto ci lascia, almeno apparentemente, con una vaga sensazione di speranza, ma poca aspettativa per una eventuale seconda serie che ormai, passati tre anni, difficilmente ci sarà.
Si ha l’impressione che tutta la storia sia solo il pretesto per sviluppare la storia d’amore tra i due protagonisti principali. Peccato che lo svolgimento non sia condotto in modo molto interessante e le elucubrazioni personali dei due in merito, così come quelle di coppia, risultino spesso noiose e a volte forzate.
Quello che ho veramente apprezzato, più che la storia romantica, di cui si sarebbe potuto anche fare a meno senza nulla togliere all’anime, è la situazione di Willem, il suo essere l’unico superstite, cosa che, in realtà, parrebbe aver preso fin troppo bene. Ma il colpo di scena degli ultimi episodi, quando si trova fra le rovine della sua vecchia città, è forse il migliore di tutta l’opera. La sua disperazione in quel frangente è, per me, il culmine di tutta la serie, non le vicende di Chtholly, con buona pace del tragico destino suo e delle sue compagne.
In tutta questa dissertazione non ho ancora parlato di uno degli aspetti positivi di quest’opera, forse in assoluto la cosa migliore: la colonna sonora.
Si parte con “Farborough Fair”, ennesimo adattamento di un pezzo del 1600 che ha più cover di un negozio di dischi. Ma questa versione non ha nulla da invidiare a quelle che l’hanno preceduta e contribuisce a farci entrare nell’immaginario dell’opera. È un pezzo di pathos innegabile, di un respiro amplissimo, che riesce a rendere malinconici anche vedendo un sorriso. Perché, conoscendone tutto il testo, già si capisce dove, poi, si andrà a parare. Il tema verrà poi ripetuto in uno degli ultimi episodi.
Ma anche tutto il resto del commento musicale è pregevole e ben si presta a commentare la scena, e anche opening ed ending sono molto gradevoli. Insomma, OST promossa su tutta la linea.
Alla fine della visione resta un po’ di amaro in bocca per un’occasione tutto sommato sprecata. Sì, la visione in generale è gradevole, ma non entusiasmante. Avrebbe potuto essere un fuoco d’artificio e invece ci si ritrova in mano una di quelle stelline di Capodanno. Carine, per carità, ma il fuoco vero è altrove.
Partendo con ordine, ho trovato adeguati i fondali e le animazioni, molto piacevole il chara design. Ho gradito particolarmente la rappresentazione degli occhi dei protagonisti, anche se in un paio di occasioni parevano concavi invece che convessi. Gradevole anche la rappresentazione delle ali. Sufficienti i mostri. I doppiatori fanno lodevolmente il loro lavoro.
La storia che qui si racconta ruota attorno alle vicende di una coppia formata da Willem Kmetsch, un militare, e Chtholly Nota Seniorious, una ragazza che scopriamo presto essere qualcosa di diverso da quello che appare.
L’ambientazione è apparentemente quella di un mondo in guerra: cinquecento anni dopo la grande catastrofe che ha visto l’umanità estinguersi ad opera di “bestie” mostruose, i pochi superstiti, in una moltitudine di razze animali antropomorfe, sopravvivono su isole nel cielo, assediati dai mostri in superficie.
Willem, che è rimasto pietrificato per cinque secoli, viene riportato in vita e gli viene affidata la cura delle armi più particolari: le uniche che possano brandire delle spade magiche che, solo loro, possono ferire e uccidere le “bestie”. Willem è l’unico essere umano rimasto, unico esemplare di una razza che viene, a torto o a ragione, accusata di aver distrutto il pianeta. Oggi l’avere aspetto umano è, molto spesso, causa di disprezzo e odio. Un episodio sarà dedicato a problematiche sociali di integrazione sociale vs. segregazione.
Su questo sfondo si sviluppa la timida storia d’amore tra Chtholly e Willem, un giovane di età incerta, che prima di essere pietrificato aveva dei figli (edit: si tratta di compagni di orfanotrofio? Grazie, pippo311lp), e che nasconde comunque un passato oscuro. Allo stesso modo, anche Chtholly ha un passato misterioso e un futuro molto incerto, così come tutte le sue compagne, il cui unico scopo nella vita è - o dovrebbe essere - combattere per gli altri e morire alla bisogna.
Le premesse per un anime magnifico c’erano tutte, ma qualcosa è andato storto. In una serie di soli dodici episodi è stato dato, almeno per la mia opinione di spettatrice, decisamente troppo tempo alle interazioni tra le ragazze e le bambine e alla vita quotidiana in quello che potrebbe essere considerato una specie di collegio, a scapito dell’azione e di qualche spiegazione in più su quelle che sono le cause della situazione in essere.
Per essere un mondo in guerra, assediato dalle “bestie” su tutti i fronti, non si avverte nessuna sensazione di agitazione, solo una gran tristezza che permea ogni cosa, soprattutto per via del triste destino delle fate. Ci sono pochissime battaglie, e quelle poche mancano spesso di pathos. L’attesa per il ritorno delle guerriere non genera ansia in chi guarda, è tutto molto piatto. Soprattutto, moltissime cose non vengono spiegate. Se un’idea di chi siano le fate e di come siano venute in essere le “bestie” alla fine ce la facciamo, continueremo per sempre a domandarci da dove arrivino tutte le razze animali antropomorfe che ora popolano le isole nel cielo, visto che cinquecento anni sono pochi per una mutazione. Non è chiarissima nemmeno la situazione dei capintesta. Il finale aperto ci lascia, almeno apparentemente, con una vaga sensazione di speranza, ma poca aspettativa per una eventuale seconda serie che ormai, passati tre anni, difficilmente ci sarà.
Si ha l’impressione che tutta la storia sia solo il pretesto per sviluppare la storia d’amore tra i due protagonisti principali. Peccato che lo svolgimento non sia condotto in modo molto interessante e le elucubrazioni personali dei due in merito, così come quelle di coppia, risultino spesso noiose e a volte forzate.
Quello che ho veramente apprezzato, più che la storia romantica, di cui si sarebbe potuto anche fare a meno senza nulla togliere all’anime, è la situazione di Willem, il suo essere l’unico superstite, cosa che, in realtà, parrebbe aver preso fin troppo bene. Ma il colpo di scena degli ultimi episodi, quando si trova fra le rovine della sua vecchia città, è forse il migliore di tutta l’opera. La sua disperazione in quel frangente è, per me, il culmine di tutta la serie, non le vicende di Chtholly, con buona pace del tragico destino suo e delle sue compagne.
In tutta questa dissertazione non ho ancora parlato di uno degli aspetti positivi di quest’opera, forse in assoluto la cosa migliore: la colonna sonora.
Si parte con “Farborough Fair”, ennesimo adattamento di un pezzo del 1600 che ha più cover di un negozio di dischi. Ma questa versione non ha nulla da invidiare a quelle che l’hanno preceduta e contribuisce a farci entrare nell’immaginario dell’opera. È un pezzo di pathos innegabile, di un respiro amplissimo, che riesce a rendere malinconici anche vedendo un sorriso. Perché, conoscendone tutto il testo, già si capisce dove, poi, si andrà a parare. Il tema verrà poi ripetuto in uno degli ultimi episodi.
Ma anche tutto il resto del commento musicale è pregevole e ben si presta a commentare la scena, e anche opening ed ending sono molto gradevoli. Insomma, OST promossa su tutta la linea.
Alla fine della visione resta un po’ di amaro in bocca per un’occasione tutto sommato sprecata. Sì, la visione in generale è gradevole, ma non entusiasmante. Avrebbe potuto essere un fuoco d’artificio e invece ci si ritrova in mano una di quelle stelline di Capodanno. Carine, per carità, ma il fuoco vero è altrove.
I collegamenti ad Amazon fanno parte di un programma di affiliazione: se effettui un acquisto o un ordine attraverso questi collegamenti, il nostro sito potrebbe ricevere una commissione.















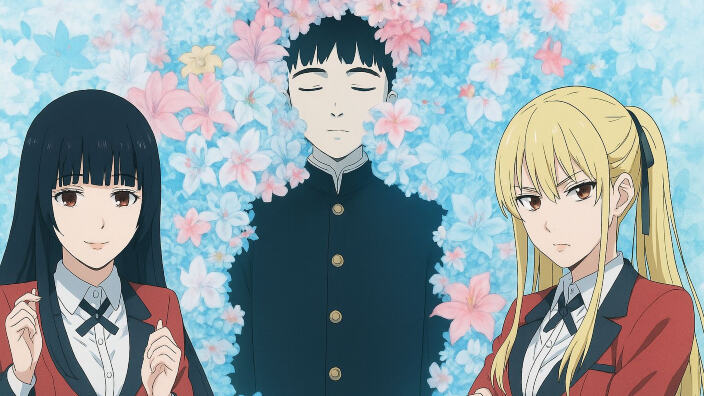








Per l'epoca fu rivoluzionario sotto tanti punti di vista, soprattutto rapportato al budget a disposizione di Gainax, ma la serie ha tantissimi difetti ed ingenuità, come le tantissime sequenze animate riciclate per risparmiare soldi e quei due episodi finali che puzzano tutt'ora di "non sapevamo come concludere la serie".
Resta comunque un lavoro eccellente a cui è impossibile dare meno di 8 nella valutazione complessiva.
WorldEnd ha un solo e grosso difetto: la lentezza e l'adattamento.
Non ho letto la novel, ma è chiaro come il sole che siano stati fatti tantissimi tagli, i buchi narrativi sono più che palesi soprattutto sul passato di Willem.
L'inizio è molto bello, così come il finale; avessero dato più cura alla parte centrale sarebbe stato un'ottima serie anche questa, ma non la vedo oltre la sufficienza.
WorldEnd condivido il voto e in buona parte anche la recensione di @dawnraptor, il finale molto molto discutibile con tutte le interrogazione del perchè / come ( solo un accenno ) della distruzione della terra e del passato dei vari protagonisti lasciate ampiamente in sospeso.
Si inaugura il 2021 con un capodanno di sangue con quel voto
In primis, chino umilmente la testa di fronte alla mia incredibile presenza qui.
In secondo luogo, su Evangelion preferisco autocensurarmi per evitare il ban a vita. Dai, si capisce lo stesso cosa ne pensi...
E per quanto riguarda la splendida dissertazione su Texhnolyze, devo dire che forse io l'ho sopravvalutato un pochino, ma, per quanto lentissimo e sicuramente pesante, sono veramente felice di averlo guardato. Non lo riguarderò, ma...
Ho visto gli ultimi minuti con la bocca aperta e una lacrima che non riusciva a scendere. Mi sembra quasi di essere in lutto. Non potrei rivederlo, ma dovevo vederlo. Potente. Disturbante.Obbligatorio.
Secondo me lui è davvero un superuomo, ma non il superuomo idealizzato da Nietzsche che in quanto archetipo risulta inesistente non solo nella realta ma anche in una finzione scritta bene. Non potendo portarti nuovi elementi sul piano fllosofico (sarebbe arrogante) te ne porto sul piano storico.
Yoshii mi ricorda molto come gli uomini del 900 hanno messo in pratica i concetti superoministi.
Trovo molta somiglianza fra Yoshii che scende a Lux e un D'annunzio che sbarca a Fiume, o ancora meglio un Mussolini nel suo periodo svizzero con il suo socialismo reazionario. Yoshii come i suoi omologhi storici ha lo stesso disprezzo sia verso il borghese della superficie che poltrisce nell'inazione sai verso il povero che si rifiuta di "vivere pericolosamente" per ottenere qualcosa.
Nel contesto di finzione di texhnolyze, Yoshii per me si può davvero considerare pienamente un ubermensch, anche se figlio di QUEI tempi più che degli scritti di Nietzsche.
Concordo, è esageratamente basso.
Classica risposta di un fanboy di Evangelion.
Caro @Thorgrim come vedi non sempre siamo divergenti sulle opinioni, quoto buona parte di ciò che hai scritto.
Purtroppo WorldEnd è minato dal fatto di essere una mera trasposizione atta a vendere la novel, un vero peccato perché avrebbe meritato sicuramente una trasposizione migliore.
Devo inoltre trovare il tempo di visionare Texhnolyze, la recensione del buon @2247 mi ha messo curiosità.
Vedi, la cosa che trovo divertente e allo stesso tempo ridicola, è che ho pure tessuto le lodi su come Anno e Gainax siano riusciti a far uscire un lavoro che meno di 8 non merita con i pochi soldi che avevano a disposizione! xD
A prescindere da tutto, 9,5 è un voto esagerato per tantissime serie e anche io in passato ho messo voti così esagerati alla mentula canis preso dal momento di esaltazione che una serie in quel frangente era riuscita a darmi.
Per i pollici versi oramai non ci faccio più caso, soprattutto quando si parla di serie intoccabili come Evangelion, è la norma, l'importante è non aver insultato nessuno e aver detto con serenità quello che penso: bello e da vedere, ma non un capolavoro.
WorldEnd purtroppo ha fatto la fine di tantissime trasposizioni di novel che non vedranno mai una S2. Purtroppo per noi, i gusti del mercato giapponese sono diversi da quelli di noi occidentali e spesso ci restano sul groppone serie che abbiamo apprezzato molto, ma che magari in patria hanno riscosso un tiepido successo che non ha spinto alla produzione di una S2 (le prime serie che mi vengono in mente sono Alderamin on the Sky, Saga of Tanya the Evil - che nonostante il film, ha tantissimo materiale tagliato rispetto al manga che invece è più fedele alla novel -, e Hataraku Maou-sama!, ma la lista è molto più lunga ed impietosa).
Dobbiamo starci, meglio anche una sola stagione che niente.
E' questo uno dei tanti motivi per cui spero che l'inclusione di competitor dello streaming occidentali come Netflix ed Amazon evitino il ripetersi di questo genere di produzioni, come anche una più lungimirante gestione delle trasposizioni, che non possono di certi 'arroccarsi' alla mera vendita del cartaceo, non di certo visto quanto il media sta crescendo a livello internazionale in questi anni.
Su Evangelion ho scritto talmente tanto che mi sono stufato su questo blog, pertanto non aggiungo altro rispetto a quanto hai scritto.
Mah, non credo che si tratti di una questione di quantità di competitor sul mercato che, fra le altre cose, sono già presenti come Netflix.
Molti editori vedono le trasposizioni solo ed esclusivamente come degli investimenti per aumentare le vendite del proprio media di origine (novel, manga o anime che sia), poi se va bene, s'investe ancora sperando in un bis.
Mi viene in mente l'esempio recente di I'm Standing on a Million Lives, il cui anime ha letteralmente triplicato le vendite del manga da cui è tratto al punto che faranno anche una S2.
Un caso in cui ciò non è successo è Eromanga Sensei dove speravano di bissare il successo avuto da Oreimo, ma, nonostante l'eccellente comparto tecnico, la serie ha avuto più critiche che vendite e non avrà mai una S2. L'adattamento manga, stranamente, è andato ben oltre un'ipotetica S2, quindi significa che sta avendo buoni riscontri.
La "giusta via" per soddisfare i nostri gusti è sperare negli Originals come quelli di Crunchyroll e Netflix, serie coprodotte rivolte ad un pubblico occidentale (perché se non fosse stato per Amazon, col cavolo che potevamo vedere l'adattamento, per quanto tagliato, de L'immortale).
Il mio non voleva essere un discorso sulla quantità sia chiaro, ma è innegabile, come hai anche scritto tu, che l'inserimento di Amazon, Netflix o Crunchryoll abbia portato una più lungimirante cura delle trasposizioni delle opere originali.
Spero quindi, come anche ti auguri tu, che la coproduzione delle trasposizioni dia modo a quelle che lo meritino di avere delle stagioni più strutturate e meno travagliate, perché è assurdo che dobbiamo assistere ad oggi a delle produzioni monche.
Non aggiungo altro perché gli esempi che hai portato testimoniano chiaramente le problematiche del fenomeno, pertanto sperare che si assottigli è quello si possa augurare un vero appassionato dell'animazione giapponese.
Capisco che è un mio limite.
Ho letto e apprezzato le recensioni di @schop e @dawnraptor, anche se WorldEnd non l'ho mai visto. Ma il discorso sulla colonna sonora mi ha incuriosito.
@ataru moroboshii In realtà hai colto perfettamente il punto.
Il personaggio di Yoshii si allontana da un modello prettamente nietzschiano.
C'è un errore comune sull'identificazione dell'ubermensch, dovuto soprattutto alle arbitrarie interpretazioni delle destre (ma in parte anche delle sinistre) in campo politico e culturale.
D'Annunzio infatti fu proprio uno dei protagonisti cardine di queste errate interpretazioni.
Tant'è vero che alcuni studiosi oggi prediligono la traduzione del termine in italiano con "oltreuomo" piuttosto che "superuomo". Non solo perché lo si ritiene filosoficamente più corretto, ma soprattutto perché "superuomo" è diventato sinonimo di realtà ormai lontanissime dal concetto originale (in particolare nella cultura pop).
Questo volevo sottolineare nella recensione.
Complimenti a @2247, @schop e @dawnraptor e un grazie: leggere recensioni interessanti anche, se non soprattutto, di opere che non credo siano troppo nelle mie corde è uno dei grandi piaceri che mi dà questo sito
Evangelion è un classico. Capolavoro, che piaccia o meno. Io preferisco Nadia ma Eva è stato devastante all'epoca, forse in maniera esagerata ma è la realtà. Il picco, il massimo raggiunto dalla serie, il capolavoro assoluto, sono gli ultimi due episodi, da poter scrivere un saggio!
Ma guarda in generale concorderei (tristemente) con quello che dici ma devo dire che per quanto riguarda la quasi totalità degli utenti del sito hanno saputo dimostrare una maturità che va oltre la bellezza degli effetti speciali.
Per il resto il problema di fondo è quella scala di giudizio che in realtà dovrebbe essere oggettiva ma è quasi sempre soggettiva. Dare 9,5/ 10 in realtà è quasi impossibile, ma spesso lo dimentichiamo dando questi voti alla leggera, certo parliamo, recensiamo, opere che abbiamo amato, ma anche nell'amore ci vuole il minimo distacco, l'amore non è dire "fai sempre bene" ma è dire "qui potevi far meglio".
Parlando di Evangelion ad esempio una cosa triste è dire "di quale finale parliamo?" Il finale dovrebbe essere (in realtà sempre) quello della serie.
I commenti estremamente positivi o negativi non vanno tenuti in considerazione in quanto frutto di un eccessivo amore/odio verso il prodotto, quindi soggettivi ed inaffidabili.
Per quanto mi riguarda lo ripeto, la serie è ottima, meno di 8 non merita, ma ha dei "difetti" di produzione dovuti al budget limitato che Gainax aveva all'epoca che mi impediscono di acclamarlo come un capolavoro a tutto tondo (e ricordo che se Evangelion non fosse stato quel fenomeno di massa che è diventato, lo studio avrebbe chiuso per bancarotta - parole di Anno)
Hanno fatto un miracolo con i mezzi a disposizione e questo gli va riconosciuto fino alla fine dei giorni, ma i difetti restano e 9.5 è forse un voto dettato più dall'amore verso la serie che non da un'oggettiva valutazione dell'opera in questione (come anche scritto da Focasaggia un paio di commenti sopra questo).
Aggiungo inoltre che molti dei simbolismi sono stati inseriti, a detta dello staff, per rendere il prodotto più figo e fruibile da una maggiore platea possibile, pertanto ad oggi continuare ad idolatrare questa parte dell'opera è insensato, così come ricercare mille mila significati e spiegazioni che non hanno alcun significato se non quello di mero ornamento al plot.
La dura e triste realtà è quella che hai esplicitato e che ancor oggi lo zoccolo duro della fanbase non vuole accettare, hanno prodotto quegli episodi perché non vi era più budget a disposizione, per la cattiva gestione di Hideki Anno, non nuovo a queste abitudini.
Altro discorso poi si potrebbe aprire sui suoi intenti, che non sono altro quelli di continuare a prostituire la sua opera il più possibile, finché la vacca produce, ma questi sono discorsi che esulano dagli argomenti del thread che riguarda la serie animata, pertanto la chiudo qui.
Mi permetto, però, di dissentire umilmente in merito ad alcune cose dette sopra.
Su due elementi siamo sicuramente d’accordo: l’importanza a livello storico della serie e i suoi difetti. I problemi di budget hanno funestato la produzione senza alcun dubbio, ma ciò che ho sempre trovato sensazionale è il messaggio che la serie ha cercato di veicolare e la commistione fra le vicende umane del suo autore e la scrittura dei personaggi.
Ritengo tutt’ora che ciò che Evangelion può dare ad uno spettatore sia qualcosa di unico e non rintracciabile altrove. Quindi, per questa sua capacità di aver intercettato i turbamenti di un periodo storico come quello in cui è stata creata e di intere generazioni, si merita un voto così alto.
Veniamo però a ciò che non condivido: dubito che sia possibile scindere completamente l’oggettività dalla soggettività, visto che qualsiasi opinione sarà sempre dettata da un gusto personale, che influenzerà il giudizio complessivo; se per recensione si intende un giudizio puramente tecnico allora posso condividere l’osservazione, ma se si prende in esame anche il valore contenutistico di una qualsiasi opera in questo caso la soggettività assumerà un ruolo di primo piano. Personalmente ho sempre considerato le recensioni come un insieme delle due cose e in Evangelion la carenza tecnica indiscutibile non ha mai pesato troppo sul mio giudizio.
Il secondo punto è il seguente: dire che i pareri estremamente positivi o estremamente negativi non vadano minimamente presi in considerazione lo trovo sbagliato a priori, per il fatto che al di sotto del semplice voto numerico c’è sempre un testo da leggere. Una volta letto, se tale commento appare come male argomentato o (peggio ancora) per nulla argomentato, allora in quel caso io per primo tendo a non dare peso all’opinione in questione. Ovviamente poi sta al lettore valutare se si trova in linea o meno con quanto è stato detto. Tacciare una critica di inaffidabilità soltanto perché si da per scontato che, in quanto troppo positiva, sia dettata da una sostanziale imparzialità, non mi pare un criterio di valutazione adeguato.
Il problema, purtroppo, sta tutto in quel numero iniziale: 9, 8, 10 sono semplici cifre che non dovrebbero avere un peso determinante tanto quanto quello che viene detto nella recensione.
Ho cercato di argomentare il motivo del mio voto in modo esaustivo, spero di esserci riuscito. Personalmente parlando poi, toglierei i voti da ogni recensione per evitare sterili divergenze su dei valori che variano inevitabilmente da persona a persona, da giudizio a giudizio.
Detto ciò, mi perdonerete il lungo papiro ma ci tenevo a dire la mia, essendo stato (indirettamente) chiamato in causa!
ho dato 3,5 ad Angel's Egg e 5,5 ad Haibane Renmei quindi posso dirmi immune da questo problema.
Finchè esprimi i tuoi pareri va tutto bene, inizia le frasi più lapidarie con un "per me" e non hai più motivo di avere un ansia da prestazione perchè ciò che scrivi sarà comunque la realtà.
Tu hai assolutamente ragione, è più importante cosa si vuole trasmettere con la recensione che il voto espresso, ma ritengo sempre corretto mantenerlo in quanto lo trovo l'unico modo per ottenere una media necessaria per far capire quanto sia piaciuta o meno una serie.
Detto questo un 10 dovrebbe essere dato da un insieme di dati: personaggi(protagonisti-antagonisti-secondari), dialoghi, musiche, messaggio/emozioni che trasmette, coerenza/realismo, animazioni, disegni, regia/montaggio, doppiaggio e finale (volendo ne possiamo aggiungere tanti). Se tutto questo venisse dato sarebbe 9,5-10 a prescindere dai gusti. Certo, capisco il tuo discorso, ma non dico che sia facile, essere obiettivi è un qualcosa di molto difficile per chiunque.
Ad Evangelion sono mancati i fondi, paga quindi diverse cose, fra cui un finale che se lasciamo quello della serie non è un finale, per quanto possiamo considerarlo il finale dell'evoluzione di Shinji, lui è parte della storia non è la storia. Ma tutti concordiamo che sia una grande opera, capolavoro o capolavoro mancato che vogliamo pensarlo.
Mi sento chiamato in causa, quindi mettiamo i puntini sulle "i".
Ribadisco, i commenti estremamente positivi o estremamente negativi, sono, per definizione, degli estremi che non portano argomentazioni valide a proprio supporto (es. "Capolavoro!", "È una me*da!", ecc.), quindi, dal mio personale punto di vista, non sono diversi dal capriccio di un bambino. E per le serie di successo questo tipo di commenti sono la maggioranza.
Se invece l'opinione è argomentata BENE e con cognizione di causa, allora il canone di estremismo viene meno, indifferentemente dal voto finale dato, che sia uno 0 o un 10.
Se per te i film di Lars von Trier sono dei capolavori e me lo argomenti come Dio comanda, io non ho nulla da dire, ma se la tua opinione è per "partito preso" come gli intellettualoidi di fantozziana memoria, allora non la considero proprio.
Ah certo, in questo caso siamo pienamente d’accordo, io credevo che con commenti estremamente positivi o estremamente negativi intendessi quelli con i voti più alti o più bassi, quindi soltanto in relazione ad un giudizio di tipo numerico.
Ovviamente nemmeno io considero mai una recensione se si esprime solo con i quattro termini pre-impostati da te citati.
Sono io che ringrazio te per la risposta esaustivo.
Si, purtroppo la questione dei voti e della loro attribuzione è un annoso problema che non credo troverà mai una soluzione soddisfacente per tutti, si può solo cercare di fare un bel servizio nell’attribuirli, a seconda dei criteri che ciascuno ritiene più importanti per assegnarli.
Sul finale di Evangelion si potrebbe aprire un capitolo a parte in effetti; Anno trascura tutti gli altri argomenti che non siano l’evoluzione psicologica di Shinji, cosa che però ho trovato azzeccata in quanto il focus della storia si stava da tempo spostando verso una maggiore introspezione.
Quella miseria di mezzi si è, in un certo senso, sposata con il messaggio che l’autore voleva trasmettere, rendendolo ancora più potente, a mio giudizio.
Un saluto!
Dopo vent'anni a raccontarle, ste storie, valle a togliere dalla mente delle persone.
Su forza avanti con i non mi piace anche qui, vi sto aspettando. Comunque lo considero un anime da 8 con alcuni episodi da 10, the end invece forse il 9.5 lo merita.
Ah e il secondo film del reboot lo considero la miglior opera legata al brand, mentre il 3.0 la peggiore nonostante non sia brutto.
io l'ho visto all'epoca dell'uscita e ti assicuro che si merita anche 11 di voto specialmente per confronto a cosa uscita nello stesso periodo
ovvio che se le guardi adesso é giusto dire che un 8 va piú che bene dato che le innumerevoli copie e idee prese uscite negli anni successivi e anche adesso
the end of evangelion sono 87 minuti di fan service. Anno voleva fare un anime psicologico mascherato da mecha progetto coraggioso e innovativo, ma i fan volevano il finale action a tutti i costi, cosi lui glielo ha dato, a costo di storpiare tutte le caratterizzazioni dei personaggi. the end of evangelion è come se dopo 2 batman di Nolan si chiudesse la triologia con un batman di Burton.
" l'apocalisse di san giovanni è un pacco Hideaki, sono solo cifre, numeri e simbolismi, non c'è uno straccio di storia. le soluzioni Hideaki sono due o fai l'mpepata di cozze o fai il finale psicologico. "
Il finale classico è quello psicologico
The end of evangelion è l' im'pepata de cozze!
Ummh Evangelion è del 1995-1996, Cowboy Bebop del 1998-1999, parlando del secondo anche fra 20 anni sarà sempre da 9.5/10. Versailles no bara/Lady Oscar è del 1979-1980. Direi che si difende bene (eufemismo) anche ora. Il pensiero che dopo tanti anni una serie possa perdere valore significa solo che quell'opera non ha mai avuto valore. Evangelion non ha mai perso il suo valore, la sua bellezza e non la perderà mai.
Peraltro, si tratta di un voto che mi pare ben argomentato, quindi non vedo il perché di tanta costernazione.
si chiama triggerarsi
Ultima nota al buon "Schop", tra le migliori recensioni che abbia letto qui su animeclick, si vede chiaramente per ha lasciato un segno molto profondo.
Ekros. Le interviste andrebbero lette nella sua interezza. Ma poi, scusa, come ragioni? Che me la citi a fare una intervista? Ce vo' n'intervista per capire che parliamo di un anime? L'arte non si vende solo a significati; quasi tutto in un prodotto televisivo è, a vari livelli, messo per attrarre un pubblico. Sottolineo a vari livelli, perché mi pare che è questo che la gente non capisce. Altrimenti nessuno se li guarda 'sti anime, nessuno paga e nessuno ti sponsorizza. E poi, perdonami. Ma una cosa non può essere messa per far figo e avere comunque un significato? Io posso mettere gli Angeli perché fà tanto figo, ma magari ci costruisco un design che ricalchi i nomi originali, mettendoci un significato. O no? Troppo complicato per te? Non posso neanche dare torto ai creatori. Il cristianesimo e l'arte cristiana sono veramente fighissime. Vedi Obata e i suoi putti barocchi.
C.V.D.
nOn lO vOlETE AccETTaRe. Sai dire qualcos'altro o andiamo avanti?
Comunque. Non t'è chiaro, ma per me Eva è tutt'altro che perfetto, e negli ultimi (s)consigliati rimasi piacevolmente colpito dalla negativa recensione di micheles. Ti consiglio di nuovo di leggere le interviste. Siam tutti bravi a riempirci la bocca di parole, ma qua ci vogliono i fatti. Hideaki Anno, Tsurumaki, la Gainax o Oguro non hanno mai, mai menzionato, accennato o si so' fatti inconsciamente scappare informazioni su un problema di budget. Il problema fu essenzialmente di tempo. L'episodio su Kaworu fu prodotto con Satsukawa e Masayuki in due settimane, quello finale in tre giorni. Con i primi due avevano perso quasi un anno di tempo. Ufficialmente la schedule fu gestita male da Tatsunoko, ma, sì, la cosa non è nuova da parte di Anno. Già Daicon III e IV furono prodotti fino alla mattina prima. Ma, dico io, criticami pure gli episodi. Mi va benissimo che tu mi dica che sono immondizia. Ci sta. Ma informati prima. Non credo ti pretendere troppo, no? E poi, boh, cosa c'è da non accettare? Per me so' belli e accettiamo tutti da venti anni il background che c'è dietro. Mo' arrivi tu e dici qualcosa che nessuno sa, secondo te? Eh, no, caro mio. La vita non funziona così. Questa si chiama presunzione. La vita è ben altro, e ti troverai male così. Te lo dico come consiglio personale, eh.
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.