Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle recensioni su anime e manga, realizzate degli utenti di AnimeClick.it.
Se volete farne parte anche voi... rimboccatevi le maniche e recensite!
Ricordiamo che questa rubrica non vuole essere un modo per giudicare in maniera perentoria i titoli in esame, ma un semplice contesto in cui proporre delle analisi che forniscano, indipendentemente dal loro voto finale, spunti interessanti per la nascita di discussioni, si auspica, costruttive per l'utenza.
Per saperne di più continuate a leggere.
Se volete farne parte anche voi... rimboccatevi le maniche e recensite!
Ricordiamo che questa rubrica non vuole essere un modo per giudicare in maniera perentoria i titoli in esame, ma un semplice contesto in cui proporre delle analisi che forniscano, indipendentemente dal loro voto finale, spunti interessanti per la nascita di discussioni, si auspica, costruttive per l'utenza.
Per saperne di più continuate a leggere.
La canzone del mare
8.0/10
“Con il nome di selkie si identificano talune creature fantastiche appartenenti alla mitologia irlandese, islandese, e scozzese. Secondo le leggende, le selkie vivono nel mare come foche, ma sono in grado di rimuovere il loro manto per assumere un aspetto umano.
Nelle isole scozzesi si credeva che le foche fossero esseri umani trasmutati, per questo si sospettava che ucciderle portasse sfortuna; le storie più diffuse ruotano intorno a personaggi selkie femminili a cui viene rubato il manto e si trovano quindi costrette a restare sulla terraferma. Il manto delle selkie infatti è l'elemento necessario perché possano trasformarsi nuovamente in animali e tornare in mare. Altre storie narrano di come dei personaggi umani non si accorgano di vivere con una selkie e si risveglino una mattina scoprendo che la loro partner... è sparita.”
Mitologia, tribalismo arcaico, pungente sapore di sale, vento gelido e fiabe ancestrali.
Saoirse è una bambina dolcissima, bella, vivace, imprevedibile e incredibilmente coraggiosa. E proprio oggi compie sei anni! Ma... ancora, strano a dirsi, non ha imparato a parlare. Vive con il padre, il fratello maggiore Ben e il cane Cù, un bestione allegro e giocherellone. Tutti insieme abitano sull’isolotto del faro di uno sperdutissimo paese dell’Irlanda del Nord.
In tale scenario freddo, apparentemente inospitale eppur intriso di una magia che lascia trasparire soltanto parte dell’imminente incanto, scopriremo che questa famiglia ha tragicamente smarrito la madre dei due bambini, una bellissima e rassicurante donna di nome Bronagh, proprio il giorno della nascita di Saoirse: una sparizione misteriosa che col tempo è divenuta, inevitabilmente, un lutto da elaborare e infine accettare, poiché di Bronagh non vi sono state più tracce.
Il prologo de “La canzone del mare” ci mostra - in maniera vaga e confusa - la silenziosa ma sofferta scomparsa della donna, evento che ha contribuito a inasprire il rapporto fra Ben e sua sorella minore, collegando in qualche modo quest’ultima alla mancanza dell’adorata madre. Di fronte a una situazione familiare di difficile gestione, comportamenti incoscienti da parte dei ragazzini e un padre intento ad affogare i ricordi legati alla moglie nei pub sulla costa, la nonna di Ben e Saoirse comprende che ormai è aria di cambiare, e decide prenderli e portarli con sé proprio in città, speranzosa che un drastico cambiamento possa promettere ai piccoli un futuro migliore.
Se agli occhi dei piccoli il cambio di dimora possa inizialmente apparire come un peggioramento del tenore di vita, presto si rivelerà un trampolino di lancio verso una realtà oscura, intrigante e incantata, sospesa a metà fra misticismo e tracce di antiche leggende.
Si tratta di un lungometraggio che ci regala atmosfere uniche, un libro di illustrazioni fra il naif e l’allegorico, una pellicola che snocciola immagini meravigliose, colori brillanti, accesi, ricchi di contrasti studiati e preziosi, e nonostante l’incipit si mostri piuttosto amaro e ci comunichi una situazione poco felice, il celtico connubio di suoni e immagini capace di evolversi minuto dopo minuto stupisce e affascina, ammaliando tramite scenari e melodie estremamente curate e coinvolgenti.
Le inflessioni e le venature di radice prettamente nordeuropea si insinuano ovunque, sin dalle prime battute. È un mondo ispirato a leggende norreno-anglosassoni dalle animazioni spigolose, minimali eppure esaustive, plasmanti un clima inflessibile, gelido, rassicurante e misteriosamente affascinante, con un certo retrogusto d’avventura infantile a cui non possiamo assolutamente sottrarci, poiché solletica i nostri ricordi più lontani, radicati nella nostra testa sin da quando eravamo bambini. Esso li stimola, li desta, e infine li riporta a galla in questo gelido mare familiare e spietato, permettendoci di rimembrare com’era sognare quando il mondo ci appariva più semplice e la fantasia si attestava a nostro impalpabile spirito guida.
Premettendo che anche il doppiaggio italiano risulti di grande qualità, lesti ci si ritrova in una fiaba moderna dai contorni antichi e malinconici, a tratti drammatici; un affresco dai fondali traboccanti di sentimenti che ritrae grandi paesaggi ove cieli sterminati si mangiano la scena, divorando spesso e volentieri i raggi del sole e trascinando lo spettatore nelle terre del Nord Europa, magistralmente trasfigurate attraverso impeccabili allegorie minimali. Apprezziamo così orizzonti nuvolosi ed evocativi, scogliere a picco, pioggia battente, contorni confusi e nebbiosi, spesso acquarellati, idratati da pigmenti che si mischiano su carta e danno vita a un rustico realismo virtualmente increspato, genesi d’atmosfere coinvolgenti, ma che non tentano di nascondere grandi, grigie e lugubri città dell’entroterra, dove Halloween è alle porte e la voglia di viaggiare con la fantasia diviene una necessità dell’anima.
Artisticamente parlando non esistono studi di prospettiva, né grandi virtuosismi di sorta. È un continuo sovrapporsi di ritagli d’immagini e colori, un decoupage di contrasti cromatici talvolta gentili, talvolta aspri e ad ogni modo funzionali alla trama; si ha la costante impressione di sfogliare, come già accennato, un libro illustrato dalle pagine cartonate e consumate, un tomo dall’odore di vecchio ma buono che ci trascinerà in un’avventura fuori dal tempo, arricchita da una colonna sonora elaborata, antica e dolce contemporaneamente, vertiginosa quanto basta per cullarci verso una cultura lontana, mistica, algida e meravigliosamente intrigante (sublimi e indimenticabili i canti in gaelico). In parallelo, i gesti, le emozioni e le reazioni dei personaggi si dimostreranno intensi, forti, improvvisi, ma mai troppo eclatanti, permeati da una misurata freddezza propria degli abitanti delle isole del Nord.
Assistiamo quindi a una rivisitazione della selkie gentilmente ritoccata, senza alcuna intenzione di stravolgere le fondamenta di questo mito, ammantata di un velo di mistero - sia fisico che metaforico -, un velluto baltico pregno d’austero misticismo, ignara dello scorrere del tempo come ogni leggenda radicata, mitologicamente pertinente nel suo semplice occultismo fra fiaba e credenze tramandate di generazione in generazione.
Ne “La canzone del mare” si mischiano credenze popolari e racconti ispirati agli dei della Madre Terra secolare, un’eredità pagana attinta dalle creature del mare e della foresta, focalizzandosi sulla selkie, appunto, un folletto ittico che tutt’oggi popola la fantasia di Scozzesi, Irlandesi, Inglesi e Gallesi, senza escludere i popoli ancora più a Nord. Sono racconti fra il malinconico e il superstizioso, legati alle figure sacre di una religione celtico-sassone lontana un’era e più da quella mediterranea.
L’originalità di questa passa anche per l’assenza di vere e proprie controparti malvagie: chi sembra prendere i contorni di un probabile antagonista, più che cattivo si dimostra rassegnato al proprio destino e schiacciato da tristi eventi passati, in balia di forze ed eventi più potenti della propria volontà, ormai appassita e sconfitta.
Artisticamente anacronistico e per questo ancor più stuzzicante, curioso e calamitante, “La canzone del mare” s’è giocato l’Academy Award nel 2015, perdendo il confronto soltanto con il colosso disneyano “Big Hero 6”, anche se per molti avrebbe meritato la vittoria. La forza evocativa degli ambienti, in netta controcorrente rispetto all’imperante computer grafica che asfissia ogni genere di lavoro contemporaneo, si è dimostrata di una potenza emotiva come non si vedeva da tempo. Ed ecco quindi inquadrature a campo lungo, aperto, scenari più iconografici e di contorno che in cerca di un monotono realismo, veri e propri esercizi estetici capaci di suggerire la libertà d’azione dei giovanissimi protagonisti tramite un’occhiata immediata, prima ancora che gli spazi vengano riempiti dall’azione stessa.
Se è vero che la prima parte scorra pigra e poco incisiva, la seconda metà del film accelera di ritmo e interesse, strizzando l’occhio ai fratelli Grimm e ad Andersen, intrisa di leggende popolari che prendono finalmente vita e ci portano in un mondo fatato dalle sfumature tolkieniane di rara delicatezza; l’andamento non più claudicante ci prende per mano e ci guida verso un finale agrodolce, per nulla scontato e di grande impatto, ma nel contempo decisamente attuale.
La colonna sonora è un vero gioiello, e una doverosa menzione va senza dubbio a “Dùlamàn”, celebre canto popolare originariamente in gaelico: dall’equivoco testo metaforico che sembra parlare di alghe marine e delle profondità dell’oceano, in realtà cela una storia di gelosia, d’amore e di famiglie.
“Ricordami nelle tue storie e nelle tue canzoni”, sarà questo il concetto che ci rimarrà nella testa alla fine della visione, metodo antico e affascinante col quale si sono sempre tramandate la maggior parte delle leggende che tutt’oggi ci affascinano ed emozionano in maniera ipnotizzante e viscerale.
Il segreto per gustarsi questa piccola perla è di non concentrarsi sul ritmo di narrazione, bensì sulle emozioni che ci vengono centellinate di sequenza in sequenza, fino a un finale dove assaggerete felicità e tristezza, in un sol magico boccone.
Catartico, appagante, sincero. Una fiaba da ascoltare davanti a un camino in una fredda notte d’inverno, lasciando che il narratore sia nientemeno che il mare in burrasca.
Nelle isole scozzesi si credeva che le foche fossero esseri umani trasmutati, per questo si sospettava che ucciderle portasse sfortuna; le storie più diffuse ruotano intorno a personaggi selkie femminili a cui viene rubato il manto e si trovano quindi costrette a restare sulla terraferma. Il manto delle selkie infatti è l'elemento necessario perché possano trasformarsi nuovamente in animali e tornare in mare. Altre storie narrano di come dei personaggi umani non si accorgano di vivere con una selkie e si risveglino una mattina scoprendo che la loro partner... è sparita.”
Mitologia, tribalismo arcaico, pungente sapore di sale, vento gelido e fiabe ancestrali.
Saoirse è una bambina dolcissima, bella, vivace, imprevedibile e incredibilmente coraggiosa. E proprio oggi compie sei anni! Ma... ancora, strano a dirsi, non ha imparato a parlare. Vive con il padre, il fratello maggiore Ben e il cane Cù, un bestione allegro e giocherellone. Tutti insieme abitano sull’isolotto del faro di uno sperdutissimo paese dell’Irlanda del Nord.
In tale scenario freddo, apparentemente inospitale eppur intriso di una magia che lascia trasparire soltanto parte dell’imminente incanto, scopriremo che questa famiglia ha tragicamente smarrito la madre dei due bambini, una bellissima e rassicurante donna di nome Bronagh, proprio il giorno della nascita di Saoirse: una sparizione misteriosa che col tempo è divenuta, inevitabilmente, un lutto da elaborare e infine accettare, poiché di Bronagh non vi sono state più tracce.
Il prologo de “La canzone del mare” ci mostra - in maniera vaga e confusa - la silenziosa ma sofferta scomparsa della donna, evento che ha contribuito a inasprire il rapporto fra Ben e sua sorella minore, collegando in qualche modo quest’ultima alla mancanza dell’adorata madre. Di fronte a una situazione familiare di difficile gestione, comportamenti incoscienti da parte dei ragazzini e un padre intento ad affogare i ricordi legati alla moglie nei pub sulla costa, la nonna di Ben e Saoirse comprende che ormai è aria di cambiare, e decide prenderli e portarli con sé proprio in città, speranzosa che un drastico cambiamento possa promettere ai piccoli un futuro migliore.
Se agli occhi dei piccoli il cambio di dimora possa inizialmente apparire come un peggioramento del tenore di vita, presto si rivelerà un trampolino di lancio verso una realtà oscura, intrigante e incantata, sospesa a metà fra misticismo e tracce di antiche leggende.
Si tratta di un lungometraggio che ci regala atmosfere uniche, un libro di illustrazioni fra il naif e l’allegorico, una pellicola che snocciola immagini meravigliose, colori brillanti, accesi, ricchi di contrasti studiati e preziosi, e nonostante l’incipit si mostri piuttosto amaro e ci comunichi una situazione poco felice, il celtico connubio di suoni e immagini capace di evolversi minuto dopo minuto stupisce e affascina, ammaliando tramite scenari e melodie estremamente curate e coinvolgenti.
Le inflessioni e le venature di radice prettamente nordeuropea si insinuano ovunque, sin dalle prime battute. È un mondo ispirato a leggende norreno-anglosassoni dalle animazioni spigolose, minimali eppure esaustive, plasmanti un clima inflessibile, gelido, rassicurante e misteriosamente affascinante, con un certo retrogusto d’avventura infantile a cui non possiamo assolutamente sottrarci, poiché solletica i nostri ricordi più lontani, radicati nella nostra testa sin da quando eravamo bambini. Esso li stimola, li desta, e infine li riporta a galla in questo gelido mare familiare e spietato, permettendoci di rimembrare com’era sognare quando il mondo ci appariva più semplice e la fantasia si attestava a nostro impalpabile spirito guida.
Premettendo che anche il doppiaggio italiano risulti di grande qualità, lesti ci si ritrova in una fiaba moderna dai contorni antichi e malinconici, a tratti drammatici; un affresco dai fondali traboccanti di sentimenti che ritrae grandi paesaggi ove cieli sterminati si mangiano la scena, divorando spesso e volentieri i raggi del sole e trascinando lo spettatore nelle terre del Nord Europa, magistralmente trasfigurate attraverso impeccabili allegorie minimali. Apprezziamo così orizzonti nuvolosi ed evocativi, scogliere a picco, pioggia battente, contorni confusi e nebbiosi, spesso acquarellati, idratati da pigmenti che si mischiano su carta e danno vita a un rustico realismo virtualmente increspato, genesi d’atmosfere coinvolgenti, ma che non tentano di nascondere grandi, grigie e lugubri città dell’entroterra, dove Halloween è alle porte e la voglia di viaggiare con la fantasia diviene una necessità dell’anima.
Artisticamente parlando non esistono studi di prospettiva, né grandi virtuosismi di sorta. È un continuo sovrapporsi di ritagli d’immagini e colori, un decoupage di contrasti cromatici talvolta gentili, talvolta aspri e ad ogni modo funzionali alla trama; si ha la costante impressione di sfogliare, come già accennato, un libro illustrato dalle pagine cartonate e consumate, un tomo dall’odore di vecchio ma buono che ci trascinerà in un’avventura fuori dal tempo, arricchita da una colonna sonora elaborata, antica e dolce contemporaneamente, vertiginosa quanto basta per cullarci verso una cultura lontana, mistica, algida e meravigliosamente intrigante (sublimi e indimenticabili i canti in gaelico). In parallelo, i gesti, le emozioni e le reazioni dei personaggi si dimostreranno intensi, forti, improvvisi, ma mai troppo eclatanti, permeati da una misurata freddezza propria degli abitanti delle isole del Nord.
Assistiamo quindi a una rivisitazione della selkie gentilmente ritoccata, senza alcuna intenzione di stravolgere le fondamenta di questo mito, ammantata di un velo di mistero - sia fisico che metaforico -, un velluto baltico pregno d’austero misticismo, ignara dello scorrere del tempo come ogni leggenda radicata, mitologicamente pertinente nel suo semplice occultismo fra fiaba e credenze tramandate di generazione in generazione.
Ne “La canzone del mare” si mischiano credenze popolari e racconti ispirati agli dei della Madre Terra secolare, un’eredità pagana attinta dalle creature del mare e della foresta, focalizzandosi sulla selkie, appunto, un folletto ittico che tutt’oggi popola la fantasia di Scozzesi, Irlandesi, Inglesi e Gallesi, senza escludere i popoli ancora più a Nord. Sono racconti fra il malinconico e il superstizioso, legati alle figure sacre di una religione celtico-sassone lontana un’era e più da quella mediterranea.
L’originalità di questa passa anche per l’assenza di vere e proprie controparti malvagie: chi sembra prendere i contorni di un probabile antagonista, più che cattivo si dimostra rassegnato al proprio destino e schiacciato da tristi eventi passati, in balia di forze ed eventi più potenti della propria volontà, ormai appassita e sconfitta.
Artisticamente anacronistico e per questo ancor più stuzzicante, curioso e calamitante, “La canzone del mare” s’è giocato l’Academy Award nel 2015, perdendo il confronto soltanto con il colosso disneyano “Big Hero 6”, anche se per molti avrebbe meritato la vittoria. La forza evocativa degli ambienti, in netta controcorrente rispetto all’imperante computer grafica che asfissia ogni genere di lavoro contemporaneo, si è dimostrata di una potenza emotiva come non si vedeva da tempo. Ed ecco quindi inquadrature a campo lungo, aperto, scenari più iconografici e di contorno che in cerca di un monotono realismo, veri e propri esercizi estetici capaci di suggerire la libertà d’azione dei giovanissimi protagonisti tramite un’occhiata immediata, prima ancora che gli spazi vengano riempiti dall’azione stessa.
Se è vero che la prima parte scorra pigra e poco incisiva, la seconda metà del film accelera di ritmo e interesse, strizzando l’occhio ai fratelli Grimm e ad Andersen, intrisa di leggende popolari che prendono finalmente vita e ci portano in un mondo fatato dalle sfumature tolkieniane di rara delicatezza; l’andamento non più claudicante ci prende per mano e ci guida verso un finale agrodolce, per nulla scontato e di grande impatto, ma nel contempo decisamente attuale.
La colonna sonora è un vero gioiello, e una doverosa menzione va senza dubbio a “Dùlamàn”, celebre canto popolare originariamente in gaelico: dall’equivoco testo metaforico che sembra parlare di alghe marine e delle profondità dell’oceano, in realtà cela una storia di gelosia, d’amore e di famiglie.
“Ricordami nelle tue storie e nelle tue canzoni”, sarà questo il concetto che ci rimarrà nella testa alla fine della visione, metodo antico e affascinante col quale si sono sempre tramandate la maggior parte delle leggende che tutt’oggi ci affascinano ed emozionano in maniera ipnotizzante e viscerale.
Il segreto per gustarsi questa piccola perla è di non concentrarsi sul ritmo di narrazione, bensì sulle emozioni che ci vengono centellinate di sequenza in sequenza, fino a un finale dove assaggerete felicità e tristezza, in un sol magico boccone.
Catartico, appagante, sincero. Una fiaba da ascoltare davanti a un camino in una fredda notte d’inverno, lasciando che il narratore sia nientemeno che il mare in burrasca.
«L’idea della storia sul “prendere in prestito” è intrigante e perfettamente attuale. L’era del consumo di massa sta per concludersi, perché viviamo in una brutta crisi economica e la possibilità di “prendere in prestito” invece che comprare ciò che ci serve indica la direzione verso cui il mondo si sta avviando».
Circa quarant’anni fa Miyazaki e Takahata scrissero l’adattamento di “The Borrowers”, un film del 1997 diretto da Peter Hewitt e tratto dagli omonimi racconti per ragazzi di Mary Norton. Il progetto ideato dai due fondatori dello Studio Ghibli, però, finì ben presto nel dimenticatoio, fino a quando il sensei Miyazaki decise di riprenderlo finalmente in mano nel 2008, quasi trent’anni dopo, per farci un film d’animazione e, probabilmente, tenere cara la memoria degli anni giovanili trascorsi con il suo amico e collega Takahata. Il produttore del lungometraggio sarebbe stato Toshio Suzuki, terzo dei tre fondatori dello Studio Ghibli, ma le cose, almeno nei primi tempi, non filarono lisce. All’epoca, Suzuki aveva in mente un film diverso da quello che si immaginava il sensei e, per questo, le discussioni si protrassero a lungo. Alla fine, come potete ben immaginare, fu Miyazaki ad avere l’ultima parola. Il film si sarebbe fatto e come lo voleva lui. Pertanto, consigliò a Suzuki di leggere i racconti di Mary Norton, in modo da fissare bene quelli che sarebbero stati i punti focali del film. Terminata la lettura, Suzuki fece una domanda molto precisa a Miyazaki: «Ma perché “The Borrowers” proprio ora?». Il sensei rispose come sopra riportato, anticipando, di ben quindici anni, la deriva verso cui il mondo consumistico-capitalistico si sarebbe e si è ormai inesorabilmente avviato.
Sotto il pavimento di una grande casa situata in un magico e rigoglioso giardino alla periferia di Tokyo, vive Arrietty, una minuscola ragazza di quattordici anni, con i suoi altrettanto minuscoli genitori. La casa è abitata da due vecchiette, che naturalmente ignorano la presenza di questa famiglia in miniatura. Tutto ciò che Arrietty e la sua famiglia possiedono lo “prendono in prestito”: strumenti essenziali come la cucina a gas, l’acqua e il cibo; e ancora tavoli, sedie, utensili, o prelibatezze come le zollette di zucchero. Tutto viene preso in piccolissime quantità, così che le padrone di casa non se ne accorgano. Un giorno Sho, un ragazzo di dodici anni che deve sottoporsi a urgenti cure mediche in città, si trasferisce nella casa delle vecchiette. I genitori di Arrietty le hanno sempre raccomandato di non farsi vedere dagli umani, poiché, una volta visti, i piccoli abitanti devono lasciare il luogo in cui sono stati scoperti e cercarsi una nuova dimora. L’avventurosa ragazzina, però, non li ascolta, e Sho si accorge della sua presenza. I due ragazzi iniziano a confidarsi l’uno con l’altra e, seppur nella diversità, nasce un’amicizia destinata a rimanere impressa a fondo nei cuori dei due giovani.
Potrà suonare strano all’orecchio di molti, ma ritengo che “Arrietty” sia, concettualmente parlando, uno dei migliori Ghibli in assoluto. Probabilmente sarò strano io, ma nella mia vita non avevo mai visto un film del genere, che parlasse di uomini in miniatura, abitanti di un mondo segreto, collocato esattamente sotto il pavimento che calpestiamo quotidianamente. Il mio cervello non aveva mai neanche lontanamente fantasticato una cosa del genere, e questo deve aver sicuramente generato in me un effetto sorpresa maggiore del previsto. Non che io mi ritenga un genio, sia chiaro, ma sono sempre stato un ragazzo a cui piace volare con la fantasia e di storielle strane nella mia mente ne ho inventate parecchie, ma come questa mai. Come in diverse delle sue pellicole precedenti, dunque, Miyazaki riesce a stupire facendo leva sulla componente fantasy, grande leitmotiv dei lungometraggi Ghibli. Eppure, come spesso accade, il fantastico è un mero espediente, usato dal sensei, per raccontare qualcosa di più, una storia più profonda. Nei due diversi modi, quello di Sho e quello della vecchia Haru, una delle signore che abitano la casa immersa nel verde, di interfacciarsi con i prendimprestito, si legge l’intrigante e ambigua storia della società moderna. Sho e Haru sono due facce della stessa medaglia, così vicine fra di loro, eppure così incredibilmente distanti. La vecchia Haru è diffidente nei confronti di quelli che lei chiama gnomi e, infatti, alla prima opportunità, ne cattura uno, come se fosse un qualsivoglia cimelio di guerra. Nell’immediato, il suo volto crudele sembra trasmettere odio, quando, invece, si tratta di semplice paura mista a ignoranza, nel senso, per dirla alla Aldo, Giovanni e Giacomo, che ignora chi siano e cosa facciano questi uomini in miniatura. Dunque, davanti al diverso, agisce come molti di noi farebbero, e anzi fanno, mettendosi sulla difensiva, come se una guerra fosse pronta a divampare da un momento all’altro. Il giovane Sho, invece, appare più coscienzioso e, come tutti i ragazzi della sua età, curioso. È la curiosità a spingerlo verso nuovi orizzonti e a voler sapere di più su coloro che abitano il mondo segreto sotto il pavimento. Nella sua genuinità fanciullesca, Sho si dimostra aperto verso questa specie che non conosce e finisce per fare amicizia con una di loro, la bella Arrietty. Seppur nella diversità, nasce un’amicizia inaspettata per entrambi, destinata a infrangersi con la lontananza, ma di cui i due giovani porteranno sempre un vivido ricordo nel loro cuore. È vedendo film del genere, quindi, quasi tutti quelli di Miyazaki, che penso a quanto il mondo sia sbagliato e quanto poco basterebbe per cambiarlo. E non mi riferisco a grandi gesta o azioni plateali, quelle le lascio volentieri ai supereroi. Nella quotidianità, mi accontento di regalare un sorriso a uno sconosciuto o, più semplicemente, offrire in prestito una zolletta di zucchero a chi ne ha maggiormente bisogno.
Tecnicamente impeccabile, come tutti gli altri film targati Studio Ghibli. Animazioni stupende e cura maniacale per ogni dettaglio, anche la più piccola goccia di rugiada, sulla più alta e lontana foglia, di un minuscolo albero sullo sfondo. Perché sì, i dettagli fanno la differenza, eccome se la fanno. Alla regia, Hiromasa Yonebayashi, che, a mio parere, si sarebbe distinto maggiormente con il successivo “Quando c’era Marnie”. Alle musiche, la voce vellutata di Cecile Corbel, che ha impreziosito la versione nostrana del film, cantando in italiano la colonna sonora del film, “Arrietty’s Song”.
In conclusione, “Arrietty - Il mondo segreto sotto il pavimento” è un film breve per gli standard dello Studio Ghibli e, probabilmente, anzi sicuramente, di minor impatto emotivo. Nonostante ciò, offre interessanti spunti di riflessione e intrattiene più che egregiamente. Consigliato.
Circa quarant’anni fa Miyazaki e Takahata scrissero l’adattamento di “The Borrowers”, un film del 1997 diretto da Peter Hewitt e tratto dagli omonimi racconti per ragazzi di Mary Norton. Il progetto ideato dai due fondatori dello Studio Ghibli, però, finì ben presto nel dimenticatoio, fino a quando il sensei Miyazaki decise di riprenderlo finalmente in mano nel 2008, quasi trent’anni dopo, per farci un film d’animazione e, probabilmente, tenere cara la memoria degli anni giovanili trascorsi con il suo amico e collega Takahata. Il produttore del lungometraggio sarebbe stato Toshio Suzuki, terzo dei tre fondatori dello Studio Ghibli, ma le cose, almeno nei primi tempi, non filarono lisce. All’epoca, Suzuki aveva in mente un film diverso da quello che si immaginava il sensei e, per questo, le discussioni si protrassero a lungo. Alla fine, come potete ben immaginare, fu Miyazaki ad avere l’ultima parola. Il film si sarebbe fatto e come lo voleva lui. Pertanto, consigliò a Suzuki di leggere i racconti di Mary Norton, in modo da fissare bene quelli che sarebbero stati i punti focali del film. Terminata la lettura, Suzuki fece una domanda molto precisa a Miyazaki: «Ma perché “The Borrowers” proprio ora?». Il sensei rispose come sopra riportato, anticipando, di ben quindici anni, la deriva verso cui il mondo consumistico-capitalistico si sarebbe e si è ormai inesorabilmente avviato.
Sotto il pavimento di una grande casa situata in un magico e rigoglioso giardino alla periferia di Tokyo, vive Arrietty, una minuscola ragazza di quattordici anni, con i suoi altrettanto minuscoli genitori. La casa è abitata da due vecchiette, che naturalmente ignorano la presenza di questa famiglia in miniatura. Tutto ciò che Arrietty e la sua famiglia possiedono lo “prendono in prestito”: strumenti essenziali come la cucina a gas, l’acqua e il cibo; e ancora tavoli, sedie, utensili, o prelibatezze come le zollette di zucchero. Tutto viene preso in piccolissime quantità, così che le padrone di casa non se ne accorgano. Un giorno Sho, un ragazzo di dodici anni che deve sottoporsi a urgenti cure mediche in città, si trasferisce nella casa delle vecchiette. I genitori di Arrietty le hanno sempre raccomandato di non farsi vedere dagli umani, poiché, una volta visti, i piccoli abitanti devono lasciare il luogo in cui sono stati scoperti e cercarsi una nuova dimora. L’avventurosa ragazzina, però, non li ascolta, e Sho si accorge della sua presenza. I due ragazzi iniziano a confidarsi l’uno con l’altra e, seppur nella diversità, nasce un’amicizia destinata a rimanere impressa a fondo nei cuori dei due giovani.
Potrà suonare strano all’orecchio di molti, ma ritengo che “Arrietty” sia, concettualmente parlando, uno dei migliori Ghibli in assoluto. Probabilmente sarò strano io, ma nella mia vita non avevo mai visto un film del genere, che parlasse di uomini in miniatura, abitanti di un mondo segreto, collocato esattamente sotto il pavimento che calpestiamo quotidianamente. Il mio cervello non aveva mai neanche lontanamente fantasticato una cosa del genere, e questo deve aver sicuramente generato in me un effetto sorpresa maggiore del previsto. Non che io mi ritenga un genio, sia chiaro, ma sono sempre stato un ragazzo a cui piace volare con la fantasia e di storielle strane nella mia mente ne ho inventate parecchie, ma come questa mai. Come in diverse delle sue pellicole precedenti, dunque, Miyazaki riesce a stupire facendo leva sulla componente fantasy, grande leitmotiv dei lungometraggi Ghibli. Eppure, come spesso accade, il fantastico è un mero espediente, usato dal sensei, per raccontare qualcosa di più, una storia più profonda. Nei due diversi modi, quello di Sho e quello della vecchia Haru, una delle signore che abitano la casa immersa nel verde, di interfacciarsi con i prendimprestito, si legge l’intrigante e ambigua storia della società moderna. Sho e Haru sono due facce della stessa medaglia, così vicine fra di loro, eppure così incredibilmente distanti. La vecchia Haru è diffidente nei confronti di quelli che lei chiama gnomi e, infatti, alla prima opportunità, ne cattura uno, come se fosse un qualsivoglia cimelio di guerra. Nell’immediato, il suo volto crudele sembra trasmettere odio, quando, invece, si tratta di semplice paura mista a ignoranza, nel senso, per dirla alla Aldo, Giovanni e Giacomo, che ignora chi siano e cosa facciano questi uomini in miniatura. Dunque, davanti al diverso, agisce come molti di noi farebbero, e anzi fanno, mettendosi sulla difensiva, come se una guerra fosse pronta a divampare da un momento all’altro. Il giovane Sho, invece, appare più coscienzioso e, come tutti i ragazzi della sua età, curioso. È la curiosità a spingerlo verso nuovi orizzonti e a voler sapere di più su coloro che abitano il mondo segreto sotto il pavimento. Nella sua genuinità fanciullesca, Sho si dimostra aperto verso questa specie che non conosce e finisce per fare amicizia con una di loro, la bella Arrietty. Seppur nella diversità, nasce un’amicizia inaspettata per entrambi, destinata a infrangersi con la lontananza, ma di cui i due giovani porteranno sempre un vivido ricordo nel loro cuore. È vedendo film del genere, quindi, quasi tutti quelli di Miyazaki, che penso a quanto il mondo sia sbagliato e quanto poco basterebbe per cambiarlo. E non mi riferisco a grandi gesta o azioni plateali, quelle le lascio volentieri ai supereroi. Nella quotidianità, mi accontento di regalare un sorriso a uno sconosciuto o, più semplicemente, offrire in prestito una zolletta di zucchero a chi ne ha maggiormente bisogno.
Tecnicamente impeccabile, come tutti gli altri film targati Studio Ghibli. Animazioni stupende e cura maniacale per ogni dettaglio, anche la più piccola goccia di rugiada, sulla più alta e lontana foglia, di un minuscolo albero sullo sfondo. Perché sì, i dettagli fanno la differenza, eccome se la fanno. Alla regia, Hiromasa Yonebayashi, che, a mio parere, si sarebbe distinto maggiormente con il successivo “Quando c’era Marnie”. Alle musiche, la voce vellutata di Cecile Corbel, che ha impreziosito la versione nostrana del film, cantando in italiano la colonna sonora del film, “Arrietty’s Song”.
In conclusione, “Arrietty - Il mondo segreto sotto il pavimento” è un film breve per gli standard dello Studio Ghibli e, probabilmente, anzi sicuramente, di minor impatto emotivo. Nonostante ciò, offre interessanti spunti di riflessione e intrattiene più che egregiamente. Consigliato.
Recensione di AnthonyAyanokoji
-
Il body shaming rappresenta un tabù ancora da sfatare, un tema molto complesso che va inquadrato all'interno di una società basata sulle apparenze e di tendenza espressamente narcisista. E quale modo migliore per affrontare l'argomento se non attraverso un crossover di alcune delle fiabe più famose e conosciute al mondo? In effetti, tralasciando il lapalissiano riferimento a "Biancaneve e i sette nani", vengono citate indirettamente anche altre due fiabe: "Scarpette rosse" e "La bella e la bestia", in particolare la seconda, per il concept iniziale e conclusivo della narrazione.
La protagonista, Biancaneve, viene concettualizzata nell'aspetto esteriore, in maniera completamente diversa rispetto all'idea originale dei Fratelli Grimm o alla più tardiva versione della Disney, nelle quali viene descritta come una bellissima principessa, la più bella di tutto il reame. Corpulenta, insicura e goffa, sono queste le tre principali caratteristiche che denotano e definiscono la Biancaneve ideata dal regista coreano Sung-ho Hong, la quale riesce ad acquisire una bellezza fuori dal comune solo attraverso l'utilizzo di un paio di magiche scarpette rosse. Un destino molto simile tocca ai Favolosi Sette, ovvero sette avvenenti principi dai poteri straordinari i quali, per analogia del contrappasso, vengono trasformati in sette mostruosi nani e condannati a rimanere in tale condizione finché non riceveranno il bacio della donna più bella del mondo. La maledizione inflitta ai principi è dovuta sia all'assenza di maturità che ad una chiara superficialità da parte loro nel giudicare esclusivamente dall'aspetto esteriore, in quanto, nell'immaginario comune, è lecito aspettarsi che difficilmente una principessa possa essere contemplabile come brutta, oppure una figura bella e armonica essere associata a canoni negativi.
Per metterla in altri termini, gli individui spesso manifestano degli archetipi erronei e fittizi che non esistono nella realtà: associare il bello al bene, alla positività, e il brutto al male o alla negatività.
L'incarnazione per eccellenza del concetto di vanità è appurabile nel personaggio di Merlino, il quale durante quasi tutto il corso del film non sembra cogliere minimamente il reale significato della maledizione inflitta dalla Principessa delle Fate. Mentre l'interesse graduale manifestato da Biancaneve è sincero e puro, quindi rivolto alla sua versione temporanea, non quella ideale e meravigliosa da principe, l'attrazione di Merlino, invece, è dovuta inequivocabilmente alla sua bellezza esteriore. Tale aspetto viene ancora più sottolineato dal fatto che il principe rassicura Biancaneve che quelle non sono le sue vere sembianze, schernendo e ironizzando molteplici volte sulle stesse. Dunque, verrebbe da chiedersi: per quale motivo la principessa si è innamorata di Merlino? E pensare che, per esaltare le sue caratteristiche psicologiche, tutti gli altri principi sono stati messi sostanzialmente in ombra: Jack, cultore del bello e dei gioielli, Hans, immerso nella cucina, per non parlare del trio Pino, Noki e Kio, i quali sembrano proprio estranei alla narrazione, vivendo nel loro mondo di creatività e invenzione. Per Arthur, invece, il discorso è leggermente diverso, in quanto, insieme a Merlino, è il personaggio a cui viene dato più spazio e opportunità di interagire con Scarpette Rosse. Tuttavia il suo ruolo è quello dell'anti-eroe, a differenza del compagno: infatti, oltre all'egoismo, alla spavalderia e a mostrare i muscoli, il suo contributo è piuttosto marginale, e Biancaneve non se lo fila neanche di striscio. Geniale la sequenza con la spada nella roccia: "Altruista, cortese e veritiero devi essere, se la Spada Excalibur è nel tuo interesse", decisamente la persona ideale per estrarre la spada!
Il lavoro sul comparto grafico è stato davvero fantastico, solo per il character design di Scarpette Rosse varrebbe la pena guardare il film, una delle principesse più belle mai realizzate e disegnate nella storia dell'animazione. Purtroppo è d'obbligo aprire la vergognosa parentesi italiana sia sul doppiaggio che sulle OST: ma per quale motivo assegnare i ruoli dei protagonisti a Baby K, Pio e Amedeo? Ci sono tanti professionisti competenti del settore che studiano anni e anni per avere una parte, invece sono stati selezionati una cantante e due comici... che, tra l'altro, mentre con Baby K e Pio si può apprezzare un minimo di impegno, seppur la prestazione sia lo stesso inadeguata, Amedeo non è proprio all'altezza della situazione: fin dall'inizio è sembrato troppo meccanico e poco calato nella parte, per non parlare poi del fatto che gli sono stati assegnati addirittura due ruoli, non solo Arthur, ma anche quello dello Specchio Magico. Il doppiaggio dei personaggi secondari è nettamente superiore, guarda caso il resto del cast è composto da tutti doppiatori professionisti.
Anche le OST sono belle e orecchiabili, le canzoni "Something so Beautiful", "This Is Me" e "Start of Something Right" appartengono alla compagnia musicale The Math Club, mentre le tracce strumentali sono state composte da Geoff Zanelli. Ovviamente in italiano sono stati tradotti e adattati solo gli spezzoni musicali presenti nel film, non è stata rilasciata alcuna versione ufficiale delle varie canzoni. È possibile trovare su YouTube solo una cover di "Start of Something Right" di Thymeka.
"Red Shoes and the Seven Dwarfs" è un prodotto con l'obiettivo di lanciare un preciso messaggio al suo pubblico: non bisogna soffermarsi sulle mere apparenze, gli individui vanno compresi fino a fondo, prima di esprimere una qualsiasi forma di giudizio. Purtroppo nella società contemporanea si attribuisce eccessiva importanza a elementi come l'aspetto fisico, i lineamenti, l'estetica, così tanta rilevanza da spingere molteplici volte le persone ad attuare dei cambiamenti forzati o ad atti più estremi pur di piacere agli altri. Diventa fondamentale valorizzare sé stessi, in qualsiasi frangente, far emergere il proprio carattere, il carisma, la sicurezza o, per essere ancora più specifici, quella che viene definita la "bellezza interiore", poiché anche quest'ultima potrebbe rappresentare uno strumento valido per conquistare una persona che ai nostri occhi sembra irraggiungibile. In fondo, ogni individuo può identificarsi nella dicotomia Scarpette Rosse/Biancaneve, ma spetta sempre a noi decidere quale delle due versioni essere, senza avere rimpianti o essere giudicati per le proprie decisioni. Sebbene il film d'animazione abbia tale intento, ha ricevuto pesanti accuse di body shaming dalla community, a tal punto da spingere la doppiatrice originale di Biancaneve, Chloe Grace Moretz, a scusarsi per il contenuto del primo trailer del film diffuso in rete. A ciò, va aggiunta un'errata commercializzazione del prodotto che l'ha relegato subito al dimenticatoio: con tutta onestà, sono venuto a conoscenza della sua esistenza praticamente per caso. È davvero un peccato, perché l'idea di fondo dell'autore è interessante, anche le scene comedy, nonostante siano molto, ma molto banali e demenziali, non stonano troppo con tutto il resto. L'unico dubbio resta sul cambiamento di visione da parte di Merlino nell'ultimo quarto di film, che sa molto di forzatura rispetto a quanto visto in precedenza; per questo motivo concludo la recensione con una domanda per il lettore: "Un'evoluzione psicologica simile può davvero avvenire in così poco tempo e richiedere solo una breve riflessione su sé stessi?"
La protagonista, Biancaneve, viene concettualizzata nell'aspetto esteriore, in maniera completamente diversa rispetto all'idea originale dei Fratelli Grimm o alla più tardiva versione della Disney, nelle quali viene descritta come una bellissima principessa, la più bella di tutto il reame. Corpulenta, insicura e goffa, sono queste le tre principali caratteristiche che denotano e definiscono la Biancaneve ideata dal regista coreano Sung-ho Hong, la quale riesce ad acquisire una bellezza fuori dal comune solo attraverso l'utilizzo di un paio di magiche scarpette rosse. Un destino molto simile tocca ai Favolosi Sette, ovvero sette avvenenti principi dai poteri straordinari i quali, per analogia del contrappasso, vengono trasformati in sette mostruosi nani e condannati a rimanere in tale condizione finché non riceveranno il bacio della donna più bella del mondo. La maledizione inflitta ai principi è dovuta sia all'assenza di maturità che ad una chiara superficialità da parte loro nel giudicare esclusivamente dall'aspetto esteriore, in quanto, nell'immaginario comune, è lecito aspettarsi che difficilmente una principessa possa essere contemplabile come brutta, oppure una figura bella e armonica essere associata a canoni negativi.
Per metterla in altri termini, gli individui spesso manifestano degli archetipi erronei e fittizi che non esistono nella realtà: associare il bello al bene, alla positività, e il brutto al male o alla negatività.
L'incarnazione per eccellenza del concetto di vanità è appurabile nel personaggio di Merlino, il quale durante quasi tutto il corso del film non sembra cogliere minimamente il reale significato della maledizione inflitta dalla Principessa delle Fate. Mentre l'interesse graduale manifestato da Biancaneve è sincero e puro, quindi rivolto alla sua versione temporanea, non quella ideale e meravigliosa da principe, l'attrazione di Merlino, invece, è dovuta inequivocabilmente alla sua bellezza esteriore. Tale aspetto viene ancora più sottolineato dal fatto che il principe rassicura Biancaneve che quelle non sono le sue vere sembianze, schernendo e ironizzando molteplici volte sulle stesse. Dunque, verrebbe da chiedersi: per quale motivo la principessa si è innamorata di Merlino? E pensare che, per esaltare le sue caratteristiche psicologiche, tutti gli altri principi sono stati messi sostanzialmente in ombra: Jack, cultore del bello e dei gioielli, Hans, immerso nella cucina, per non parlare del trio Pino, Noki e Kio, i quali sembrano proprio estranei alla narrazione, vivendo nel loro mondo di creatività e invenzione. Per Arthur, invece, il discorso è leggermente diverso, in quanto, insieme a Merlino, è il personaggio a cui viene dato più spazio e opportunità di interagire con Scarpette Rosse. Tuttavia il suo ruolo è quello dell'anti-eroe, a differenza del compagno: infatti, oltre all'egoismo, alla spavalderia e a mostrare i muscoli, il suo contributo è piuttosto marginale, e Biancaneve non se lo fila neanche di striscio. Geniale la sequenza con la spada nella roccia: "Altruista, cortese e veritiero devi essere, se la Spada Excalibur è nel tuo interesse", decisamente la persona ideale per estrarre la spada!
Il lavoro sul comparto grafico è stato davvero fantastico, solo per il character design di Scarpette Rosse varrebbe la pena guardare il film, una delle principesse più belle mai realizzate e disegnate nella storia dell'animazione. Purtroppo è d'obbligo aprire la vergognosa parentesi italiana sia sul doppiaggio che sulle OST: ma per quale motivo assegnare i ruoli dei protagonisti a Baby K, Pio e Amedeo? Ci sono tanti professionisti competenti del settore che studiano anni e anni per avere una parte, invece sono stati selezionati una cantante e due comici... che, tra l'altro, mentre con Baby K e Pio si può apprezzare un minimo di impegno, seppur la prestazione sia lo stesso inadeguata, Amedeo non è proprio all'altezza della situazione: fin dall'inizio è sembrato troppo meccanico e poco calato nella parte, per non parlare poi del fatto che gli sono stati assegnati addirittura due ruoli, non solo Arthur, ma anche quello dello Specchio Magico. Il doppiaggio dei personaggi secondari è nettamente superiore, guarda caso il resto del cast è composto da tutti doppiatori professionisti.
Anche le OST sono belle e orecchiabili, le canzoni "Something so Beautiful", "This Is Me" e "Start of Something Right" appartengono alla compagnia musicale The Math Club, mentre le tracce strumentali sono state composte da Geoff Zanelli. Ovviamente in italiano sono stati tradotti e adattati solo gli spezzoni musicali presenti nel film, non è stata rilasciata alcuna versione ufficiale delle varie canzoni. È possibile trovare su YouTube solo una cover di "Start of Something Right" di Thymeka.
"Red Shoes and the Seven Dwarfs" è un prodotto con l'obiettivo di lanciare un preciso messaggio al suo pubblico: non bisogna soffermarsi sulle mere apparenze, gli individui vanno compresi fino a fondo, prima di esprimere una qualsiasi forma di giudizio. Purtroppo nella società contemporanea si attribuisce eccessiva importanza a elementi come l'aspetto fisico, i lineamenti, l'estetica, così tanta rilevanza da spingere molteplici volte le persone ad attuare dei cambiamenti forzati o ad atti più estremi pur di piacere agli altri. Diventa fondamentale valorizzare sé stessi, in qualsiasi frangente, far emergere il proprio carattere, il carisma, la sicurezza o, per essere ancora più specifici, quella che viene definita la "bellezza interiore", poiché anche quest'ultima potrebbe rappresentare uno strumento valido per conquistare una persona che ai nostri occhi sembra irraggiungibile. In fondo, ogni individuo può identificarsi nella dicotomia Scarpette Rosse/Biancaneve, ma spetta sempre a noi decidere quale delle due versioni essere, senza avere rimpianti o essere giudicati per le proprie decisioni. Sebbene il film d'animazione abbia tale intento, ha ricevuto pesanti accuse di body shaming dalla community, a tal punto da spingere la doppiatrice originale di Biancaneve, Chloe Grace Moretz, a scusarsi per il contenuto del primo trailer del film diffuso in rete. A ciò, va aggiunta un'errata commercializzazione del prodotto che l'ha relegato subito al dimenticatoio: con tutta onestà, sono venuto a conoscenza della sua esistenza praticamente per caso. È davvero un peccato, perché l'idea di fondo dell'autore è interessante, anche le scene comedy, nonostante siano molto, ma molto banali e demenziali, non stonano troppo con tutto il resto. L'unico dubbio resta sul cambiamento di visione da parte di Merlino nell'ultimo quarto di film, che sa molto di forzatura rispetto a quanto visto in precedenza; per questo motivo concludo la recensione con una domanda per il lettore: "Un'evoluzione psicologica simile può davvero avvenire in così poco tempo e richiedere solo una breve riflessione su sé stessi?"
I collegamenti ad Amazon fanno parte di un programma di affiliazione: se effettui un acquisto o un ordine attraverso questi collegamenti, il nostro sito potrebbe ricevere una commissione.















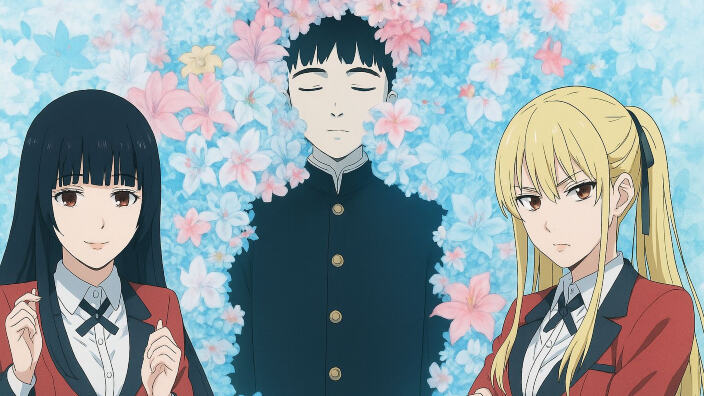







Personalmente gli do un 7 massimo 7.5
Anch'io gli do 7, l'ho visto questo mese dovendo recuperare molti film Ghibli prima di vedere l'ultimo ma non mi è piaciuto particolarmente
@felpato12ahhhh bellissimo arrietty
Grazie Mille
ps
buon anno a tutti!
Molto meglio di Marnie, sempre di Yonebayashi.
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.